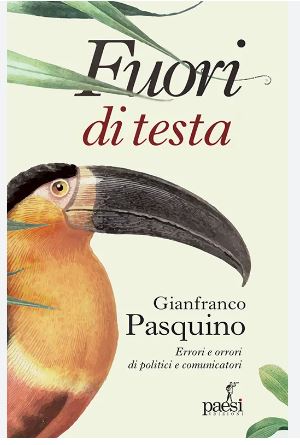Democrazie e crisi delle istituzioni #Intervista a Gianfranco Pasquino @RadioRadicale
ASCOLTA ► https://www.radioradicale.it/scheda/746133
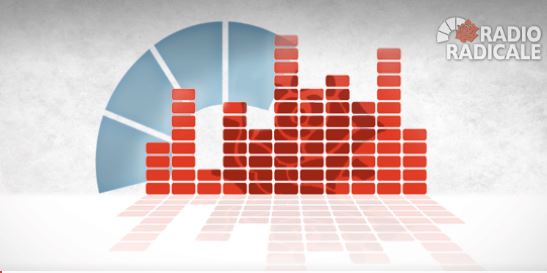
“Democrazie e crisi delle istituzioni. Intervista a Gianfranco Pasquino” realizzata da Antonello De Fortuna con Gianfranco Pasquino (professore emerito di Scienza Politica all’Alma Mater Studiorum di Bologna).
Gianfranco Pasquino parla della crisi delle istituzioni in Francia e dello stato di salute delle democrazie europee.
Nel corso dell’intervista Pasquino analizza anche il momento del Movimento Cinquestelle.
Nel corso dell’intervista sono stati trattati i seguenti temi: Astensionismo, Barnier, Cittadinanza, Consultazioni, Conte, Democrazia, Elezioni, Esteri, Francia, Governo, Grillo, Le Pen, Legge Elettorale, Macron, Movimento 5 Stelle, Partiti, Politica, Presidenza Della Repubblica, Presidenziale, Voto.
Con gli scioperanti, oltre lo sciopero #ParadoXaforum

Da troppo tempo alcuni leader sindacali valutano l’esito di uno sciopero con riferimento esclusivo al numero/alla percentuale dei partecipanti, degli scioperanti. Spesso, con qualsiasi governo, la Confindustria sembra preferire il silenzio, ne segue una guerra di cifre, più o meno affidabili che l’opinione pubblica non è mai in grado di valutare. Purtroppo, a quello che so, nessuno va a vedere e dice se l’obiettivo dello sciopero è stato effettivamente, in tutto o in quanta parte, conseguito. Si è impedita la chiusura di una fabbrica? è stato revocato il licenziamento di uno o più lavoratori? sono migliorate le condizioni e i tempi di lavoro? è ripartita la contrattazione sui salari? infine, con riferimento al più recente sciopero generale, saliranno adesso i salari italiani tristemente e pericolosamente collocati fra i più bassi degli Stati membri dell’Unione Europea?
La mia domanda di fondo è: “quando lo sciopero è il migliore e il più efficace strumento di lotta dei lavoratori?” Nessun retropensiero, ritengo che sia necessario cercare e trovare al più presto strumenti nuovi che i lavoratori dipendenti e i loro rappresentanti sindacali riescano ad usare flessibilmente con probabilità di maggior successo. Non intendo ledere nessuna suscettibile maestà di leader sindacali dallo stentoreo ego, subito difesi da qualche commentatrice che ha a cuore, “com’è buona lei!”, la causa di chi è condizioni di debolezza relativa e che neppure si interroga su eventuali alternative. Il conflitto è e rimane, come sanno soprattutto i liberali-liberali, la fonte principale dell’innovazione.
Il fatto che la CISL non abbia sentito il bisogno di partecipare a molti degli scioperi recenti, indetti congiuntamente da CGIL e UIL, compreso lo sciopero generale, non turba nessun sogno dei corifei di Landini&Co. Anzi, schierarsi con le posizioni e le esternazioni del segretario generale della CGIL viene considerato decisivo anche poiché è segno di opposizione (rivolta sociale, sic, contro) ad un governo in odore, e forse più, di fascismo.
Fermo restando che, personalmente, non ho neanche il minimo dubbio che tutti gli scioperi sono legittimi, semmai da criticare in casi di violenza e distruzioni, e che so che specialmente lo sciopero generale è politico nel senso migliore del termine contrapponendosi alla politica del governo, i miei due interrogativi di fondo rimangono: quando e come lo sciopero è ancora efficace e serve davvero a migliorare le condizioni dei lavoratori? oltre che auspicabile, non è anche venuto il tempo di procedere a trovare modalità alternative di lotta che, in aggiunta ad un maggior coinvolgimento dell’opinione pubblica, giovino al sistema economico e politico? Non sarebbe questo il ritorno del sindacato a svolgere quella funzione nazionale tenacemente argomentata dai dirigenti sindacali italiani negli anni cinquanta e seguenti e allora svolta con notevole successo?
Pubblicato il 5 dicembre 2024 su PARADOXAforum
Su Stellantis hanno tutti torto. La crisi si supera solo in Europa @DomaniGiornale

Il caso è Stellantis oppure è Carlos Tavares? Sicuramente, per il suo ruolo di capo e per la sua ingente liquidazione (100 milioni di Euro paiono spropositati a prescindere e già sono un problema in sé), Tavares merita il massimo dell’attenzione e della riprovazione. Ma non unicamente. Le difficoltà di Stellantis sotto la costosa gestione di Tavares derivano da scelte sbagliate sulle quali, a cominciare dai proprietari e quindi da John Elkann e dagli azionisti, pochi, forse nessuno, hanno sostanzialmente, tempestivamente fatto obiezione. Stabilire una graduatoria dei “disattenti” e degli opportunisti e quindi anche degli (ir)responsabili è utile poiché può servire a mettere in guardia per il futuro. Anche se vistisi sempre negare da Tavares il ruolo di interlocutori, i sindacati dovrebbero comunque interrogarsi se e come, oltre alla legittima difesa dei livelli occupazionali, non sarebbe opportuno da parte loro esercitarsi anche in approfondimenti concernenti la produzione, tipo e quantità, e l’immissione di quali modelli automobilistici sul mercato.
Mi pare sia giusto chiamare a rispondere del loro (in)operato anche i ministri che si occupano di economia e di industria. Tuttora preda di qualche sudditanza psicologica e un tantino anche politica nei confronti di quella grande compagnia automobilistica? Per la Confindustria parla il devastante editoriale del “Sole 24 Ore”, forse, ma ascoltare le interpretazioni e le valutazioni del Presidente e dell’ufficio di presidenza potrebbe apportare altri elementi conoscitivi certamente utili. Meno, molto meno condivisibile, mi sembra la ricerca, come ha prontamente fatto Giorgia Meloni (metto convintamente Salvini in secondo piano) di un capro, caprone, espiatorio nelle politiche ecologiche e di transizione all’elettrico decise e perseguite dall’Unione Europea.
Buona parte degli analisti più preparati sostengono che le difficoltà di Stellantis dipendono dalle politiche volute e decise da Tavares in persona. Tuttavia, in qualsiasi modo si cercherà di uscire da una situazione difficilissima e pesantissima del settore automobilistico che coinvolge anche Volkswagen, all’Europa sarà necessario rivolgersi. In Europa bisognerà cercare la soluzione. Da un lato, non possiamo fare finta che la concorrenza cinese prima di, eventualmente, sconfiggerla sul terreno della qualità e dell’innovazione, bisogna arginarla. Sullo stesso terreno, è opportuno temere le politiche commerciali e di fissazione di dazi dell’Amministrazione Trump. Dall’altro, forse stiamo per mettere alla prova uno dei suggerimenti operativi del Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea. Grande magari non è sempre bello, ma può essere vitale. Quanto basterà procedere a qualche forma di coordinamento delle politiche nel settore dell’auto, tuttora e prevedibilmente nel futuro prossimo, molto importante per il lavoro, l’imponente indotto, la ricerca e l’innovazione con i suoi effetti spill over e quanto, invece, bisognerà avviarsi sulla strada delle concentrazioni per giungere a giganti industriali competitivi, ma inevitabilmente poi interessati ad una fetta di potere politico europeo?
Le soluzioni intermedie, che riguardino investimenti, occupazione, bilanci, debbono essere cercate non come (costosi) tamponi, ma come premesse di una strategia di lungo periodo da presentare e discutere con le autorità governative italiane e europee. Il caso Stellantis non è solo un test di come rispondere ad una grave emergenza. Può diventare e deve essere una opportunità di elaborazione e attuazione di politiche europee lungimiranti.
Pubblicaro il 4 dicembre 2024 su Domani
Sciopero, arma spuntata? #3dicembre ore 17.30 a @WarRoomCisnetto
Uno sciopero necessario, ma il sindacato deve combattere con modalità nuove @DomaniGiornale

Chiunque ritenga che è importante, doveroso, giusto migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori dipendenti è obbligato a chiedersi se lo sciopero e ancor più uno sciopero generale sia lo strumento più adeguato e efficace per conseguire l’obiettivo. CGIL e UIL hanno scelto come indicatore di successo l’alta adesione dei lavoratori, all’incirca il 70 per cento. Lamentando la non partecipazione allo sciopero della CISL, interpreto il dato come segno di una buona relazione identitaria fra i lavoratori e i due sindacati CGIL e UIL. Che sia stato anche conferito a Maurizio Landini il mandato di “rivoltare l’Italia come un calzino” mi pare più problematico sostenerlo. Se uno sciopero di questo genere venisse interpretato come la premessa, ancora nelle parole del segretario generale della CGIL, di una “rivolta sociale” di cui l’Italia avrebbe bisogno, sarei, certamente non da solo, molto preoccupato. Nessuna democrazia ha mai bisogno di una rivolta sociale, che è qualcosa da lasciare, forse auspicandola, ai regimi autoritari, ma con frasi come questa si alimentano illusioni che sfoceranno malamente in delusioni. Non è del tutto fuori luogo, in questi tempi di brutte guerre, ricordare con le parole di un grande sociologo, Alessandro Pizzorno, che negli anni settanta frange di terrorismo rosso furono espressione di un surplus di militanza anche sindacale.
Che lo sciopero è un diritto costituzionalmente previsto e garantito è persino fastidioso sentirlo ripetere da coloro che, poi, si affrettano ad aggiungere che deve svolgersi nel rispetto di alcuni criteri prestabiliti e soprattutto che va criticato quando è politico. In una (in)certa misura tutti gli scioperi, specialmente se generali, sono politici, vale a dire riguardano la polis, la comunità sociale e politica, e la coinvolgono. Infatti, quegli scioperi, come nel caso in discussione, sono indirizzati contro l’atto politico più importante di qualsiasi governo: la legge finanziaria che stabilisce l’assegnazione e la distribuzione delle risorse disponibili. Sbagliato, dunque, e irrilevante, criticare la politicità di uno sciopero generale. Più opportuno e molto più significativo metterne in evidenza la problematicità e le criticità.
Come molti sindacalisti sono da tempo acutamente consapevoli, lo sciopero generale è una ultima ratio. Dovrebbe essere attuato quasi esclusivamente quando tutte le altre modalità di azione e di intervento sono state esperite e sono state rigettate, per di più senza essere state prese in seria considerazione dal governo e dai suoi ministri e forse neppure dall’opposizione. Certo l’attuale governo non è propriamente amico dei sindacati e non particolarmente interessato ai lavoratori dipendenti. Molti sono i contratti di lavoro scaduti da tempo e non ancora rinnovati sui quali fare leva con la protesta e la proposta, dentro e fuori il parlamento. Quantomeno è ipotizzabile che i sindacati non abbiano saputo esercitare le pressioni più opportune sul ministro del lavoro mettendo in campo i loro rappresentanti e i loro consulenti. La pratica dell’obiettivo, vecchia, ma incisiva terminologia, è da riprendere in seria considerazione. Sicuramente, è meno luccicante dello sciopero, ma, altrettanto sicuramente, è più promettente. Consentirebbe di mettere in piena luce le inadempienze del governo, della Confindustria, dei datori di lavoro. Fornirebbe informazioni utili e abbondanti all’opinione pubblica. Potrebbe persino contribuire a reclutare nuovi iscritti che sentissero il sindacato più vicino ai loro interessi e alle loro necessità e condizioni di vita.
Opposizioni frammentate e, in verità, incapaci di andare oltre qualche proposta specifica, peraltro, assolutamente condivisibile, come il salario minimo, più fondi alla sanità e all’istruzione, non sanno offrire altro che una sponda acritica ai sindacati che, spesso, a loro volta, non sanno se e come interloquire con quelle opposizioni. Le opposizioni in Parlamento non sono certamente la cinghia di trasmissione di sindacati divisi anche sulle proposte. Ma qualche forma di interazione non occasionale e di coordinamento di proposte e di azioni è non solo auspicabile, ma fattibile purché perseguita nella chiarezza e con concretezza.
L’unica informazione vera che uno sciopero generale comunica al governo, alle opposizioni, all’opinione pubblica è, nel migliore dai casi, lo stato di insoddisfazione dei lavoratori che vi partecipano. Può essere un punto di partenza, e lo vedremo. Però, rimane legittimo e particolarmente opportuno chiedere ai sindacati e ai loro dirigenti, da un lato, di riflettere sull’utilità dello sciopero, dall’altro, di individuare modalità innovative più efficaci e feconde dello sciopero generale e anche degli scioperi settoriali. Fin d’ora.
Pubblicato il 2 dicembre 2024 su Domani
Il nuovo M5S serve se mobilita chi non vota più @DomaniGiornale

La trasformazione del Movimento 5 Stelle da, per l’appunto, movimento a partito, giunge forse in ritardo e suscita più interrogativi. Nato con un misto all’italiana di qualunquismo e antiparlamentarismo, non, dunque, né soltanto né specialmente, populismo, il Movimento suscitò la mobilitazione di molti attivisti e, soprattutto, elettori che, altrimenti, si sarebbero confinati per scelta e volontà nell’astensione. Sull’onda dell’antisistema, già contravvenendo al suo principio “no alleanze”, andò al governo. Privo di competenze, secondo principio “nessuno che avesse avuto cariche politiche”, il suo antiparlamentarismo, “aprire il parlamento come una scatoletta di tonno”, si tradusse nella tremenda semplificazione del taglio del numero dei parlamentari. Meglio sarebbe stato tentare qualche innovazione tecnologica alle modalità di svolgimento dei lavori parlamentari. A questi lavori sicuramente non giovò la rigida applicazione del limite di due mandati, misura che impedisce la formazione di una classe politica al prezzo di privarsi di esperienze e competenze e quindi anche di influenza.
L’onda di qualsiasi movimento può rimanere alta soltanto per un certo, mai molto lungo, periodo di tempo. L’effervescenza collettiva deve sfociare in qualcosa di più solido, altrimenti svanisce in un misto di delusione e risentimento. L’azione di governo (svolta) al governo servì a mantenere effervescenza e entusiasmo per un non troppo breve periodo. In assenza di qualche forma di istituzionalizzazione, alla quale le modalità di lavoro on-line non erano e non sono in grado di contribuire, il declino diventò, ed è stato, inevitabile.
La decisione di abolire il limite dei due mandati apre una delle strade che conducono alla trasformazione del movimento in partito: associazione di uomini e donne che presentano candidature, ottengono voti, vincono cariche. Le comunicazioni e le votazioni on-line sono di ostacolo alla formazione di un comunità che agisce sul territorio, che recluta, seleziona, promuove, rappresenta e governa, apprendendo la politica, acquisendo meriti, sperimentando alleanze. La collocazione progressista “indipendente” (ma chi si definirebbe “dipendente”, eterodiretto?) deve forse essere intesa come la delimitazione dell’area nella quale si cercheranno alleanze, ma il campo progressista in Italia è già piuttosto affollato e, almeno, in parte, piuttosto propenso al litigio come strumento di differenziazione.
Se progressista implica spingere avanti la società, la cultura, l’economia, la politica internazionale c’è tutta una elaborazione da fare, anche in competizione con gli altri progressisti, nessuno dei quali mi pare particolarmente attrezzato e avanzato, una volta segnati i punti di riferimento essenziali. Almeno al di là delle Alpi ce ne sono. Di nuovo, ripeto in attesa di smentite convincenti, gli scambi on line non agevolano ricerche e confronti assolutamente necessari.
L’aggiunta nel sistema politico italiano di un protagonista disponibile a interazioni anche tese e conflittuali nel largo ambito progressista può risultare molto positiva a due condizioni. La prima è che il Partito delle Cinque Stelle affini i suoi strumenti telematici per ampliare non soltanto le opportunità decisionali, ma soprattutto la conversazione democratica intesa a comprendere le preferenze e gli interessi dei cittadini. La seconda condizione è che la competizione inevitabile fra i progressisti non rimanga confinata nel ristretto ambito degli elettori già votanti. Recuperare, motivandoli, i milioni di elettori che dal 2013 al 2018 ritennero che il Movimento 5 Stelle offriva cambiamenti reali e profondi come nessun altro e dopo se ne allontanarono, costituisce un obiettivo sistemico in grado di dare slancio e forza al partito nascente. Con beneficio della politica italiana.
Pubblicato il 27 novembre 2024 su Domani
Andreatta: quel che ricordo e mi fa bene #Arel #rivista


Pubblicato nel fascicolo della rivista “AREL”, n, 2.3/2024, dedicato a Nino Andreatta, pp. 104-106
Andreatta: quel che ricordo e mi fa bene
“La politica economica dei dirigenti del Partito comunista è molto migliorata da quando si fanno consigliare dagli economisti borghesi miei allievi”. Ricordo sempre con un sorriso questa frase pronunciata con nonchalance da Andreatta un giorno dell’autunno 1984. Come talvolta capitava, all’arrivo del volo del mattino Bologna-Roma (la Freccia Rossa ancora non esisteva) con gentilezza, ma anche per avere compagnia e per curiosità (avere da noi notizie, impressioni, valutazioni), Andreatta dava un passaggio da Fiumicino al Senato a Filippo Cavazzuti, per l’appunto l’economista borghese suo allievo, e Gianfranco Pasquino, entrambi suoi colleghi di Facoltà a Scienze politiche di Bologna e senatori della Sinistra indipendente. In quanto presidente della Commissione Bilancio per i suoi spostamenti Andreatta poteva usufruire della macchina con autista. Si appallottolava di fianco all’autista e cominciava la conversazione. Era molto fortunato (sic): economia con Cavazzuti, istituzioni con me. Facevamo entrambi parte della Commissione bicamerale per le Riforme istituzionali (30 novembre 1983-1 febbraio 1985) nota come Commissione Bozzi dal nome del deputato liberale di lungo corso Aldo Bozzi. Andreatta frequentò spesso la Commissione le cui elaborazioni non furono affatto prive di interesse. Alla fine di quei lavori, purtroppo, anche per la dichiarata ostilità dei socialisti, a nulla interessati tranne al rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio (Bettino Craxi in carica da metà agosto 1983), nessuna delle relazioni, né quella di maggioranza né quelle di minoranza, una delle quali firmata da me e dal Senatore Eliseo Milani, Sinistra indipendente del Senato, venne, come sarebbe stato doveroso, mai discussa in aula. Probabilmente perché aveva apprezzato alcuni miei interventi, Andreatta mi chiese di curare un volume sulla politica istituzionale del partito comunista. Sorpreso, compiaciuto e onorato mi misi subito al lavoro. Anche grazie alla cura di Mariantonietta Colimberti, l’esito fu il volume Arel La lenta marcia nelle istituzioni: i passi del PCI, (Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 461), tutt’ora, ne sono convinto, utile da compulsare e leggere.
Avevo conosciuto Andreatta all’inizio degli anni settanta. Eravamo colleghi nella Facoltà di Scienze politiche di Bologna, a quei tempi luogo di eccellenza: Nicola Matteucci, Giuseppe Alberigo, Achille Ardigò, Roberto Ruffilli, Giorgio Basevi, naturalmente Filippo Cavazzuti, persino Romano Prodi. Entrambi eravamo assidui frequentatori dei Consigli di facoltà nei quali Andreatta primeggiava, ma non spadronegggiava, in maniera spesso imprevedibile. L’altro luogo di incontro, ugualmente se non più importante era l’Associazione di cultura e politica “il Mulino”. Ne ero stato cooptato giovanissimo nel 1970, prima di lui, e me ne vanto, adesso. Quasi ogni sabato facevamo un incontro mattutino, seguito da un pranzo, con una ventina di soci, i fondatori fra i quali ancora Matteucci, Luigi Pedrazzi e Federico Mancini, l’operatore editoriale indispensabile Giovanni Evangelisti, l’inesauribile produttore di idee Arturo Parisi, poi altri eminenti studiosi come Ezio Raimondi, Gerardo Santini, Gino Giugni, Pietro Scoppola. Frequenti e rumorose erano le incursioni di Andreatta. Ci occupavamo, lo scrivo proprio così, platealmente, di idee e, naturalmente, di libri pubblicati, letti, da proporre. La politica italiana stava sullo sfondo, ma qualche volta, meritava attenzione per le sue inadeguatezze, ritardi, stupidità. Ricordo un intervento di Andreatta sulla scuola, tema che interessava noi tutti, ma sul quale le differenze di opinione erano notevoli. L’opinione, senza dubbio autorevole, di Andreatta non era maggioritaria. Prendendone atto, lui ci spiazzò tutti “allora, scriverò un disegno di legge!”. Non trattenemmo qualche meritata risata. Quei sabati del Mulino, ho spesso pensato, furono luogo di cultura e di apprendimento comparabile ai mercoledì dell’Einaudi. Allora.
Di Andreatta ho molti ricordi personali belli. Per esempio, quando mi corteggiò lungamente, pure fortemente lusingato, seppi resistere, per mandarmi a insegnare Scienza politica nell’Università della Calabria che, insieme a Paolo Sylos-Labini, tentò di costruire come grande campus all’americana, fonte di sviluppo per il Mezzogiorno. Il ricordo più bello viene dal Senato. Come anche, forse persino di più, alla Camera dei deputati, catturare l’attenzione vera dei colleghi parlamentari è molto difficile. Discussione importante aula affollata, ma anche intenso e denso frusciare delle pagine dei quotidiani (la Rassegna stampa non arrivava sui cellulari). Quando il presidente di turno dava la parola al Sen. Andreatta, non importa quali quotidiani e quali articoli stessero leggendo i colleghi, si faceva immediato silenzio, l’indicatore più sicuro e possente del prestigio dell’oratore e dell’aspettativa che dicesse (diceva, eccome, s e le diceva) parole importanti, efficaci, spiazzanti. Dall’alto del mio banco ho ancora negli occhi e nelle orecchie, nella mente quel silenzio quanto mai raro e eloquente.
Diversamente eloquente era Andreatta quando raccontava ai soci del Mulino la sua idea di partito, radicato sul territorio, rappresentativo della società di cittadini laboriosi, presente nel discorso pubblico, un vero e proprio Volkspartei (che era la parola da lui usata). Della contendibilità della leadership non gliene importava proprio nulla, un fico secco, poiché quelle leadership non erano incollate alle poltrone, ma si curavano delle persone e sapevano quando andarsene, liberare il posto. Non era la politica come “servizio”. Erano convinzione e stile, visione. Quando gli feci notare che quella che descriveva era nel migliore dei casi la DC del Trentino e del suo amico Bruno Kessler e forse di pochi altri luoghi del paese e che anche il PCI in molte zone che mi vantavo di conoscere era allora un Volkspartei assentiva con rispetto per gli attivisti e gli elettori, meno per alcuni dei dirigenti. Soltanto un fortissimo senso del dovere, mi sono molto spesso ripetuto, può spiegare che Andreatta si trovasse in aula alla Camera dei deputati il 15 settembre 1999, dopo cena intorno alle 22 per ascoltare gli interventi in una discussione generale. Questo è un ricordo che mi opprime, una mancanza dolorosa. So che parleremmo dell’aggressione russa all’Ukraina, del terrorismo di Hamas, dell’Unione Europea, presente e futuro, del modo di governare. So anche che direbbe parole originali, non solo pour èpater i soci del Mulino, “ma, Nino, non ti sembra di esagerare” (voce di Pedrazzi e di Arrigo Levi). So che, accavallate scompostamente le gambe e mostrati i calzini spaiati, non intonati come colore ci/mi ascolterebbe con interesse abbozzando un sorriso ironico talvolta beffardo. Un altro mondo, altre persone.