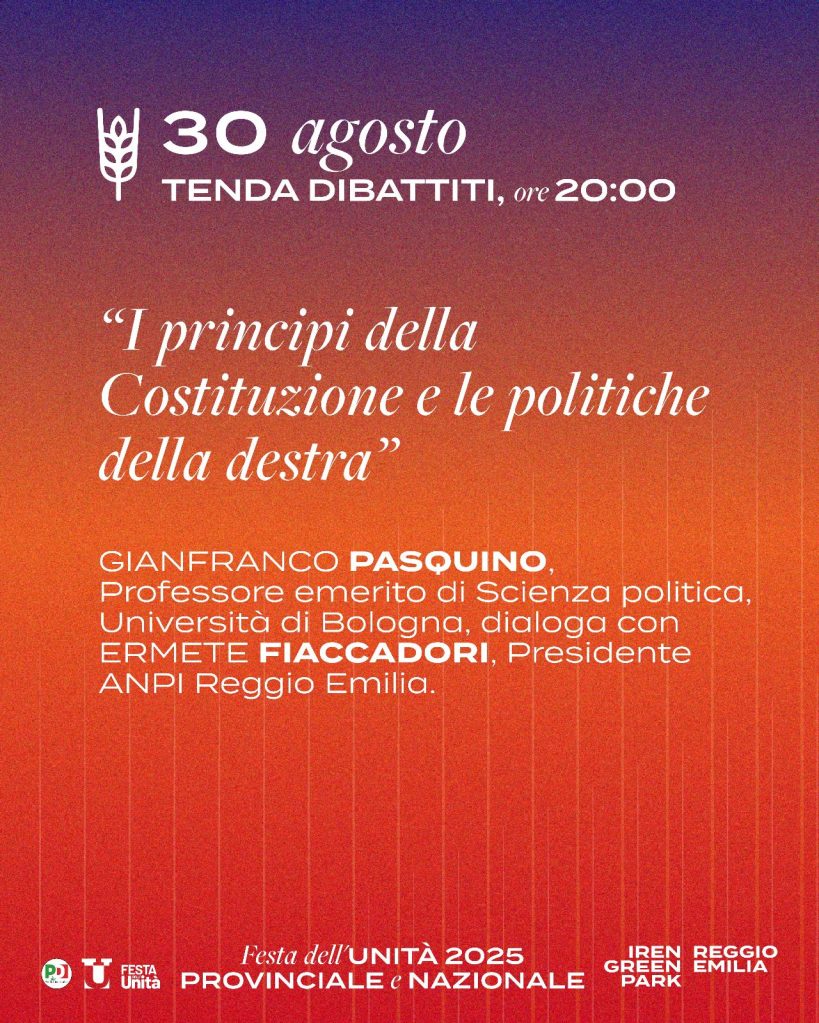Gaza è una tragedia dell’Umanità @DomaniGiornale

Gaza è una tragedia, non “umanitaria”, aggettivo tremendamente ambiguo in questa situazione, ma dell’umanità. Conseguenza anche, ma nient’affatto esclusiva e necessitata, dei crimini commessi da Hamas il 7 ottobre e che probabilmente Hamas avrebbe potuto evitare liberando senza condizioni gli ostaggi israeliani, Gaza sta affondano sotto il tiro incrociato di altri crimini, di gravissimi errori, di deprecabili ambizioni. La rappresaglia, secondo qualsiasi criterio davvero sproporzionata, scatenata dal Primo ministro Netanyahu lo ha giustamente reso un criminale di guerra. Finora la continuazione della rappresaglia contro Hamas e i palestinesi gli è anche servita, obiettivo da non dimenticare, a mantenere la carica e a procrastinare il processo per reati di corruzione.
L’opinione pubblica israeliana, inevitabilmente attraversata da molte linee di divisione, sembra dare priorità allo sforzo bellico. Una piccola parte protesta contro quella che è l’indifferenza del capo del governo alla sorte degli ostaggi ancora in vita. La destra, soprattutto quella religiosa, trae vantaggio dalla situazione che contempla il suo ruolo indispensabile per la continuazione del governo e ne approfitta per espandere gli insediamenti. Grande e fondato appare il timore che la democrazia in Israele venga imprigionata e sottomessa dai comportamenti di Netanyahu e dei suoi sostenitori.
Il riconoscimento, da parte di alcuni governi, non soltanto europei, di un improbabile Stato palestinese, risulta essere poco più che una mossa propagandistica più o meno apprezzabile e condivisibile, che purtroppo fa anche correre il rischio che si tralasci di pensare e di operare rapidamente per soluzioni più concrete e praticabili. La foto del segretario di Stato Marco Rubio a Gerusalemme con il Primo ministro israeliano proprio nelle ore in cui questi lanciava l’invasione di Gaza che dovrebbe essere l’operazione finale (non commento la terminologia e la sua macabra assonanza con “soluzione finale”) è certamente meno raccapricciante di quelle dei tre autocrati Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un a Shanghai alla ricerca di un diverso ordine internazionale, mai specialità dei dittatori. Però, segnala l’impotenza degli USA e la connivenza del loro Presidente con il governo israeliano.
L’affarista newyorkese insediatosi alla Casa Bianca, stende il tappeto rosso per il criminale di guerra Putin in cambio di nulla (certo non, visti gli esiti del pessimamente organizzato e deprecabile incontro bilaterale, l’agognato Premio Nobel), ma fa di peggio con Netanyahu. Smettesse di sostenerlo economicamente e soprattutto con abbondanti forniture di armi potrebbe cercare di avvicinare la fine del conflitto. Qualcuno dovrebbe far sapere a Trump l’immobiliarista che soltanto a conflitto concluso sarà possibile cominciare i lavori per costruire, incuranti degli ordigni bellici che saranno rimasti in grande quantità, luoghi di vacanze di superlusso. Quanto breve in questa visione malata è il passaggio di Gaza dalla tragedia alla farsa che, però, sarebbe riscattata dalle migliaia di posti di lavoro a disposizione dei palestinesi locali. Questo è, finora non sono arrivate smentite e neppure indicazioni alternative, il livello di raffinatezza del pensiero geopolitico elaborato a Washington.
Immagino che sul continente europeo molti, come me continuino a sentire acutamente un profondo senso di colpa per i comportamenti dei loro governanti e dei loro connazionali ai tempi dell’Olocausto. Nessuno creda che la tragedia di Gaza offra l’opportunità di liberarsi di sensi di colpa. Anzi, dovremmo tutti interrogarci sulle ragioni della nostra inadeguatezza di pensiero e di azione. Giusto armare l’Unione Europea per dissuadere gli attacchi dal fronte orientale e difendersi adeguatamente, In qualche modo, però, interrogandosi sugli errori commessi in Medio Oriente l’Unione Europea deve provvedere anche a elaborare una strategia ad ampio raggio per il perseguimento di paci giuste fuori del suo continente, a cominciare da quel che resterà di Gaza.
Pubblicato il 17 settembre 2025 su Domani
INVITO In nome del popolo sovrano Potere e ambiguità delle riforme in democrazia @egeaonline #17settembre #Sarzana
Mercoledì 17 settembre alle ore 17,30
Sala della Repubblica in Via Falcinello, 1
Sarzana
Conferenza del prof. Gianfranco Pasquino in occasione della presentazione del libro
In nome del popolo sovrano Potere e ambiguità delle riforme in democrazia
(Ed. Egea)
Fare riforme istituzionali è un compito importante. Può migliorare la vita del popolo sovrano. Analizzando quanto fatto e non fatto, Gianfranco Pasquino giunge a una limpida e documentata valutazione: finora gli improvvisati e imperterriti riformatori italiani non hanno dato buona prova. E con il cosiddetto premierato, ovvero l’elezione popolare del presidente del Consiglio, stanno facendo persino peggio. La Costituzione ha disegnato una democrazia parlamentare fondata sui partiti che ha accompagnato la crescita politica ed economica dell’Italia. Il Presidente della Repubblica ha saputo «suonare» al meglio la fisarmonica dei suoi poteri, ma Parlamenti e governi hanno funzionato mediamente male e nel corso del tempo la qualità dei partiti e della classe politica è scaduta. In più, le brutte leggi elettorali consentono oggi ai dirigenti di partito di farsi eleggere quando e dove vogliono e di imporre i loro amici, amiche e collaboratori. Buona è invece la legge elettorale che dà potere a chi vota. Con cittadini interessati alla politica, informati, partecipanti ed «europeisti» è però ancora possibile migliorare, grazie a pochi ritocchi al Parlamento e al governo. Con scienza politica e impegno civile, questo libro spiega come e perché.

Un richiamo al drammatico omicidio di Charlie Kirk sbagliato #intervista il Resto del Carlino @qn_carlino

*Qui il testo dell’intervista approvato dal prof Pasquino. In fondo allegata **l’intervista fortemente rimaneggiata pubblicata da il Resto del Carlino
*Un richiamo al drammatico omicidio di Charlie Kirk sbagliato, perché la situazione fra Stati Uniti e Italia non è paragonabile, e spudoratamente volto a trarre qualche vantaggio politico.
Gianfranco Pasquino, Professore Emerito di Scienza Politica all’Università di Bologna, boccia le accuse lanciate dalla premier Meloni e l’allarme della destra italiana, che ha messo in guardia sul rischio emulazione.
Professor Pasquino, che idea si è fatto dell’assassinio di Charlie Kirk?
«In America la violenza è di casa sempre. Come disse un tempo un leader delle Pantere Nere, la violenza è “americana come la torta di mele” e quindi non mi stupisco e più di nulla. Può succedere in qualsiasi momento contro un politico, contro i bambini che vanno a scuola. Contro i clienti di un supermercato, in qualsiasi situazione che in qualche modo possa eccitare qualche mente malata che dispone di armi».
In Italia, però, c’è un dibattito piuttosto infervorato sulla possibilità che questa ondata di violenza approdi anche in Italia. La premier Meloni ieri ha parlato di clima insostenibile e lanciato accuse alla sinistra, rea secondo lei di minimizzare quanto accaduto negli Stati Uniti…
«Anzitutto, andrebbe ricordato alla premier Meloni che la stagione dei neofascisti stragisti non è estranea all’Italia e che le bombe in Piazza Fontana e alla stazione di Bologna sono bombe dichiarate dai magistrati fasciste. Credo non vada dimenticato. In secondo luogo, non c’è il clima perché ci sia una radicalizzazione violenta nella società e mi auguro che non ci siano neanche coloro che sperano di trarre vantaggio politico. I tempi sono altri e fa molto male a richiamarli. Giorgia Meloni deve pensare ad altro».
Quindi, da politologo e docente universitario, non vede una polarizzazione all’interno degli atenei come quella che si può osservare negli Stati Uniti?
«C’è una situazione di tensione fra i giovani, soprattutto per quanto riguarda la delicata situazione internazionale, con particolare riferimento a Israele e Hamas. In una parte di attivisti pro Palestina è ravvisabile una qualche propensione alla violenza, ma si tratta di un fenomeno abbastanza limitato. L’Italia non è paragonabile agli Stati Uniti sotto nessun punto di vista».
Ha detto che i tempi sono cambiati e che la situazione italiana non è paragonabile a quella statunitense. Ma, in concreto, che cosa, secondo lei, mette al riparo l’Italia da un rischio di emulazione dell’esperienza americana?
«Negli Stati Uniti, la tradizione di violenza è stata coltivata nel corso dei decenni, non si è mai né attenuata, né tanto meno estinta. Al contrario, in Italia è stata respinta in modo molto chiaro. Non mi pare che adesso nel nostro Paese ci siano gli spiragli o le motivazioni per portare avanti azioni di violenza politica motivata. È proprio un paragone che non sta in piedi, a meno che non si si riferisca a Casa Pound e a Forza Nuova, gli assaltatori della sede romana della CGIL .
La premier, però, ha accusato la sinistra di minimizzare l’omicidio di Kirk, parlando di ‘clima insostenibile’. Come mai una posizione tanto netta?
«Pensa di poter trarre vantaggio politico, soprattutto se si considera che, spesso, chi chiede legge e ordine sono gli elettori di destra. Questo, dal punto di vista elettorale, a volte funziona, ma che brutta strumentalizzazione».
L’opposizione è stata attaccata duramente, come dovrebbe replicare, secondo lei, soprattutto in ragione del fatto che, per fortuna, in Italia al momento non ci sono atti eversivi o violenti?
«Dovrebbe replicare dicendo a Giorgia Meloni di fare pulizia nei suoi dintorni, perché la violenza si annida sui versanti della destra estrema, non della sinistra italiana».
** Intervista rimaneggiata pubblicata il 14 settembre 2025 su il Resto del Carlino

In Francia sono in crisi i partiti, non la democrazia @DomaniGiornale

“Chi conosce il diritto costituzionale classico e ignora la funzione dei partiti, ha un’idea sbaglia dei regimi politici contemporanei; chi conosce la funzione dei partiti e ignora il diritto costituzionale classico ha un’idea incompleta ma esatta dei regimi politici contemporanei”. Questa frase del giurista e politologo francese Maurice Duverger, è tratta dal suo giustamente famosissimo libro Les partis politiques (1951). Mantiene tutta la sua validità e bisogna farne tesoro analitico. Anni dopo, pur fiero oppositore del Gen. de Gaulle e inizialmente delle istituzioni della Quinta Repubblica, Duverger diventò sostenitore e cantore del semipresidenzialismo, modello di governo poi diffusosi con successo in Portogallo e in non poche democrazie postcomuniste dell’Europa centro-orientale. Fedele alla sua impostazione, oggi Duverger suggerirebbe di guardare alle notevoli difficoltà di funzionamento (come sono bravo a evitare la parola crisi meno che mai associandola a democrazia) della Quinta Repubblica, ma, senza in nessun modo sottovalutare l’assetto costituzionale, andando ad esplorare in special modo la struttura e la dinamica del sistema dei partiti.
Fintantoché i partiti gollista e, in maniera appena inferiore, il Parti Socialiste hanno saputo raccogliere e organizzare il consenso dell’elettorato, la Francia, che, è opportuno ricordarlo, veniva dall’esperienza disastrosa della Quarta Repubblica, ha acquisito dinamismo, si è modernizzata, ha dato vita a energizzanti alternanze al governo e grande spolvero alla sua grandeur. Indebolitisi i partiti per molte ragioni, una delle quali è il declino delle qualità delle loro leadership, è diventato più difficile acquisire e mantenere un funzionamento soddisfacente delle istituzioni semipresidenziali.
Nel 2017 Emmanuel Macron conquistò la presidenza sfruttando un appositamente creato veicolo elettorale che scompaginò la sinistra, soprattutto i socialisti, e in parte anche i gollisti. Poi, contando probabilmente troppo sulle sue capacità personali, non si è impegnato a sufficienza per radicare sul territorio, operazione comunque difficile, la sua comunque strutturalmente debole organizzazione politica. Riconquistata la presidenza nel 2022 soltanto grazie a quel che rimane della “disciplina repubblicana” con la quale de Gaulle escludeva democraticamente la destra da qualsiasi accesso al governo, Macron si è trovato a fronteggiare un’Assemblea Nazionale nella quale i “suoi” deputati non sono mai stati maggioranza assoluta e hanno dimostrato di non avere abbastanza forza di attrazione. Al contrario.
La sua esagerata autostima e una malposta volontà di ripicca nei confronti di alcuni settori della sinistra, in particolare quelli guidati da Jean-Luc Mélenchon, hanno portato l’orgoglioso Presidente Macron in un vicolo cieco. Potrebbe procedere a sciogliere nuovamente il Parlamento, sperando in qualche colpo di fortuna elettorale, ma il rischio di logorare a suo personale scapito sia l’elettorato sia le istituzioni è molto grave. Non riesce a trovare, probabilmente oggi non esiste, una personalità in grado di convincere almeno parte dei rappresentanti della France Insoumise a sostenere un nuovo governo. Per di più non potendo ricandidarsi per un terzo mandato, le sue dimissioni in tempi brevi aprirebbero una voragine, pardon la strada per l’Eliseo al Rassemblement National, anche se non all’inibita Marine Le Pen ovvero, in alternativa, non meno sgradita al campione di europeismo Macron, ad un esponente anti-Unione Europea di France Insoumise. Se i non sottomessi saranno capaci, superando le loro differenze, di trovare un candidato vincente.
Comunque vada, senza una effettiva e significativa ristrutturazione del sistema dei partiti, il funzionamento del sistema politico francese non migliorerà. Anzi, continuerà ad essere la palla al piede delle indispensabili riforme economiche e sociali la cui attuazione richiede una guida politica competente, affidabile, legittimata dal consenso elettorale. Vaste programme, bien sûr.
Pubblicato il 10 settembre 2025 su Domani
INVITO La politica: vocazione e partecipazione #LectioMagistralis #11settembre #Ancona 7° Festival della Storia #Passioni

giovedì 11 Settembre 2025
h. 17:00 | Auditorium della Mole
La politica: vocazione e partecipazione
Gianfranco Pasquino
Lectio Magistralis
Chi non si interessa di politica, la politica non si interessa di lui/lei. Politica è vivere insieme nella città. Interessarsi, informarsi, inquietarsi, partecipare, vincere, perdere rifluire. L’indifferenza è il vizio dei cittadini di serie B. Appassionarsi con giudizio è la qualità che vorremmo, che possiamo acquisire. Giova a noi e agli altri.
7° Festival della Storia Passioni Ancona 11 settembre – 14 settembre 2025

Democrazie, non fragili, ma complesse #paradoXaforum

Fra pochi giorni sarà in libreria il primo importante libro di Giovanni Sartori, Democrazia e definizioni, pubblicato dal Mulino nel 1957. Come avrebbe poi teorizzato, Sartori scriveva contro, vale a dire criticando le definizioni di democrazia date dai comunisti e dai benpensanti non solo a sinistra negli anni quaranta e cinquanta del secolo scorso. Quel contesto era particolarmente significativo. Quelle definizioni, spesso accompagnate da aggettivi distorcenti, democrazia “guidata”, pleonastici e fuorvianti, democrazie “popolari”, erano spesso strumento di lotta politica e ideologica. Forse oggi c’è bisogno di dire e sottolineare che Sartori riteneva e argomentava che la democrazia liberale era la forma migliore di democrazia. Condivido, sapendo che Sartori fu sempre attento alle possibili declinazioni pratiche delle democrazie liberali. Qui sta il punto che merita un approfondimento.
Le democrazie, a partire da quelle liberali, sono, come, senza fantasia ripetono non pochi commentatori, “fragili“? Quest’aggettivo non compare negli scritti di Sartori et pour cause, cioè non per caso. Infatti, né le democrazie liberali né la democrazia di Sartori possono mai essere definite fragili, castelli di carte. Quell’insieme di diritti, civili e politici, talvolta anche sociali, e di istituzioni separate (merci, Montesquieu), che è costitutivo delle democrazie, non è affatto fragile. Merita, anche quando non è accompagnato da una società, uso gli aggettivi preferiti dagli americani, ”robusta e vibrante”, l’aggettivo complesso. Poi, caso per caso, si potrà indagare se complesso implica anche e a quali condizioni vulnerabile. Non necessariamente.
Certamente, la democrazia di Weimar (1919-1933), alla quale nessuno ha mai attribuito l’aggettivo fragile, fu politicamente e istituzionalmente molto complessa e si dimostrò anche vulnerabile. In quanto drammaticamente tale continua a essere oggetto di una molteplicità di analisi anche ottime sulle cause del suo crollo. Ma, fermo restando che si contano sulle dita di una mano le democrazie apparse e cresciute dopo il 1945, dopo il 1974 e dopo il 1989 (le ondate di democratizzazione di cui ha convincentemente scritto nel 1991 Samuel P. Huntington), quali sarebbero di grazia le democrazie “fragili”?
Soltanto di una democrazia del secondo dopoguerra è possibile affermare con certezza che è “caduta”: il Venezuela. Gli analisti sono concordi che la causa principale, il fattore scatenante fu l’implosione dei due partiti che garantivano la politica democratica e competitiva, non la fragilità delle istituzioni venezuelane. Quel che è sicuro è che l’autoritarismo di Maduro è tutt’altro che solido. Tuttavia, il discorso su presunta fragilità, complessità e vulnerabilità delle democrazie non deve essere abbandonato. Insieme a molti errori definitori e talvolta, più gravi, analitici (non è vero che le democrazie “muoiono”, accertabile è che vengono assassinate, per lo più dalle elites politiche, economiche, militari, persino religiose), alcuni studiosi hanno finalmente colto i punti più importanti, spesso decisivi. Erosione e backsliding, scivolamento all’indietro, retrocessione sono i due fenomeni più preoccupanti.
Quando i diritti dei cittadini vengono limitati e cancellati e l’autonomia di ciascuna delle istituzioni, in particolare quella del sistema giudiziario, viene ferita e ridimensionata, allora comincia un procedimento pericolosissimo che colpisce prima la qualità di quella democrazia, poi, la sua funzionalità, infine, la sua esistenza. Niente di questo risulta comprensibile a chi lo guarda dalla finestra della fragilità, meno che mai sapendo come bloccarlo. Mantenere la complessità suscitando pluralismo è, Sartori approverebbe, la ricetta dei difensori della/e democrazia/e.
Pubblicato il 4 settembre 2025 su PARADOXAforum
Pasquino:“Attori del disordine” #intervista @Key4biz Cina, Russia e India pronti alla nuova governance globale anche sulla tecnologia.
SCO 2025. Cina, Russia e India pronti alla nuova governance globale anche sulla tecnologia.

di Flavio Fabbri | 2 Settembre 2025
Il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai segna un passo in avanti nell’asse Pechino-Mosca-Delhi. Infrastrutture, materie prime, tecnologie e dazi americani ridisegnano gli equilibri globali, rafforzando la cooperazione asiatica e mettendo in discussione vecchi ordini. L’intervento di Gianfranco Pasquino.
“Difficile dire quali saranno le conseguenze concrete del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione tenutosi a Shangai. Per quel che sappiamo pare opportuno che il giudizio rimanga per metà sospeso e per metà meriti di essere piuttosto negativo. Certamente quegli stati e i loro leader non sapranno costruire un nuovo ordine mondiale. Hanno contribuito per insipienza e per prepotenza al disordine. Non hanno elaborato e diffuso idee sulle loro preferenze (ma qualche riprovevole fattaccio, sì). Non risolveranno il problema, ma continueranno ad essere parte cospicua di quel problema“, ci ha spiegato Gianfranco Pasquino, accademico dei Lincei, Professore emerito di Scienza politica all’Università di Bologna.
“La dichiarazione di Tianjin sul “rispetto del diritto dei popoli a scegliere in modo indipendente e democratico i propri percorsi di sviluppo politico e socio-economico” è CLAMOROSAMENTE contraddetta – ha proseguito Pasquino – da un lato, dalla continuazione dell’aggressione russa all’Ucraina, dall’altro, dalle palesi mire della Cina su Taiwan nonché dalle modalità di “normalizzazione” di Hong Kong (da non dimenticare). Per di più, come opportunamente nota Flavio Fabbri, “Pechino reclama un ruolo chiave e di guida” (sicuramente non basato sul soft power) che, la Russia forse sarà costretta a riconoscere, ma che l’India proprio non può permettersi di accettare“.
“Tutti o quasi guidati in maniera autoritaria, con l’eccezione democratica dell’India che Modi sta erodendo, gli stati firmatari condividono due caratteristiche fondamentali: un notevole livello di repressione e un alto grado di corruzione politica, economica, sociale. Su questi due pilastri non si costruirà nessun nuovo ordine internazionale. Anzi, ben presto emergeranno le contraddizioni nei comportamenti dei firmatari e nelle loro interazioni.
In maniera molto ingenerosa, si critica l’Europa per la sua assenza, quasi rassegnazione. Ma a che cosa? L’Unione Europea è impegnata su una pluralità di fronti in azioni di cooperazione allo sviluppo e di sostegno internazionale. Deve legittimamente astenersi da critiche esplicite a fenomeni incompiuti che non può in nessun modo condividere. La sua stessa esistenza e le sue attività mantengono accesa la torcia dei diritti umani e della democrazia. Lo sanno benissimo tutti i migranti che approdano sulle spiagge europee perché in Europa vogliono venire a vivere, lavorare, fare crescere i figli, persino tornare a fare politica“, ha precisato Pasquino.
“Quando nascerà un nuovo ordine internazionale decente post-liberale, alcuni dei governanti dello SCO avranno perso le loro cariche e, forse, i precedenti degli autoritarismi repressivi insegnano, anche la vita. Quel nuovo ordine non avrà nulla o quasi da spartire con le ambizioni egoiste, gli interessi particolaristici e gli opportunismi dei firmatari della dichiarazione di Tianjin. Saranno i principi e i valori dell’Unione Europea a costituirne le fondamenta“, ha sottolineato Pasquino.
Le fatiche di Sisifo della sinistra multiforme @DomaniGiornale

Da qualche tempo, forse più che nel recente passato, per intenderci ai tempi dei governi guidati da Berlusconi, le opposizioni italiane si (rap)presentano all’elettorato e all’opinione pubblica in maniera frammentata e particolaristica, conflittuale al loro interno, improponibili come governanti. In parte consapevolmente e deliberatamente, in parte anche, va detto, con egoismo e insipienza, sembrano avere deciso che ciascuna di loro rappresenta una sua parte di elettorato, che a ciascuna di loro viene appaltata quasi in esclusiva una tematica importante.
Coerentemente con la sigla prescelta, Alternativa Verdi e Sinistra si definisce con riferimento alle tematiche ambientali, affidate a Bonelli, e alle tematiche sociali più antagoniste (quelle sulle quali il Partito Democratico è più timido) riserva di Fratoianni, sempre televisivamente ripresi insieme (par condicio). Lasciato un po’ (troppo) sullo sfondo il reddito di cittadinanza, le 5 Stelle di Giuseppe Conte, lui più che altri, si caratterizzano come il partito più contrario alla guerra con tutte le ambiguità del caso. Dal canto loro, Renzi e Calenda sono essi stessi tutto un programma personalistico e non esitano a rimarcarlo in maniera più o meno plateale ogniqualvolta possibile, preferendo farlo con prese di distanza rispetto alle posizioni del Partito Democratico.
In quanto vero e proprio, anche se spesso insoddisfacentemente, partito, il PD non può limitarsi a possedere una sola preminente e prominente tematica che lo caratterizzi una volta per tutte. In aggiunta alla sanità e al salario minimo garantito (che non merita di essere lasciato appassire), deve avere una pluralità di offerte e di posizioni programmatiche e deve cercare di fare sintesi con quelle dei potenziali e indispensabili alleati. Al suo interno, e non soltanto perché la segretaria Elly Schlein da quell’interno, che poco si concilia con alcune sue propensioni di movimento, non viene e poco lo conosce, stanno diverse “sensibilità” che cercano di manifestarsi, per l’appunto intorno ad una tematica. Di recente, sono stati i cattolici, sì, lo so, molto più di una semplice tematica, piuttosto un posizionamento (ideale?), a esprimere il loro disagio. La sostanza complessiva è che l’elettorato percepisce una immagine variegata delle opposizioni che, talvolta attrae e talvolta respinge, a seconda dei luoghi e della prevalenza non del tutto casuale di uno o di altro oppositore.
Marciare separati per offrire il massimo di rappresentanza ad una società frammentata e conflittuale, agitata da interessi particolaristici è comprensibile. Può servire e riuscire, ma è una fatica di Sisifo. Richiede determinazione, pazienza e raffinatezza. Si esaurisce di volta in volta. Per stare alle parole della politica, il campo deve essere definito, popolato e allargato costantemente. Per colpire uniti, che è la seconda, decisiva fase, se non ad una unità impossibile, forse neppure desiderabile, da chi crede che il pluralismo è la vera ricchezza, è essenziale non soltanto formulare un programma, non una sommatoria, coerente, ma dimostrare molto più che la semplice condivisione e intenzione di sostenerlo. Invece, nelle aule del Parlamento, nel salotti dei talk televisivi, sui social, nelle piazze, i dirigenti delle opposizioni ricercano la loro visibilità segnalando quanto gli altri siano distanti e, soprattutto, siano in errore, sbaglino. Gli elettori vedono e sentono, alcuni se ne dolgono e se ne vanno (lontano dalle urne). Pochi, non sufficienti, si lasciano attrarre da promesse contrastanti. Altri, lo sappiamo da diverse ricerche, non vogliono un governo attraversato da tensioni che potrebbero essere paralizzanti se non letali.
Sarebbe sbagliato chiedere alle opposizioni di appiattirsi abbandonando temi cari e importanti per l’lettorato, ma se non riescono ad elaborare una credibile prospettiva di governo non all’ultimo minuto, il futuro loro e quel che più conta dei loro elettori sarà triste e gramo.
Pubblicato il 3 settembre 2025 su Domani