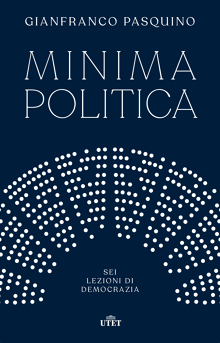Home » Posts tagged 'legge elettorale' (Pagina 7)
Tag Archives: legge elettorale
Le ragioni del NO #Referendum2020 #tagliodeiparlamentari #intervista @RadioRadicale #IoVotoNO
“Referendum sul taglio dei parlamentari, le ragioni del NO. Intervista al professor Gianfranco Pasquino” realizzata da Giovanna Reanda con Gianfranco Pasquino (professore emerito di Scienza Politica all’Università degli Studi di Bologna).
L’intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2020 alle 09:37.
La registrazione audio ha una durata di 13 minuti.
Meno parlamentari, meno efficienza #ReferendumCostituzionale @rivistailmulino
Coloro che voteranno “sì” alla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari, poiché vogliono un Parlamento più efficiente con meno parlamentari per fare più leggi e più rapidamente, sbagliano alla grande almeno su due punti assolutamente discriminanti. Dal punto di vista della teoria, che non hanno imparato neppure dopo la grande occasione del referendum 2016, poiché il compito più importante del Parlamento non è fare le leggi. Semmai, è esaminarle, emendarle e approvarle. Dal punto di vista della pratica poiché in tutte le democrazie parlamentari le leggi le fa il governo: tra l’80 e il 90% per cento delle leggi approvate sono di origine governativa. Ed è giusto che sia così perché qualsiasi governo, anche di coalizione, ha avuto il consenso degli elettori sulle sue promesse programmatiche e ha, quindi, il dovere politico di tentare di tradurle in politiche pubbliche. Naturalmente, nei governi di coalizione il governo concilierà le diverse promesse programmatiche dei partiti coalizzati. I parlamentari potranno poi valutare, per eventuali voti di coscienza e scienza, quanto le proposte si discostano dalle promesse e, se non c’entrano per niente, astenersi dal votarle. A un Parlamento che s’attarda, a una opposizione che ostruisce, a una maggioranza riluttante (quasi nulla di tutto questo è un “semplice” affare di numeri), il governo imporrà la decretazione di urgenza.
La domanda giusta è: meno parlamentari saranno in grado nelle Commissioni di merito e in aula di controllare quello che il governo (con i suoi apparati politici e burocratici) fa, non fa, fa male?
Detto che il controllo sul governo è il compito più importante del Parlamento, quasi sullo stesso livello si situa il compito della rappresentanza politica, dei cittadini, della “nazione”. Non ne farò un (solo) problema di numeri come argomentano molti volonterosi sostenitori del taglio, ma di qualità. È plausibile credere che, automaticamente, meno parlamentari saranno parlamentari migliori, più capaci, più efficaci, più apprezzabili? Per sfuggire a una risposta (negativa) frettolosa, mi rifugio nell’affermazione che molto dipenderà dalla legge elettorale. Ovviamente, una legge elettorale è buona o cattiva o anche pessima (che è l’aggettivo da utilizzare per le due più recenti leggi elettorali italiane) a prescindere dal numero dei parlamentari, ma con riferimento prioritario a quanto potere conferisce agli elettori. Gli accorati inviti di Zingaretti ad approvare una legge elettorale proporzionale addirittura prima dello svolgimento del referendum mi paiono avere come obiettivo quello di contenere la riduzione inevitabile del numero di seggi del Partito democratico, piuttosto che quello di migliorare la qualità della sua rappresentanza proprio quando dal suo partito vediamo venire strabilianti esempi di opportunismo.
Questi esempi rispondono in maniera quasi definitiva alla domanda posta da Giovanni Sartori nel 1963. Di quali soggetti i parlamentari temono maggiormente la sanzione per i loro comportamenti: gli elettori, i gruppi di interesse, i dirigenti di partito? Con le due più recenti leggi elettorali la risposta è elementare: i dirigenti di partito (e di corrente). A loro volta sono questi dirigenti a cercare di raggiungere i gruppi di interesse rilevanti spesso candidando uno dei loro esponenti. Quanto agli elettori, costretti a barcamenarsi fra candidature plurime, un vero schiaffo alla rappresentanza politica, e candidature bloccate, la loro eventuale sanzione non riuscirà mai ad applicarsi alla singola candidatura.
E, allora, quale rappresentanza? Quale accountability? Quale responsabilizzazione? Il fenomeno più significativo è rappresentato dal Pd. Tre volte i suoi deputati e i suoi senatori, che non risulta avessero consultato i loro elettori, hanno votato no alla riduzione. L’ultima volta votarono compattamente sì. La spiegazione, forse era preferibile dirlo alto e forte, era che l’approvazione del taglio era indispensabile per dare vita alla coalizione di governo con il Movimento 5 Stelle. Capisco, ma ritengo assai deprecabile chi ha votato tre volte “no” senza trasparentemente esprimere alcun dissenso e ha votato “sì” alla quarta volta, nuovamente senza esprimere dissenso né spiegare la giravolta. Il fatto è che quei parlamentari democratici hanno applicato la linea del loro partito/gruppo parlamentare che aveva deciso che la formazione del governo giallorosso era di gran lunga preferibile all’alternativa rappresentata da Salvini e Meloni, i quali avrebbero aggredito la Costituzione, antagonizzato l’Unione europea, inciso negativamente sulla già non proprio elevata qualità della democrazia italiana.
Adesso, la risposta da dare nelle urne è proprio se la riduzione del numero dei parlamentari contribuirà o no a un salto di qualità della rappresentanza politica, al miglior funzionamento del bicameralismo (che qualcuno scioccamente continua a definire “perfetto”, dunque, da non toccare minimamente) e alla qualità della democrazia italiana. A mio parere, nulla di tutto questo conseguirà dalla semplice riduzione. I risparmi sui costi di un terzo dei parlamentari eliminati saranno “mangiati” dall’aumento dei costi delle campagne elettorali più competitive e in circoscrizioni più ampie. Il reclutamento di candidati e candidate ad opera dei dirigenti di partito e di corrente premierà coloro che hanno dimostrato di essere più disciplinati (è un eufemismo). Alcuni si sono già posizionati, altri stanno sgomitando. Farà la sua comparsa in grande stile, ma sotto mendaci spoglie, il vincolo di mandato. Vota non come vorrebbero i tuoi elettori, che, a meno di una buona legge elettorale, gli eletti non saranno in grado di conoscere, ma come dicono i dirigenti del partito e della corrente anche perché in questo modo si sfuggirà dal fastidioso esercizio dell’accountability. La prossima volta a qualcuno/a sarà assegnato un seggio sicuro magari in Alto Adige, se vi rimarrà almeno un collegio.
No, chi non vuole nulla di tutto questo ha l’opportunità di respingerlo: con un sano e argomentato voto che si oppone alla riforma sottoposta a referendum. Il resto chiamatelo pure “scontento” democratico. Non è immobilismo perché la Costituzione italiana e la democrazia parlamentare che esistono dal 1948 hanno ampiamente dimostrato di essere flessibili e adattabili, in grado di superare le sfide e di continuare a offrire un quadro democratico per la competizione politica, per un tuttora decente rapporto fra le istituzioni, per il conferimento dell’autorità, per l’esercizio del potere “nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Pubblicato il 28 agosto 2020 su rivistailmulino.it
Al referendum dico “NO” per difendere la Carta @fattoquotidiano #Referendum2020
Un’abbondante maggioranza assoluta di deputati e senatori, ma non i due terzi, ha votato a favore della riduzione di un terzo del numero di parlamentari in entrambe le Camere. Non importa sapere chi ha votato per convinzione e chi per convenienza, ma è legittimo chiedere ai parlamentari del Partito Democratico perché, dopo tre voti contrari, hanno deciso di passare al voto favorevole. La risposta può benissimo essere che il governo è più importante di quel particolare elemento costituzionale che è il numero dei parlamentari. Potrebbero anche dire che si sono convinti che è opportuno risparmiare i soldi del contribuente. È motivazione rispettabile anche se, naturalmente, criticabile: meno parlamentari non significa automaticamente parlamentari migliori. Potrebbero dire che meno parlamentari saranno più efficienti. Approveranno più leggi in tempi più brevi. Anche questa motivazione mostra la corda per due ragioni. Da un lato, tutti si lamentano che le leggi in Italia sono troppe. Dunque, non si capisce perché dovremmo volere un Parlamento snello che approvi più leggi. Dall’altro, è noto, o dovrebbe esserlo, che quasi il 90 per cento delle leggi approvate sono di origine governativa. Elevato o ridotto che sia, il numero dei parlamentari non fa differenza anche perché, comunque, il governo otterrà quello che vuole attraverso il ricorso alla deprecabile e deprecata decretazione d’urgenza sulla quale la riforma che procede alla riduzione del numero dei parlamentari non ha niente da dire.
In effetti, la semplice riduzione del numero dei parlamentari non implica praticamente nulla se non, ma qui il discorso diventa più complesso, qualche problema per due compiti che i “buoni” parlamentari dovrebbero svolgere: dare rappresentanza politica agli elettori, alle loro preferenze e esigenze, interessi e ideali, e controllare quello che il governo fa, non fa, fa male. Soltanto in piccola parte questi due compiti dipendono dal numero dei parlamentari, ma, certamente, un numero ridotto implica che molti parlamentari saranno più oberati da compiti che richiedono presenza, preparazione, tempo. Ci saranno aggiustamenti, annunciano i sostenitori della riforma. Dopo l’approvazione definitiva seguirà una nuova legge elettorale che consentirà, ma questo non lo dice nessuno, migliori modalità di elezione dei parlamentari. Di per sé, deve subito essere chiarito, non è affatto vero che qualsiasi legge elettorale risolva il rebus di una buona equilibrata capillare rappresentanza politica. Da quel che so non è la versione, cioè, lo stravolgimento, della legge elettorale tedesca di cui si discute, che produrrà rapporti migliori in termini di ascolto, di presa in considerazione, di apprendimento e, soprattutto, di responsabilizzazione (accountability) degli eletti e, di conseguenza, di aumento del potere degli elettori. Incidentalmente, la quantità e la qualità di questo potere dovrebbe essere il criterio dominante per valutare la bontà di una legge elettorale.
Infine, non è vero che siamo insoddisfatti soprattutto dal cattivo funzionamento del Parlamento italiano. Dovremmo, comunque, rinunciando all’antiparlamentarismo preconcetto, stilare dei criteri condivisi per dare sostanza al nostro scontento. Quello che ci preoccupa o dovrebbe preoccupare sono i cruciali rapporti fra Parlamento e governo (e viceversa). Se la riduzione del numero dei parlamentari avesse un senso forte, volesse davvero incidere sullo snodo più importante, decisivo delle democrazie parlamentari i suoi sostenitori dovrebbero affermare che con meno parlamentari quei rapporti migliorerebbero da tutti, o quasi, i punti di vista, in particolare: lealtà, disciplina, trasparenza, valorizzazione del ruolo dell’opposizione. Il silenzio su questi aspetti mi sembra molto inquietante.
Ancora più inquietante, mi è, però, parsa la motivazione del deputato del Partito Democratico Stefano Ceccanti. Non ne ricordo il dissenso quando il suo gruppo parlamentare per tre volte votò “no”. Avendo acrobaticamente espresso il suo “sì” alla quarta votazione, Ceccanti ha prodotto come argomentazione dominante quella che, dopo tanto immobilismo costituzionale, la riduzione del numero dei parlamentari, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, aprirebbe una breccia (nella Costituzione). Più di trent’anni fa, fu il grande giurista e storico delle istituzioni, anche Senatore della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania, Gianfranco Miglio, a sostenere la necessità di uno sbrego alla Costituzione italiana. Poiché non gradisco gli sbreghi e non credo che sia opportuno sbrecciare la Costituzione italiana, meglio votare NO.
Pubblicato il 26 agosto 2020 su Il fatto Quotidiano
Meno non significa meglio #tagliodeiparlamentari
L’obiezione più rilevante alla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari non può essere che il risparmio sarà minimo, forse il prezzo di un caffè per ciascun italiano. Non può neppure essere che se gli italiani confermassero con il referendum quella riduzione sarebbe indispensabile scrivere una nuova legge elettorale poiché una legge elettorale migliore di quella vigente è comunque assolutamente auspicabile. Farla senza conoscere il numero dei parlamentari da eleggere è uno spreco di tempo e di energie. La vera obiezione è che meno parlamentari non significa automaticamente un parlamento migliore. Anzi, ci sono alcune buone ragioni per pensare che, in assenza di altre riforme, gli italiani avranno parlamentari scelti male e costretti a operare in condizioni peggiori.
Il guaio grosso non è affatto che meno parlamentari implica anche, probabilmente meno disegni di legge. Piuttosto è che, poiché quasi il 90 per cento delle leggi sono di origine governativa, né potrebbe essere altrimenti in quanto il governo ha il dovere di tradurre in politiche pubbliche le promesse elettorali, meno parlamentari non riuscirebbero a valutare le molte leggi del governo o lo farebbero in maniera approssimativa e superficiale. Inoltre, in qualsiasi emergenza, il governo procederebbe alla decretazione d’urgenza intasando il parlamento e superandone il controllo con il ricorso al voto di fiducia. Già, anche a causa delle scandalose candidature multiple e bloccate (cioè, senza possibilità per gli elettori di scegliere il candidato preferito), poco rappresentativi dell’elettorato, i parlamentari lo diventerebbero ancor meno non potendo, in collegi necessariamente più grandi degli attuali, confrontarsi con gli elettori. I sostenitori della riduzione del numero dei parlamentari replicano che sarà la tecnologia a rendere irrilevanti questi problemi obbligando una istituzione ottocentesca, il Parlamento bicamerale paritario, a diventare finalmente moderno. Purtroppo, da un lato, non c’è traccia dei provvedimenti specifici, comunque già introducibili, che modernizzerebbero il Parlamento; dall’altro, dovremmo avere imparato che lo smart working presenta molti inconvenienti anche per altre attività che si basano su rapporti fra persone, come l’insegnamento scolastico e universitario.
La politica e la rappresentanza politica sono di qualità migliore quando elettori e eletti hanno modo di incontrarsi, vedersi, interagire fisicamente. Meno sono gli eletti che avranno fatto campagna elettorale per informare e convincere gli elettori al fine di dare loro rappresentanza maggiore sarà l’insoddisfazione degli elettori nei confronti di persone che non conoscono e che non sono in grado di valutare. Una buona legge elettorale, le attuali proposte non sono apprezzabili, risolverebbe in parte alcune carenze della rappresentanza che in un democrazia parlamentare è lo snodo cruciale. Allo stato attuale del dibattito, però, la riduzione del numero dei parlamentari è più un salto nel buio che un positivo passo avanti.
Pubblicato AGL il 9 agosto 2020
Caro Zingaretti, di legge elettorale parla quando saprai quanti saranno i parlamentari da eleggere @HuffPostItalia @nzingaretti
Scrivere una qualsiasi legge elettorale senza conoscere con precisione il numero dei rappresentanti da eleggere è un’operazione azzardata. Due punti, però, possono essere decisi subito in prospettiva di una buona rappresentanza politica: nessuna candidatura bloccata, nessuna possibilità di candidature multiple. L’elettore deve potere scegliere il/la suo/a rappresentante. Quindi, o collegi uninominali o almeno un voto di preferenza.
Non impossibili, i collegi uninominali se i deputati e i senatori da eleggere saranno rispettivamente 400 e 200 avranno come minimo, rispettivamente, circa 125 e circa 250 mila elettori. Lieviteranno i costi delle campagne elettorali, conteranno anche altre risorse, sarà molto difficile per gli eletti “conoscere” i loro elettori, preferenze e esigenze. Sarebbe auspicabile che una legge elettorale proporzionale avesse circoscrizioni relativamente piccole: 40 per la Camera e 20 per il Senato con dieci eletti per circoscrizione. La soglia implicita è poco meno del 10 per cento dei voti. Premierebbe quei candidati che nelle rispettive circoscrizioni hanno ottenuto molti voti e dunque rappresentano una parte di elettori/trici anche se il loro partito non avesse superato un’eventuale soglia percentuale nazionale.
Questi relativamente semplici calcoli non dicono nulla sulla qualità della rappresentanza. La riduzione di un terzo del numero dei parlamentari non può essere giustificata soltanto con un risparmio modesto di soldi, quando poi si avrebbero spese potenzialmente “folli” nelle campagne elettorali e negli uffici da mantenere fra una campagna e l’altra. Un buon parlamento e buoni parlamentari debbono svolgere due compiti di assoluta importanza in un democrazia parlamentare: dare rappresentanza ai cittadini, controllare le attività del governo, criticarlo, stimolarlo, eventualmente sostituirlo. I parlamentari saranno tanto più liberi e efficaci in entrambi i compiti se sono debitori della elezione alle loro capacità di ottenere il consenso degli elettori e non alla cooptazione ad opera dei dirigenti dei partiti e delle correnti. È anche probabile che per svolgere soddisfacentemente quei compiti, ad esempio, valutando le leggi e i decreti legge del governo e il loro impatto e l’operato dei ministri e della burocrazia, i parlamentari debbano distribuirsi i compiti.
Un numero ridotto di parlamentari avrebbe molto probabilmente conseguenze negative sul funzionamento del Parlamento spostando potere nelle mani dei governanti. Qui, l’azzardo è palese: meno (parlamentari) non significa meglio (migliore rappresentanza politica e miglior funzionamento del Parlamento e dei rapporti Parlamento/Governo). Anzi, è più probabile che meno significhi peggio, un peggio al quale nessuna legge elettorale potrebbe ovviare, anche se alcune potrebbero ridurre rischi e danni.
Post Scriptum Un minimo di prudenza politica suggerirebbe (anche al segretario del PD Nicola Zingaretti e agli strateghi di riferimento) il silenzio, strategico, sulle indicazioni di fondo relative alla prossima (la legge Rosato è, comunque, da cancellare) legge fintantoché non si sa quanti saranno i parlamentari da eleggere.
Pubblicato il 4 agosto 2020 su huffingtonpost.it
Un’altra legge elettorale è possibile. Pasquino spiega come @formichenews
Potere degli elettori e rappresentanza politica sono i due criteri che propongo di utilizzare per valutare qualsiasi legge elettorale, compresa, naturalmente, quella alla quale si lavora adesso in Parlamento (sperabilmente senza battezzarla in latino). Il commento di Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica
Non possiamo e non dobbiamo schiacciarci ad analizzare qualsiasi testo di legge elettorale sia in discussione in Parlamento. Meno che mai dobbiamo affannarci a spiegare perché questa clausoletta perché questa percentuale perché questi criteri per le candidature. È ora di cambiare il campo di gioco. Cominciamo dai fondamentali. Il criterio dominante, ancorché non l’unico, per valutare la bontà (non la perfezione) di una legge elettorale è quanto potere e quale dà agli elettori. La legge Calderoli e la legge Rosato sono diversamente esemplari. Nella Calderoli il potere degli elettori stava tutto in una crocetta. Che, poi, con quella crocetta gli elettori sapessero vagamente quale candidato ce l’aveva fatta era, a causa delle pluricandidature, sostanzialmente impossibile. La Rosato faceva appena meglio. Mantenute le pluricandidature, ma aggiunto il voto di preferenza di genere (che, peraltro, è suscettibile di notevoli manipolazioni), dava un minimo di potere agli elettori.
Chini sui numeri e sulle percentuali che per molti di loro e dei loro partiti sono questione di vita e di morte, i facitori di leggi elettorali neppure più si ricordano che le modalità con le quali si elegge un Parlamento hanno conseguenze di enorme impatto sulla rappresentanza politica. Da tempo sostengo, in buona compagnia che va da Edmund Burke a Giovanni Sartori, che non è possibile avere nessuna governabilità decente se si riduce la rappresentanza (incidentalmente, tagliare il numero dei parlamentari italiani è riduzione di rappresentanza) invece di migliorarla qualitativamente.
Per quel che attiene alle leggi elettorali, il requisito di residenza nel collegio/circoscrizione per i candidati è il minimo. Soltanto chi vive laddove viene candidato/a e poi eventualmente eletto/a conosce i problemi, ma anche le risorse e le opportunità del luogo e delle persone e sarà in grado di rappresentarle adeguatamente, efficacemente. Le pluricandidature, oltre ad ingannare gli elettori, incidono pesantemente sulla rappresentanza del territorio che è rappresentanza di persone, delle loro attività, delle loro preferenze, delle loro speranze e, ebbene, sì, anche delle loro emozioni.
È giusto porsi l’obiettivo di evitare la frammentazione (di quel che rimane) del sistema dei partiti. Non bisogna mai premiare in qualsiasi forma i “frammentatori”. Tuttavia, credo che, nell’ottica della rappresentanza, esista una soluzione migliore delle clausole percentuali di accesso al Parlamento. In un partito escluso dal Parlamento perché non ha superato quella clausola, possono esserci candidati/e che nelle rispettive circoscrizioni hanno ottenuto notevole successo perché radicati, competenti, molto rappresentativi, ma rimarranno fuori. Meglio allora ricorrere al disegno di circoscrizioni di medio-bassa dimensione che eleggano 15-10 parlamentari (senza recupero dei resti!). Se quindici, allora la soglia sarà all’incirca 7/8 per cento; se dieci la soglia potrebbe essere 8/9 per cento. Complessivamente un partito potrà anche non raggiungere il 4/5 per cento dei voti su scala nazionale, ma alcuni suoi candidati/ saranno comunque eletti perché capaci di esprimere le esigenze di quel territorio. Ne gioverà la rappresentanza parlamentare.
Potere degli elettori e rappresentanza politica sono i due criteri che propongo di utilizzare per valutare qualsiasi legge elettorale, compresa, naturalmente, quella alla quale si lavora adesso in Parlamento (sperabilmente senza battezzarla in latino).
Pubblicato il 21 luglio 2020 su formiche.net
Retroscenisti e onorevoli: responsabili?
Qualche retroscenista, che cerca ostinatamente di indebolire il governo Conte, resuscita i “responsabili”. Non hanno vincolo di mandato. Decideranno loro se e come impegnarsi a salvare sia il governo sia la legislatura per mantenere, legittimamente, il loro seggio parlamentare. Esiste un legame insopprimibile fra legge elettorale e rappresentanza politica cosicché, a causa della pessima legge elettorale del renziano Rosato, a nessuno dei Responsabili sarà possibile, nel bene e nel male, conoscere, oggi e domani, come gli elettori valutano i loro comportamenti.
La democrazia imperfetta #Recensione Minima Politica @UtetLibri su @lasiciliait
Il libro. ”Minima politica” di Gianfranco Pasquino analizza conoscenze politiche che dovrebbero avere tutti i cittadini. La recensione di Paolo fai
«Laddove le persone hanno poco potere sulla politica e lo esercitano limitatamente, si riscontra l’effettiva esistenza di un deficit democratico»
Gianfranco Pasquino, allievo di Norberto Bobbio e Giovanni Sartori, professore emerito di Scienza politica nell’Università di Bologna, ha da poco licenziato alle stampe un libro «Minima politica – Sei lezioni di democrazia», Utet 2019, pp. 175, euro 14,00, il cui titolo – spiega Pasquino – «intende essere il mio modesto omaggio a Theodor Adorno, “Minima moralia” (1951) […], nel convincimento che per arrivare a grandi cose bisogna cominciare dalle piccole cose, impararle e farle il meglio possibile. “Minima politica” contiene, analizza e, spero, illumina il minimo di conoscenze politiche che i cittadini dovrebbero acquisire se desiderano adempiere efficacemente ai loro doveri civili e democratici».
Innervato di rigore scientifico e insieme meritoriamente divulgativo, il libro attraverso sei sezioni (Leggi elettorali, Rappresentanza politica, Presidenti della Repubblica, Deficit democratico, Governabilità, Non liberali, non democrazie) offre al lettore un’analisi, chiara e puntuale, delle problematiche attinenti al funzionamento della forma di governo, la democrazia, in cui, quanto meno per forza di etimologia, il popolo, ovvero la comunità degli individui-cittadini, è il detentore del potere politico.
Intanto, Pasquino non è tra i politologi che cantano la messa funebre alla democrazia. Né è pessimista sul futuro della democrazia. Perché, alle lamentazioni degli apocalittici, per i quali «alle democrazie manca sempre qualcosa», egli ribatte che «le democrazie sono imperfette ed è giusto così. Forse è persino meglio così perché nelle democrazie è possibile continuare a cercare quello che manca, spesso trovandolo».
Allora, dovendo scegliere fior da fiore, troveremo che a Pasquino «pare che, in maniera più appropriata, il deficit democratico meriti di essere riferito al potere dei cittadini, etimologicamente: deficit di potere del popolo. Laddove i cittadini hanno poco potere sulla politica e sui politici e lo esercitano limitatamente, si riscontra l’effettiva esistenza di un deficit democratico». Spesso, tale deficit si avverte quando vanno al potere governi neoconservatori (Tatcher, Reagan, ma anche Trump, che per Pasquino non ha «la benché minima infarinatura di liberalismo»), il cui obiettivo è «comprimere la partecipazione politica, scoraggiare i movimenti collettivi, disincentivare la mobilitazione sociale e reprimerla», al fine di ridurre il “sovraccarico” ovvero «l’accumularsi di un numero eccessivo di domande» da parte dei cittadini, che, secondo Richard Rose, sarebbe la causa della crisi di governabilità.
Il libro si apre e si chiude, ad anello, con due capitoli che si illuminano l’un l’altro: “Leggi elettorali” e “Non liberali, non democrazie”. Le democrazie si fondano sul voto dei cittadini. Ne consegue che «il rapporto tra elettori, da un lato, e rappresentanti e governanti, dall’altro, è accertatamente influenzato dalla legge elettorale che viene utilizzata». Pasquino classifica le riforme elettorali in “partigiane” e “sistemiche”. Fu sistemica quella elaborata nel 1946 dalla Costituente, che riguardava il funzionamento del sistema politico. Tutte quelle venute dopo sono state partigiane, compresa la cosiddetta “schiforma” Renzi-Boschi, su cui Pasquino, caustico, osserva: «Che la stabilità del governo […] dovesse essere affidata al premio di maggioranza ricorda la legge truffa [del 1953], la riabilita e la redime».
Se vengono meno, sostiene con forza Pasquino, i capisaldi delle democrazie liberali moderne, cioè, «da un lato, il riconoscimento, la protezione, la promozione dei diritti dei cittadini, delle persone, e, dall’altro, la separazione delle istituzioni e dei poteri», avremo solo «sistemi politici in cui si tengono elezioni intrinsecamente poco libere», quindi non liberali, non democrazie. Tra i fini di quelle pseudo-democrazie (la Turchia di Erdoğan e l’Ungheria di Orbán, ma anche la Russia di Putin), che Pasquino definisce “democrazie elettorali”, «non si trova praticamente mai quello di dar vita e senso alla “rule of law” (“governo della legge”), o (“stato di diritto), o “nomocrazia”), di tenere separate le istituzioni, di approntare freni e contrappesi, di creare canali e strutture di responsabilizzazione (“accountability”) dei governanti e dei rappresentanti. Questo è il catalogo al quale debbono attingere coloro che vogliono costruire uno stato, una democrazia compiutamente liberale». Da solo, però, il “governo della legge” non basta. Occorre anche una libera stampa e, principalmente, una forte consapevolezza politica nei cittadini. «Le (non) democrazie illiberali –conclude Pasquino – si fondano su cittadini, più o meno consapevolmente, illiberali». E sul silenzio imposto agli oppositori e ai giornalisti. Come nel «caso, esemplarmente tragico, della giornalista Anna Politkovskaja».
Pubblicato il 25 Marzo 2020 sul quotidiano La Sicilia
Minima Politica @UtetLibri
È possibile avere buona rappresentanza politica con una pessima legge elettorale? Chi può credere che meno rappresentanza porti a più governabilità? Che non sia, piuttosto, un passo verso una democrazia illiberale? Fra i freni e i contrappesi che producono equilibri liberal-democratici in Italia svolge un ruolo importante il Presidente della Repubblica? Le risposte esaurienti a questi legittimi interrogativi costituiscono cognizioni minime indispensabili per capire la politica e agire di conseguenza.
La Repubblica italiana, sorta dalle macerie della guerra e inserita da subito nel tessuto politico della tradizione democratica europea, vive momenti di grande confusione. Guerre di visualizzazioni e like su Facebook, baruffe senza costrutto nei talk show, scenette tragicomiche nelle austere aule di Senato e Camera. A questo ircocervo tra reality show e vaudeville siamo talmente assuefatti che ci sembra l’unico orizzonte possibile.
La ragione sta nell’ignoranza diffusa e persino compiaciuta che pare essersi impossessata del discorso corrente. Tra l’ansia da sondaggio e il termometro ossessivo dei social network, viviamo un assetto da campagna elettorale permanente dove i politici possono dire tutto e il contrario di tutto, fiduciosi nella labile memoria storica del loro elettorato e nell’inerzia intellettuale dell’opinione pubblica che dovrebbe sorvegliare e in caso criticare.
Però, chi ancora crede nella democrazia sa che è imperativo reagire all’attuale temperie di approssimazione, fumisteria e populismo. Che è necessario impegnarsi per pulire il linguaggio, per fare uso corretto dei concetti fondamentali, per comunicare insegnando e imparando, giorno dopo giorno.
Con il cuore e la testa ai Minima moralia di Theodor Adorno, Gianfranco Pasquino impartisce sei nitide, ironiche, affilate lezioni sui nodi cruciali della politica contemporanea: i meccanismi elettorali, gli speculari spettri di governabilità e rappresentanza, il ruolo e i compiti delle istituzioni nella complessa architettura della democrazia, lo spauracchio degli eurocrati e il mito del sovranismo.
Ripercorrendo la nostra complicata storia nazionale, ma attingendo dove serve anche agli esempi europei e internazionali, Minima politica racchiude e sprigiona il minimo di conoscenze che i cittadini devono acquisire per capire gli accadimenti politici e partecipare ogni giorno alla vita di questo confuso e malgovernato Paese.
Coazione a sbagliare l’avventurismo istituzionale di Matteo Renzi
Ricomincia l’avventura costituzionale? Vent’anni fa Mario Segni lanciava l’idea del sindaco d’Italia, ovvero l’elezione popolare del Presidente del Consiglio ricorrendo al modello, più elettorale che istituzionale, dei sindaci. Oggi la riprende Renzi con la stessa superficialità e mancanza di precisione. Tre lustri fa per controbattere chi voleva introdurre in Italia l’elezione diretta del Primo ministro, ho curato un “bel” (sic) libro Capi di governo (Il Mulino, 2005): Austria e Germania, Gran Bretagna e Irlanda, Spagna e Svezia. Per tre volte utilizzata in Israele, l’elezione popolare diretta del Primo Ministro, fu abbandonata perché non funzionava. Non esiste nessun buon motivo per riesumarla in Italia. Nelle democrazie parlamentari, il Primo Ministro nasce e muore in Parlamento. Punto.