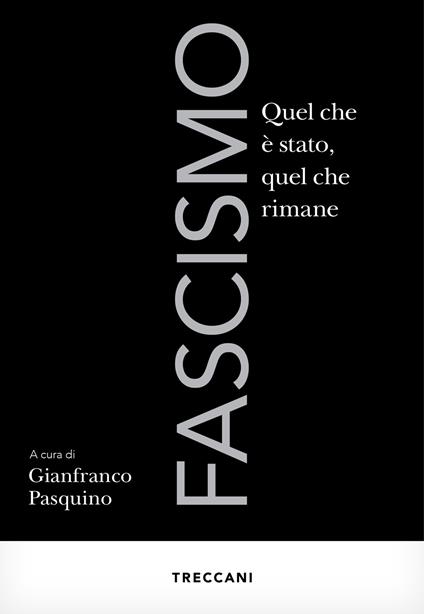La politica è la continuazione della guerra con altri mezzi @DomaniGiornale


C’è chi sostiene che la “la pacificazione” avverrà” quando entrambe le parti condivideranno la tesi che la Resistenza comportò una guerra civile. In verità, la guerra civile cominciò quando le squadre fasciste si avventarono sui lavoratori, sui sindacati e sui partiti e dirigenti di sinistra. Questa sequenza spiega anche, non necessariamente assolve, perché in alcuni contesti poco prima e dopo il 25 aprile, alcuni partigiani procedettero a “punire” i fascisti e i loro fiancheggiatori.
Non so quanti abbiano letto il fondamentale volume di Claudio Pavone, appunto Una guerra civile (Torino, Bollati Boringhieri 1991), ma Pavone scrive di tre guerre nella Resistenza. Oltre alla guerra civile fra partigiani e fascisti, furono combattute due altre guerre: un patriottica e una di classe. Ovvio che i partigiani combattessero anche, in alcuni contesti, soprattutto contro i nazisti, invasori e occupanti. Fu una guerra, in termini moderni, di liberazione nazionale nella quale i fascisti si schierarono con i nazisti, divenendo più che collaborazionisti, veri e propri traditori della patria. In questo senso è accettabile parlare di morte della patria quando i fascisti costituirono lo stato fantoccio noto come Repubblica di Salò. La terza guerra fu una guerra di classe. Molti fra i partigiani, nient’affatto esclusivamente i comunisti, volevano dare una vita uno Stato dei lavoratori, molto diverso da quello che si era inchinato a Mussolini. Molti di loro, ripeto non soltanto fra i comunisti, ritenevano indispensabile cambiare la struttura di classe dello Stato italiano e, in senso più lato, i rapporti sociali per eliminare ogni traccia di fascismo e qualsiasi possibilità di suo ritorno. Senza volere troppo forzare le sue parole, uno dei grandi Costituenti, Piero Calamandrei, giurista esimio del Partito d’Azione, offrì indirettamente sostegno a quelli che erano gli obiettivi di rinnovamento profondo perseguiti dalla guerra di classe, affermando che la Costituzione era “una rivoluzione promessa in cambio di una rivoluzione mancata”. A lungo, non solo fra i partigiani si parlò a (s)proposito di Resistenza tradita.
La parola d’ordine “attuare tutta la Costituzione” mirava proprio a dare sostanza a quegli obiettivi di rinnovamento sostanziale della società italiana, obiettivi che sono efficacemente delineati nell’art. 3 della Costituzione. Insistere nel sottolineare che la Resistenza è stata quasi essenzialmente una guerra civile e che è la destra finalmente al governo che generosamente offre la pacificazione manipola la molto più complessa verità storica. Tenta di fare dimenticare i crimini compiuti contro gli italiani dai fascisti solidamente sostenuti dai nazisti. Esclude dalla riflessioni l’obiettivo mancato del profondo rinnovamento di una società e delle organizzazioni: la Chiesa, la burocrazia, le associazioni industriali che con il fascismo erano venute a patti e che del tutto consapevolmente cercarono, anche offrendo rifugio ai fascisti sconfitti, ma non epurati, di mantenere i privilegi acquisiti e di averne fatto pessimo uso con conseguenze che sono tuttora visibili nel dibattito e nell’azione politica. In un certo senso, la necessità di profondi mutamenti sociali e culturali, è vero che la Resistenza deve continuare.
Pubblicato il 23 aprile 2023 su Domani
Fascismo. Quel che è stato, quel che rimane @Treccani #Invorio #Novara #22aprile @Anpinazionale
ANPI INVORIO
ANPI BORGOMANERO
Sabato 22 Aprile 2023 alle ore 21
Invorio – Casa Curioni
Piazza Innocenzo Manzetti, 11
GIANFRANCO PASQUINO
presenta il libro
FASCISMO
Quel che è stato, quel che rimane
Treccani
Con la partecipazione di Giovanni Cerutti
INVITO Fascismo. Quel che è stato, quel che rimane @Treccani #22aprile #Cameri #Novara Festa della Liberazione 2023
Predicare dal Colle più alto è cosa buona e giusta @DomaniGiornale


Non è una novità che dal Colle più alto possano venire le prediche. Il Presidente Luigi Einaudi ritenne, sommessamente gli direi sbagliando, che fossero prediche inutili. Altri presidenti non ebbero fra i loro meriti (e demeriti) il volere e sapere predicare. Non abbiamo apprezzato abbastanza le esternazioni di Cossiga, non sempre assimilabili a prediche. Meglio, con i loro stili personali, caratteriali, più o meno politici, i predicatori Pertini, Ciampi e Napolitano il quale più dei suoi predecessori aveva il gusto della predica anche perché convinto che il suo “verbo” fosse più conforme alla storia, alla Costituzione e alla politica di cui questo paese (chiedo scusa: nazione) ha bisogno. Da tempo, anche il Presidente Mattarella ha scelto la strada della predicazione per molti temibile anche perché li invita a pentirsi. Lo fa con parole chiare, raramente diplomatizzate, con riferimenti precisi non affidati all’opera di decodifica dei “quirinalisti/e”, con rimandi sempre opportuni alla Costituzione e in un’efficacissima prospettiva europea. L’ambiguità della figura della Presidenza della Repubblica, rilevata per tempo da pochissimi giuristi, consente un’espansione della sfera di influenza presidenziale. Chi poco sa parla a sproposito di “presidenzializzazione”, mentre si tratta piuttosto della flessibilità di cui godono le democrazie parlamentari dotate di un buona Costituzione. Flessibilità che non si trova affatto nelle Repubbliche presidenziali e che per suo prestigio personale Macron rischia di dimostrare che non abita neppure a Parigi, in un semipresidenzialismo riformato non proprio come avrebbe gradito il suo fautore, il Gen. de Gaulle. La Costituzione italiana non solo consente a Mattarella di appoggiare le sue prediche su quanto vi sta scritto. Lo sostiene e lo incoraggia. E il Presidente ne trae alimento. Predicare il ruolo guida del Presidente del Consiglio non significa acconsentire silenziosamente alla pratica deleteria della decretazione d’urgenza abbinata alla imposizione del voto di fiducia che non solo schiaccia il Parlamento, ma rende irrilevante l’opposizione. E non sappiamo quante critiche il Presidente ha avanzato in via informale. Nel contesto in cui viviamo da qualche anno il meglio delle prediche presidenziali ha riguardato le due tematiche più importanti: la guerra e l’Europa. A riprova della cultura, della esperienza vissuta, della preveggenza dei Costituenti, l’art 11 le contiene entrambe. C’è il fermo, esplicito ripudio della guerra di aggressione e c’è l’indicazione della disponibilità a condividere la sovranità a fini di pace e di prosperità. Di recente, se lo sono sentiti dire i polacchi, ma nelle orecchie di Orbán più di un fischio è arrivato. Quella predica vale anche per il 25 aprile degli italiani.
Pubblicato il 19 aprile 2023 su Domani
Pasquino: «Pd, che errore avere tenuto ai margini la cultura politica socialista» #intervista @Avantionline

Intervista raccolta da Giada Fazzalari
“Solo restando ancorati all’Europa la sinistra e il Pd possono trovare ispirazione per creare una cultura riformista “vera”, anche radicale, che oggi manca nello scenario politico italiano” – dice Gianfranco Pasquino, Professore Emerito di Scienza Politica all’università di Bologna, uno dei più intelligenti e acuti pensatori e intellettuali italiani del secondo dopoguerra. Per Pasquino, che tratteggia un affresco dell’Italia politica, il Terzo Polo, vicino alla rottura, è “una cosa poco interessante, un accordo di potere tra Renzi e Calenda che è servito a qualcuno di loro per rientrare in parlamento e per far perdere la sinistra e il Pd alle elezioni”, mentre il Governo, fatto di persone “con poca esperienza e spesso poca competenza, pratica misure che gettano fumo negli occhi ma sostanzialmente non ha fatto nulla che rimanga”.

Cos’è, come si fa, a cosa serve”
(Ed. Utet) è il libro di Gianfranco Pasquino in uscita il prossimo 2 maggio 2023
Totalitarismo e autoritarismo: due situazioni e la loro mala fine @DomaniGiornale


Ingigantire e rendere più spaventoso l’oggetto della propria decennale, in sostanza unica, ricerca può servire a ingigantire l’importanza di quella ricerca e del relativo studioso? Facendo amplissimo sfoggio dell’aggettivo totalitario, spesso a sproposito, e del sostantivo totalitarismo, senza mai definire il concetto e spiegarne significato e implicazioni, Emilio Gentile ovviamente crede di sì. Imperterrito procede attraverso un bilancio troppo selettivo di cent’anni di totalitarismo ((Totalitarismo 100. Ritorno alla storia, Roma, Salerno Editrice, 2023), fondamentalmente riferito al solo fascismo italiano. Parafrasando Giovanni Sartori, sostengo che “chi conosce un solo fascismo non conosce neppure quel fascismo” ossia senza un intelligente, deliberato ricorso alla comparazione non c’è modo di sapere quello che è normale e quello che è eccezionale. Sono, peraltro, pochi gli storici che praticano la comparazione e mettono a confronto natura, caratteristiche, evoluzione e trasformazione dei regimi politici. Senza nessuna ambizione di originalità, ma nell’intento di mettere a disposizione di chi legge quanto la scienza politica ha prodotto da tempo in materia, riporto qui di seguito le due più importanti definizioni di totalitarismo e autoritarismo.
Un regime totalitario si caratterizza per la presenza di tutti, o quasi, gli elementi che seguono, delineati da un grande Professore di Government a Harvard, Carl J. Friedrich e dal suo giovane allievo Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Democracy (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1956):
- Una ideologia totalizzante
- Un partito unico
- Una polizia segreta notevolmente sviluppata
- il monopolio statale dei mezzi di comunicazione
- il controllo centralizzato i tutte le organizzazioni politiche, sociali, culturali fino alla creazione di un sistema di pianificazione economica
- la subordinazione delle forze armate al potere politico
Naturalmente, può succedere che nel corso del tempo qualche elemento venga meno e si ponga il problema della persistenza o no del totalitarismo. Tuttavia, in assenza di alcuni di questi elementi nessun regime può essere considerato totalitario.
Per definire un regime autoritario (tradizionale o classico, quelli nati in Europa e in America latina nello scorso secolo), ritengo tuttora utile ricorrere a quanto scritto nel 1964 dal grande sociologo e politologo Juan Linz (1926-2013) con riferimento al franchismo (1939-1975). Mi pare più che opportuno citare la definizione per esteso, anche come esempio di accurata configurazione degli elementi costitutivi dei regimi autoritari. Più precisamente questi regimi sono (cito dall’articolo Autoritarismo nella Enciclopedia delle Scienze Sociali, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991, p. 444, tutti i corsivi sono miei):
“sistemi a pluralismo politico limitato, la cui classe politica non rende conto del proprio operato, che non sono basati su una ideologia guida articolata, ma sono caratterizzati da mentalità specifiche, dove non esiste una mobilitazione capillare e su vasta scala, salvo in alcuni momenti del loro sviluppo, e in cui un leader, o a volte un piccolo gruppo, esercita il potere entro limiti mal definiti sul piano formale, ma in effetti piuttosto prevedibili”.
Né l’una né l’altra definizione sono prese in considerazione da Gentile il quale opera senza sentire nessuna necessità di esplorazione e approfondimento concettuale né di differenziazione. Soltanto nelle pagine conclusive del suo libro, Gentile riporta due definizioni di fascismo come regime totalitario formulate rispettivamente dal giovane marxista Lelio Basso e dall’oppositore cattolico don Luigi Sturzo. Per il primo, gli elementi essenziali della realtà (dunque, non del ”regime”) fascista“ non ricomprendevano “un’ideologia e una concezione dello Stato che non fosse un mero riflesso della sua politica concreta, che mirava esclusivamente a conservare il potere conquistato, trasformandolo in un monopolio del governo, dello Stato e della politica, con il sostegno di una propria forza armata di partito, e con l’imposizione dei propri miti come un credo religioso, che divinizzava la nazione, identificandola col fascismo stesso, e considerando tutti gli avversari del fascismo, in quanto tali, nemici della nazione, che dovevano essere combattuti e annientati con qualsiasi mezzo” (p. 172, tutti i corsivi sono miei).
Per Sturzo, sostiene Gentile, “il totalitarismo era intrinseco alla natura del fascismo e ne condizionava tutta l’azione, spingendolo ‘ad assorbire tutte le forze nazionali: l’esercito, al quale ha messo a lato la milizia nazionale, che è milizia di partito; e la economia, organizzata nella forma corporativa di partito, per assoggettarla al paternalismo di Stato” (pp. 187-188) (corsivi miei). Infine, Sturzo sottolineava il centralismo statale del fascismo, nuovo “Leviatano che assorbisce ogni altra forza e che diviene l’espressione di un incombente panteismo politico” (p. 188). Troppo facile sottolineare la non sistematicità delle definizioni proposte da Basso e da Sturzo che, pure, entrambe contengono elementi utili, ma a mio parere, non convincenti e meno precisi di quanto scritto da Linz.
Raramente abbiamo modo di provare la validità di una definizione, l’appropriatezza di un concetto mettendoli alla prova dei fatti. Con totalitarismo e con autoritarismo è possibile tentare la prova guardando sia alla dinamica dei due tipi di regimi sia alla loro fine. La chiave interpretativa è l’esistenza/sopravvivenza di associazioni, gruppi. Nei regimi totalitari un solo attore domina le istituzioni e controlla tutti i gruppi decidendo della loro vita e della loro morte, dei loro spazi di autonomia e della loro operatività. Quando il regime totalitario crolla, non c’è nulla in grado di prendere il posto del partito unico e delle associazioni permesse e/o sponsorizzate. Il titolo del bel film di Roberto Rossellini, “Germania Anno Zero”, coglie in maniera molto più che suggestiva il deserto lasciato dal crollo del nazionalsocialismo. Nel vuoto socio-economico e politico aperto dalla disintegrazione dell’Unione Sovietica e dalla scomparsa del Partito Comunista non poteva comparire nessuna “società civile”. Vi si sono trovati a scorrazzare gli oligarchi.
La situazione alla fine ingloriosa degli autoritarismi classici: Italia, Portogallo, Spagna, è risultata molto diversa da quella dei totalitarismi. Proprio perché il fascismo, come il salazarismo e il franchismo, non aveva avuto abbastanza forza per acquisire il controllo totale su alcune potenti strutture: la Chiesa cattolica, le Forze Armate, la burocrazia, nel caso italiano, la Monarchia, e persino gli industriali (in Portogallo le 400 famiglie organizzate che detenevano il potere economico), il crollo del regime aprì, grazie al pluralismo, la transizione alla democrazia. Però. Però questa modalità di transizione comportò in Italia più che altrove (ma è un fenomeno ancora largamente e dolorosamente da esplorare) la mancata epurazione, tranne relativamente poche eccezioni, dei dirigenti e della grandissima maggioranza dei sostenitori importanti del regime.
Certo, anche alcuni esponenti di non altissimo rilievo dei regimi totalitari rimangono o tornano a galla, ma il numero dei revenants di notevole prominenza nei regimi autoritari è incomparabilmente più elevato. Sono le stesse organizzazioni che hanno iniziato la transizione a non volere e non sapere defascistizzare. Nella nuova fase di competizione i numeri contano, le esperienze associative e lavorative servono, le competenze possono essere cruciali. Come si fa a imporre l’epurazione del compagno di stanza, del collega di lungo corso, dell’amico ai tempi del liceo, del coinquilino che, pur avendo sostenuto il fascismo, si sono macchiati di crimini minori, ma giurano d essersi pentiti e si dichiarano pronti alla nuova vita dando il loro apporto all’organizzazione? Nel deserto successivo al totalitarismo, l’espulsione è inevitabile. Nel post-autoritarismo vince l’amnesia, più o meno selettiva (Géraldine Schwartz, I senza memoria. Storia di una famiglia europea, Torino, Einaudi, 2019), con la quale bisogna continuamente fare i conti.
Pubblicato il 8 aprile 2023 su Domani
VIDEO Presentazione del libro a cura di Gianfranco Pasquino “Fascismo. Quel che è stato, quel che rimane” @Treccani @RadioRadicale
“Presentazione del libro curato da Gianfranco Pasquino
Fascismo. Quel che è stato, quel che rimane
Treccani
Con
Gianfranco Pasquino (emerito di Scienza Politica all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna)
Carlo Crosato (ricercatore di Filosofia all’Università degli Studi di Bergamo).
Intervista registrata giovedì 13 aprile 2023

Basta lagnarsi: lo spoils system è il sale della democrazia @DomaniGiornale


Discutere delle qualità di coloro che vengono nominati ai vertici delle aziende a partecipazione statale è sempre cosa buona e giusta. Sbagliata e fuori luogo è, invece, la critica pregiudiziale incapace di proporre alternative allo spoils system. Circa due secoli fa furono i politici USA a stabilire che ai vincitori delle elezioni a tutti livelli spettassero le spoglie, vale a dire un certo numero di cariche non solo, ovviamente, politiche, ma anche amministrative. La logica sottostante era, e rimane, piuttosto semplice. Chi ha ottenuto dagli elettori il potere di decidere le politiche pubbliche deve essere messo in grado di nominare amministratori di fiducia per attuare le politiche da loro desiderate e definite. Chiunque, dunque, può essere nominato liberamente dai detentori del potere politico. Abbiano o no precedenti esperienze in qualche settore; abbiano o no le competenze necessarie, a quelle persone vengono affidati compiti importanti poiché chi li nomina pensa che eseguiranno quanto è loro richiesto.
Qualche volta, non necessariamente soltanto ai livelli più bassi, più dell’esperienze e della competenza, finirà per contare soprattutto la dedizione dei nominandi ai loro referenti politici e di converso la fiducia che quest’ultimi hanno in coloro che già li hanno serviti politicamente. Non c’è nulla di cui scandalizzarsi soprattutto quando l’alternativa sarebbe rappresentata da persone insostituibili nel loro ruolo che, per le loro preferenze politiche, si metterebbero di traverso se chiamati ad attuare un programma che non gradiscono o pensano contrario alle necessità della patria/nazione.
Il sistema delle spoglie comporta un rischio ed è temperato da un meccanismo democratico. Nei sistemi politici nei quali i governi cambiano spesso il rischio è che i nuovi governanti non riescano a sfruttare l’opportunità di nominare esecutori di fiducia. Negli USA, il Presidente ha sempre la possibilità di nominare circa quattro mila burocrati, anche se raramente vuole/riesce a sostituire tante persone. Il meccanismo democratico è lo svolgimento delle elezioni. Infatti, una buona opposizione avrà modo di dimostrare quanto male ha fatto il governo in carica con riferimento alle prestazioni e al rendimento delle aziende pubbliche e dei loro dirigenti, proprio quelli nominati dal capo del governo e dai suoi ministri. Il rendiconto (accountability) del fatto, del non fatto, del mal fatto è almeno in linea teorica il meccanismo che dovrebbe spingere i governanti a nominare i “migliori”. Quindi, le nomine fatte dal governo Meloni sono certamente già valutabili con riferimento all’esperienza e alla competenza dei nominati, ma in una democrazia decente il verdetto decisivo sarà quello delle prossime urne emesso da elettori informati sui fatti grazie ad una opposizione che abbia svolto il suo lavoro adeguatamente.
Pubblicato il 13 aprile 2023 su Domani
Elezioni per acclamazioni? No. Meglio di no.
Nessuna acclamazione è mai una procedura democratica. Non è trasparente, come la democrazia vorrebbe. Non consente di attribuire responsabilità personali a ciascuno/a dei votanti. Permette a chi vorrebbe dissentire di nascondersi in maniera codarda e di non farsi/lasciarsi contare (e di continuare a contrattare). L’elezione voluta dalla neo-segretaria del Partito Democratico Elly Schlein dei capigruppo alla Camera (Chiara Braga) e al Senato (Francesco Boccia) è stata una brutta pagina. Peraltro, chi fa politica dovrebbe ricordare due precedenti acclamazioni non proprio virtuose: la rielezione di Craxi a segretario del Partito socialista a Verona nel 1984 e l’indicazione di Romano Prodi come candidato alla Presidenza della Repubblica nell’aprile 2013 da parte dell’assemblea dei parlamentari del PD (101 dei quali poi non lo votarono). Curiosamente, sulla scia di questo comunque deplorevole e tuttora deplorato episodio, proprio la Schlein ottenne la sua prima visibilità creando il movimento “Occupy PD”. A proposito dell’acclamazione di Craxi, il grande filosofo politico Norberto Bobbio la bollò come “democrazia dell’applauso” e qualche mese dopo pubblicò uno dei suoi libri più famosi: Il futuro della democrazia (Einaudi 1984).
Politicamente, l’acclamazione avvenuta nell’Assemblea del PD porta con sé alcune implicazioni comunque negative. Prima implicazione: la segretaria è convinta di essere molto forte e di riuscire a decidere a prescindere dai cosiddetti “mal di pancia”. Sopravvaluta se stessa e i suoi sostenitori. Seconda implicazione: la minoranza è a disagio, vero o procurato, ma non se la sente di esporsi, di proporre proprie candidature e di imporre un dibattito. Rilutta a contarsi e si trincea dietro un applauso che cela grande ipocrisia. Terza implicazione: non importa conoscere le modalità con le quali i due neo-capigruppo intendono guidare i deputati e i senatori del Partito Democratico. Hanno silenziosamente accettato di essere la cinghia di trasmissione della segretaria. Non vorranno e non avranno autonomia che, invece, per affrontare le peripezie dei dibattiti e delle decisioni parlamentari, è spesso assolutamente essenziale. Infine, ultima implicazione, la minoranza cercherà di “strappare” posti in altre sedi, probabilmente nella segreteria che, invece, essendo la War Room della segretaria, non dovrebbe vedere contrapposizioni correntizie.
Per alcuni inestinguibili “romantici”, come chi scrive, l’acclamazione colpisce al cuore qualsiasi sforzo di costruzione, mantenimento e funzionamento della democrazia di partito nel partito. Per un Partito che si definisce “Democratico” non è solo una grave contraddizione. È una brutta (ri)partenza; è una pessima smentita. Fra il troppo potere divisivo delle correnti e il troppo potere incontrollato della Segretaria, tertium datur, c’è una vera terza via: dibattiti trasparenti, confronti fra fra idee, persone, proposte, votazioni su alternative. Questa, sì, è democrazia.
Pubblicato AGL il 31 marzo 2023