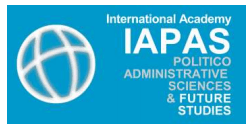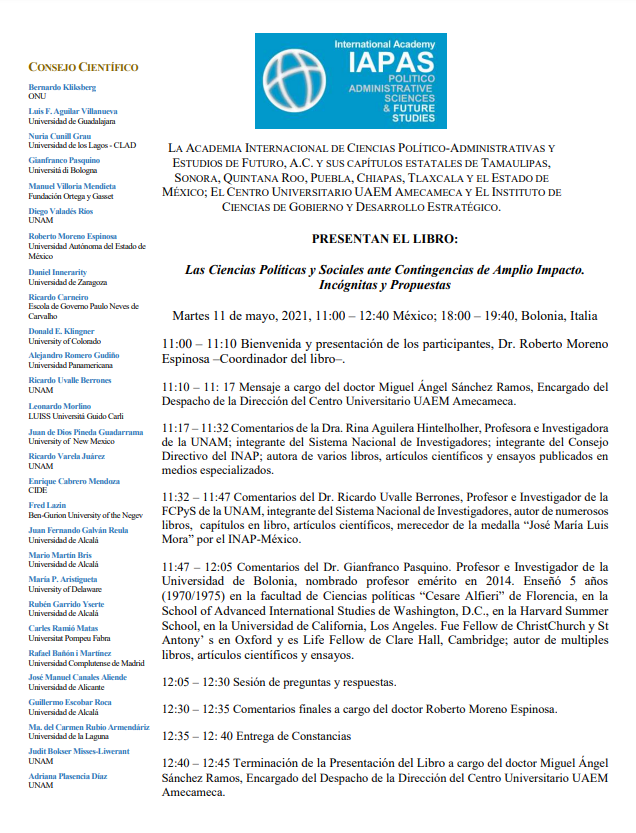Il matrimonio tra il Pd e i 5Stelle s’ha da fare (ma conta il come…) @fattoquotidiano
Da molti mesi, inesorabili e concordi, tutti i sondaggi danno il centro-destra, per la precisione Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, in chiaro e sicuro vantaggio nelle intenzioni di voto degli italiani. Altrettanto sicuramente danno per dimezzato il Movimento 5 Stelle rispetto all’esito del 2018 mentre il Partito Democratico rimane mestamente attestato appena sopra-appena sotto il 20 per cento. L’effetto Enrico Letta non c’è stato, ma in verità nel partito praticamente nessuno se l’aspettava. Una volta tornati ad essere ministri i capi correnti del PD sono lieti che la patata lessa (non bollente) del partito sia nelle mani caute di Letta, e ça suffit. Molti italiani, cerco di interpretare il pensiero di almeno quelli del centro-sinistra, si aspetterebbero che, invece di combattere fra loro, i pentastellati guardassero avanti. Vero è che, se si andrà votare con una legge proporzionale, meglio il tipo che abbia una sana soglia del 5 per cento per l’accesso al Parlamento, vi entrerebbero tanto la variante Conte-Di Maio quanto la variante Casaleggio-Di Battista: un grande fatto per loro, una certificata vittoria per il centro-destra. Giusto, quindi, che si moltiplichino gli sforzi per rimettere insieme le troppo sparse membra di quello che fu, remember?, un arrembante schieramento del 33 per cento. Il Movimento avrebbe moltissimo da recuperare fra espulsioni affrettate e emorragie poco motivate se non dalla mancanza di una cultura politica condivisa. In qualche modo, anche il Partito Democratico potrebbe porsi l’obiettivo di ricomporsi con coloro che se ne sono andati: LeU e, persino, ItaliaViva. Con i primi gli spazi di condivisione sono molto ampli; con i secondi è in corso una assurda lotta nelle primarie prossime venture che dovrebbero essere meglio utilizzate non per una sterile resa dei conti, ma per scegliere quella candidatura a sindaco di Bologna che allarghi il consenso per il centro-sinistra. Certo, per Letta discutere in maniera serena con Renzi non potrà essere né una passeggiata né un pic-nic. Quei voti, però, anche se non sono molti, servirebbero/serviranno. Comunque, non basterà ricomporre il Movimento 5 Stelle e mettere in sesto il PD. Sono essenziali grandi cambiamenti che conducano ad un accordo di fondo fra loro e che si traducano in capacità attrattiva.
Ho sempre avuto riserve sulle alleanze organiche e strutturali. La politica delle coalizioni europee ha sostanzialmente mandato un insegnamento chiaro: le alleanze elettorali, politiche, governative si costruiscono e si ripropongono di volta in volta a seconda della posta in gioco e delle preferenze dei leader, degli iscritti e degli elettori. La ri-costruzione di ciascuna alleanza è resa più o meno difficile dalle precedenti esperienze. Gli inglesi sostengono, giustamente, che success breeds success. Per dare vita a una coalizione elettorale di successo, dunque, mi parrebbe opportuno cominciare subito da qualche esperimento locale reso più agevole dalle preferenze dei dirigenti e degli attivisti, mirando ad alcuni punti programmatici particolarmente significativi. Le elezioni nei comuni al disopra dei 15 mila abitanti offrono la grande opportunità del ballottaggio per l’elezione del sindaco. Consentono, quindi, di valutare come e quanto i due elettorati, pentastellato e democratico, reagiscono rispetto alla necessità/imperativo della confluenza sulla candidatura arrivata al ballottaggio. Ma c’è di più. Consentono di vedere e di misurare sia la capacità di attrarre nuovi elettori sia di motivare parte degli astensionisti, quelli che definisco “di opinione”, cioè che per andare alle urne valutano effettivamente le proposte di nomi e di idee che vengono (loro) fatte.
Questo non è in nessun modo un ragionamento ingegneristico. Tutte le ricerche elettorali dell’ultimo decennio hanno concordemente rilevato che: 1. All’incirca un terzo o poco più degli elettori italiani, molti di quelli che vengono indicati come “indecisi” nei sondaggi, sono disponibili a cambiare opzione di voto da un’elezione all’altra, e lo hanno davvero fatto; 2. All’incirca o poco più di quel 30 per cento sono abbastanza o molto insoddisfatti di come funziona il governo/la democrazia italiana. Certo, spesso i cambiamenti di voto avvengono non da un’area all’altra, ma all’interno di ciascuna area, come potrebbe essere fra Lega e Fratelli d’Italia. Rimane, però, un 10-15 per cento di elettorato che è, userò una parola evocata dai Democratici, contendibile. Per raggiungerlo, però, sarebbe necessaria una coalizione che, partendo da PD più Cinque Stelle, vada alla ricerca dei “contendibili” con l’offerta di qualcosa di più mobilitante che l’esclusione di Salvini dal governo. Ripiegati sui loro più o meno gravi problemi, pentastellati e democratici sembrano affidare il loro destino al successo di Draghi. Non basterà.
Pubblicato il 18 maggio 2021 su il Fatto Quotidiano
A Voce Alta. Ma di cosa parlate, di cosa scrivete? #riformeistituzionali #ComunicazionePolitica @ComPolJournal
«Votare premier e coalizione è solo un sogno proibito?» (Risponde Luciano Fontana, «Corriere della Sera», 21 dicembre 2020, p. 37)
«C’è un’ampia letteratura sulla relazione infausta fra il proporzionale e la crescita della spesa pubblica (cattiva)» (Ferruccio De Bortoli, «Corriere della Sera» 24 gennaio 2021, p. 24)
«Perché il proporzionale è un passo indietro» (Risponde Aldo Cazzullo, «Corriere della Sera», 26 gennaio 2021, p. 29)
«Il proporzionale non funziona l’aveva già capito De Gasperi» (Risponde Aldo Cazzullo, «Corriere della Sera» 3 febbraio, p. 27)
Non farò nessun riferimento alla tesi espressa da Antonio Polito qualche tempo fa sulle pagine del «Corriere della Sera»(1)* sulla necessità che in Italia ci sia finalmente «un governo uscito dalle urne». Tralascio i molti riferimenti negativi alla proporzionale che Paolo Mieli sparge regolarmente nei suoi articoli. Invece, sento di dovere portare all’attenzione dei lettori la davvero mitica conclusione di Francesco Verderami ad un suo articolo di ricognizione delle possibili leggi elettorali pubblicato poco più di un anno fa. L’orientamento dei riformatori della criticata Legge Rosato andava, scrisse Verderami, nella direzione di un sistema elettorale «proporzionale a turno unico». Il lettore deve immaginare la mia frenesia nel compulsare i molti libri sui sistemi elettorali alla ricerca della varietà di sistemi proporzionali a più turni: doppio, chi sa, forse, addirittura triplo. Ricerca fallita. Poiché, comunque, il discorso sulle leggi elettorali è destinato a tornare, sono certo che dire a «voce alta» alcune cose abbia una sua, non so quanto piccola, utilità. Intrattengo sempre la speranza/illusione che nel dibattito pubblico sia possibile mettere punti fermi dai quali fare passi avanti.
Poiché scrivo nei giorni delle consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato, prenderò le mosse dal lancinante interrogativo dolorosamente posto dal Direttore del «Corriere della Sera». Luciano Fontana lo precisa in questo modo: «in attesa della ricostruzione di veri partiti e di una solida classe dirigente (aspettativa frequentemente intrattenuta sulle pagine del «Corriere» anche dall’ex Direttore Ferruccio De Bortoli e da uno degli editorialisti di punta, Ernesto Galli della Loggia), si potrebbe intanto pensare a una legge elettorale che faccia scegliere ai cittadini non il proprio (di chi?) simbolo ma anche la coalizione di governo e il premier». Qualcuno, non il Direttore Fontana e nessuno degli autorevoli collaboratori e corrispondenti del suo quotidiano, potrebbe subito andare alla ricerca delle modalità di voto nelle oramai molte democrazie esistenti. In qualche paese, si è mai avuta una legge elettorale che consentisse e effettuasse l’elezione simultanea del premier e della coalizione di governo? La risposta è semplicemente: No. Dopodiché è possibile aggiungere alcuni utili elementi conoscitivi. Primo, nemmeno nelle repubbliche presidenziali e semipresidenziali l’elezione popolare del capo dell’esecutivo, da un lato, elegge una coalizione, dall’altro, dà vita ad un governo. Tanto negli USA: presidenzialismo, quanto nella Quinta Repubblica francese: semipresidenzialismo, gli elettori eleggono il capo dell’esecutivo. Poi, sono i due presidenti eletti a nominare i loro ministri, quello francese senza nessun vincolo costituzionale, quello USA dovendo ricevere dal Senato la ratifica delle sue nomine. Entrambi hanno un inconveniente, seppure di natura diversa. Il Presidente USA potrebbe trovarsi a fare i conti con l’assenza della maggioranza del suo partito in uno o in entrambi i rami del Congresso: governo diviso. Quello francese potrebbe essere confrontato e contrastato da una maggioranza a lui politicamente opposta nell’Assemblea nazionale (fenomeno che si presenta attualmente anche nel Portogallo semipresidenziale): coabitazione. Sogni infranti di dominio senza controllo, senza freni e contrappesi politici (e istituzionali).
In un solo sistema politico, quello di Israele, per tre volte, nel 1996, 1999, 2001, è stato eletto direttamente il Primo ministro, ma non la coalizione a suo sostegno. Poi la formazione del governo è tornata nel Parlamento, Knesset, come avviene nelle democrazie parlamentari da tempo memorabile, ovvero, da almeno due secoli se ci riferiamo alla Gran Bretagna e da più di un secolo se prendiamo in considerazione l’esperienza delle democrazie occidentali, in Europa e no. Come è costitutivo, per l’appunto, di tutte le democrazie parlamentari. I governi nascono in Parlamento. Possono trasformarsi in Parlamento. Muoiono in Parlamento, eventualmente risorgendo qualora abbiano i numeri a loro favore. Il Direttore Fontana fa riferimento alla sfiducia costruttiva, una delle più importanti innovazioni costituzionali contenuta nella Legge Fondamentale tedesca: «si fa cadere un governo se ce n’è un altro già pronto a sostituirlo». Palesemente e logicamente il voto di sfiducia costruttivo non potrebbe essere adoperato se il governo fosse stato eletto dal popolo. Comprensibilmente, non sarebbe politicamente consigliabile contrapporre il Parlamento al popolo né costituzionalmente coerente consentire ai parlamentari di trasformare tanto meno sostituire un governo «eletto dal popolo».
Di tanto in tanto qualcuno, negli anni Novanta Mario Segni, di recente, Matteo Renzi, sostiene che si potrebbe eccome eleggere il capo del governo nella modalità da entrambi definita «Sindaco d’Italia». Fraintendimenti e manipolazioni si combinano e si avvinghiano. Mi limito alle due critiche più facili da argomentare. La prima riguarda la «scala». Dovrebbe essere chiaro che eleggere un sindaco anche in un comune grande per numero di abitanti e per spazio geografico non è affatto la stessa cosa per quel che riguarda, ad esempio, la campagna elettorale di partiti e candidati e la formazione delle opinioni degli elettori/trici. In secondo luogo, l’elezione popolare diretta del sindaco/capo del governo comporterebbe il cambiamento della forma di governo che da parlamentare diventerebbe (semi-)presidenziale, naturalmente, implicherebbe e comporterebbe anche un vasto procedimento di modifiche costituzionali concernenti non soltanto il Governo, ma il Parlamento e, soprattutto, i poteri del Presidente della Repubblica. Va subito aggiunto che, come nei (semi)-presidenzialismi, gli assessori delle compagini di governo locali non sono affatto votati dagli elettori e che la forma di governo «Sindaco d’Italia» è rigida. Se per qualsiasi ragione cade il sindaco, si torna ad elezioni.
Poiché ripetutamente, senza mai essere contraddetto, Matteo Renzi ha sostenuto la proposta del sindaco d’Italia come se implicasse il ricorso ad un sistema elettorale maggioritario, mi affretto a segnalare che la legge elettorale utilizzata per i comuni sopra i 15 mila abitanti è una legge proporzionale. Viene conferito un premio in seggi al sindaco eletto al secondo turno/ballottaggio per consentirgli di acquisire una maggioranza operativa nel Consiglio comunale. In molti ballottaggi, un partito del 2,5-3 per cento, come Italia Viva, potrebbe risultare decisivo. In conclusione, detto a voce alta, non siamo comunque di fronte ad un sistema elettorale maggioritario, ma a una fattispecie diversa che non può essere definita neppure sistema misto.
La discussione sui sistemi elettorali maggioritari ha avuto molto minor rilievo e spazio di quello dato di recente dato alla critica delle leggi elettorali proporzionali. Tuttavia, a scanso equivoci, alcuni elementi vanno segnalati a voce alta. La versione della Legge Mattarella (1993) per l’elezione del Senato, derivante dal quesito referendario approvato da quasi 30 milioni di elettori (l’82,7 per cento), era maggioritaria in collegi uninominali per tre quarti dei seggi. Il recupero proporzionale per il rimanente quarto dei seggi premiava i migliori perdenti: sistema limpido senza nessuna opportunità e necessità di mercanteggiamenti. Il maggioritario a turno unico, lui sì, produce i suoi frutti migliori quando esistono due partiti strutturati in grado di vincere e di alternarsi periodicamente al governo: la mitica agognata alternanza. Curiosamente, nella vorticosa discussione sulle leggi elettorali, non ha fatto adeguata comparsa la riflessione sulle conseguenze di quelle leggi sui partiti e sui sistemi di partiti. Eppure, da un lato, questa discussione è stata impostata settant’anni fa in maniera eccellente dal grande studioso francese Maurice Duverger ed è stata proseguita da Giovanni Sartori con significative precisazioni e approfondimenti. Non la esplicito qui limitandomi a dire che neppure una legge maggioritaria inglese in collegi uninominali è garanzia di produzione automatica di bipartitismo.
Se i commentatori del «Corriere della Sera», Direttore incluso (ma il mio invito/ monito vale per tutti), fossero coerenti con il loro desiderio di evitare una legge elettorale proporzionale e di consentire agli elettori di contribuire alla formazione del governo, dovrebbero argomentare l’introduzione di una legge elettorale effettivamente maggioritaria. Non ricordo di avere visto nessun articolo in materia, mentre spesso sono comparse critiche al sistema elettorale maggioritario francese a doppio turno in collegi uninominali. La critica più pesante variamente formulata è che il secondo turno sarebbe un mercato delle vacche. Forse il primo a ricorrere a questa terminologia fu il grande storico cattolico democratico Pietro Scoppola a metà degli anni Novanta. Sbagliava. Presumo che non avesse mai visto (neanche nei film) né visitato un mercato delle vacche.
Di quel mercato ho già variamente tessuto le lodi che riproduco qui in stretta comparazione con il doppio turno francese. Le vacche sono in bella mostra; i candidati debbono farsi vedere nel collegio in cui competono. Nella grande maggioranza dei casi abitano lì. Non vengono paracadutati a meno che abbiano caratura e visibilità nazionali. I venditori sono egualmente noti e fanno quel lavoro da qualche tempo e da qualche tempo frequentano quel mercato. Da tempo i capi dei partiti hanno imparato che il loro compito consiste nell’individuare e nell’offrire le candidature più appropriate anche in quanto portatori/trici dell’immagine del partito. I compratori delle vacche hanno già visto quei venditori all’opera. Ne sanno valutare il grado di credibilità. Vanno da coloro di cui si fidano di più in base alle esperienze passate. A grandi linee gli elettori sanno a che cosa corrisponde ciascuna candidatura, che cosa rappresenta, che cosa potrà/saprà fare e non fare. Lo scambio commerciale avviene in totale trasparenza, talvolta «a voce alta»: tutti vedono tutto e sentono/ascoltano eventuali critiche, lamentazioni rimproveri, assicurazioni, suggerimenti. Al primo turno gli elettori scelgono la loro candidatura preferita. Se quella candidatura non vince e neppure passa al secondo turno, aiutati dalle dichiarazioni del candidato che non ce l’ha fatta (la vacca già venduta e non più disponibile) e del suo sponsor partitico si riorienteranno valutando anche i segnali e le informazioni provenienti dai mass media verso la candidatura che maggiormente rispecchia le loro preferenze sia di rappresentanza del collegio sia di partecipazione alla eventuale coalizione di governo. In ciascun collegio (in ciascun mercato locale) tutte queste informazioni circolano, sono e rimangono ampiamente disponibili.
In qualche modo, la superiorità del doppio turno sul turno unico all’inglese consiste proprio nella possibilità per l’elettorato di avere/acquisire maggiori informazioni e di cambiare voto a ragion veduta. Peraltro, è certamente possibile che nella maggioranza dei collegi uninominali inglesi (australiani, canadesi, degli USA) le informazioni siano comunque disponibili e abbondanti se la competizione avviene fra candidati che hanno una storia politica in quel collegio dove spesso c’è un candidato in carica, un incumbent. Per rifiutare il doppio turno di collegio non basta affermare in maniera molto erroneamente saccente che nel nostro (italiano) DNA ci sarebbe la proporzionale. È un’affermazione che deriva da una limitata conoscenza della storia, non solo politica, italiana. Dal 1861 al 1919 gli italiani (e i sabaudi anche prima del 1861) hanno votato in collegi uninominali. Lo hanno fatto anche nel 1994, 1996 e 2001. Insomma, quantomeno potremmo sostenere che il nostro DNA accoglie una pluralità di geni.
Silenziosi oppure contrari ai sistemi elettorali provatamente maggioritari esistenti, molti commentatori deprecano quello che chiamano il «ritorno alla proporzionale». Detto che la vigente Legge Rosato già assegna due terzi dei seggi con riferimento proporzionale ai voti ricevuti e che, quindi, il «ritorno» degli italiani alla proporzionale non sarebbe un fenomeno tanto dirompente, sono le motivazioni del gran rifiuto che appaiono a dir poco preoccupanti. Comincio con l’ex Direttore De Bortoli che, facendo riferimento ad un articolo di alcuni economisti pubblicato nel 2007, ci informa che «un passaggio da maggioritario a proporzionale puro aumenta nel medio periodo del 5 per cento la spesa pubblica». Rilevo che, primo, De Bortoli non può riferirsi all’Italia poiché in questo paese non esiste il «maggioritario»; secondo, che l’unico caso che conosco di passaggio da maggioritario a proporzionale (sul «puro» scriverò infra) ebbe luogo ad opera del Presidente socialista François Mitterrand nel 1985. Poi il gollista Chirac vinse le elezioni parlamentari del 1986 e immediatamente ripristinò il maggioritario. Troppo poco tempo per accertare se ci fu un aumento di spesa pubblica del 5 per cento. Quanto all’aggettivo «puro» che connoterebbe un sistema elettorale proporzionale, nella letteratura internazionale sui sistemi elettorali non esiste. Supponendo che puro significhi senza nessuna soglia minima di voti per accedere al Parlamento, esistono soltanto due casi, Israele (popolazione di circa 9 milioni) e Olanda (meno di 18 milioni di abitanti), di circoscrizione unica nazionale. L’Olanda non ha nessuna soglia di accesso. Per evitare la frammentazione del sistema dei partiti, Israele ha recentemente introdotto una soglia del 3,25 per cento, quindi la sua proporzionale è corretta (impura?).
Per fortuna, Aldo Cazzullo ha almeno due importanti certezze: primo, «il proporzionale è un passo indietro». Se il confronto è con la legge Mattarella in larga parte prodotta dal referendum abrogativo del 1993, non si può dargli torto. Se il termine di confronto è la Legge Rosato non è possibile affermare che «il proporzionale» sarà un passo indietro poiché molto/tutto dipende da quale tipo di proporzionale e dalle sue clausole. La seconda certezza di Cazzullo ha basi fragilissime e friabilissime: «Di sicuro il proporzionale, se andrà in porto, servirà di più agli interessi particolari e alla libertà di manovra dei vari leader che alla partecipazione e al potere decisionale degli elettori». Provando a spacchettare questa affermazione vedo un proporzionale indefinito (dimensione delle circoscrizioni, esistenza di clausole di accesso/esclusione, formula per l’attribuzione dei seggi), quindi non valutabile. Sembra che Cazzullo ritenga che tutti, ovunque e comunque, i sistemi elettorali proporzionali (ne esiste una notevole varietà) servono agli interessi particolari e alla libertà di manovra dei vari leader». Anche, per esempio, in Germania? Non so (è una espressione retorica) quanto i «vari leader» di tutte le democrazie dell’Europa occidentale, ad eccezione della Francia e della Gran Bretagna, sarebbero disponibili a vedere nelle leggi elettorali proporzionali che usano da molti decenni e, nei paesi nordici, ininterrottamente da quasi un secolo e mezzo, uno strumento per i loro interessi particolari e la loro libertà di manovra e non piuttosto per dare buona e adeguata rappresentanza parlamentare e politica ai loro cittadini accompagnata da soddisfacenti percentuali di votanti e dalla possibilità di creare nuovi partiti e accedere al parlamento superando le soglie anti-frammentazione che pure esistono. Quanto «al potere decisionale degli elettori» confesso di non capire a che cosa si riferisca Cazzullo (e non voglio pensare che si riferisca all’elezione del governo, o sì?) Come si estrinseca quel potere decisionale? In quale paese o paesi gli elettori hanno maggiore potere decisionale? Si potrebbe aprire qui una bella pagina nella quale discutere delle modalità di scelta dei candidati, della democrazia interna ai partiti, dell’esistenza o meno del voto di preferenza (preferenza unica: remember il referendum del giugno 1981 con Craxi che suggerì di andare al mare?), delle scandalose candidature plurime. Another time another place.
Quello che è sicuro, secondo Cazzullo, è che «il proporzionale non funziona l’aveva già capito De Gasperi». Ridurre la storia di un episodio importante come quello della formulazione e dell’utilizzazione nonché del fallimento della legge del 1953, dalle opposizioni giustamente definita «truffa», al «non-funzionamento» del proporzionale richiede una notevole dose di coraggio. Immagino lo sconcerto dalla Svezia al Portogallo, dalla Norvegia alla Spagna, di fronte al giudizio senza appello «avete usato già fin troppo a lungo una legge elettorale che non funziona». Dopo la smarrimento iniziale, qualcuno potrebbe ipotizzare che sono i premi di maggioranza innestati su sistemi elettorali proporzionali: Legge Scelba del 31 marzo1953: Legge Calderoli del 2005; Legge Italicum del 2016, che non «funzionano». Poi, quel qualcuno dovrebbe spiegare che cosa significa il «non-funzionamento» di una legge elettorale. Non è affatto vero che, come scrive Cazzullo, De Gasperi capì che «il proporzionale puro non funziona». Al contrario, funzionava benissimo per dare rappresentanza ai partiti che si presentavano alle elezioni. Il problema era l’indebolimento dei partiti della coalizione centrista (PLI, DC, PRI, PSDI) al governo e la crescita, peraltro non irresistibile (che qualsiasi proporzionale mantiene lenta) del Movimento Sociale Italiano accompagnata dalle pressioni di non pochi cardinali italiani su De Gasperi affinché si predisponesse ad accogliere i neo-fascisti nella coalizione di governo. Il premio di maggioranza, che sarebbe stato dato ad una coalizione che, dichiaratasi tale, avesse ottenuto almeno il 50 per cento dei voti, serviva a rendere il centrismo totalmente svincolato dalla necessità di fare affidamento su altri partiti, a cominciare proprio dal MSI, e del tutto indipendente da pressioni esterne a cominciare da quelle del Vaticano.
Concluderò a voce alta. Se i comunicatori utilizzano una corazzata come il «Corriere della Sera» trasmettendo informazioni parziali, superficiali, leggermente manipolate, ad arte o per insufficienti conoscenze, fuorvianti quando non addirittura sbagliate in modo clamoroso, come potranno mai i lettori migliorare le loro conoscenze sulle regole del gioco e diventare buoni cittadini?
Coda: con quale sistema elettorale riusciremo ad avere il «governo dei migliori»? Questo è il tema posto con forza dal momento del conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio al Professor Mario Draghi la cui azione è destinata, secondo non pochi commentatori politici anche del «Corriere della Sera» addirittura a ristrutturare la politica che si sarebbe distrutta con la caduta del governo Conte. Mantengo tutta la distanza possibile da entrambe le tesi.
(1)* Faccio esclusivo riferimento al «Corriere della Sera» e ai suoi giornalisti poiché è il quotidiano che in questi anni ha dato maggiore spazio alle tematiche istituzionali incorrendo, più o meno inevitabilmente, in una serie di inesattezze e di errori anche gravi. Naturalmente, sarò (in una in-certa misura) lieto se si aprisse un confronto.
L’impasse di Letta @formichenews
“Non è con il contrasto a Salvini che gli si strappano voti, comunque pochi. Piuttosto è con la proposta di soluzioni formulata da dirigenti e candidati credibili. Il commento di Gianfranco Pasquino“
Pubblicato il 16/05/2021 con il titolo Letta non è una cicala. La versione di Pasquino su formiche.net
Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha scelto di lottare su due fronti. Il primo è quello, quasi, ma non del tutto inevitabile, sul quale combatte Salvini. Il secondo è quello, meno visibile, ma, di gran lunga più importante, della costruzione di un partito attivo. Sì, uso proprio quest’aggettivo poiché la grande maggioranza del ceto dirigente democratico, donne largamente comprese, quietate con la “conquista” delle cariche di capogruppo alla Camera e al Senato, mi pare appagata e attende passivamente il dipanarsi degli eventi. I ministri se ne stanno tranquilli al governo. Forse, è il loro modo di cooperare alla sospensione della politica per non fare barcollare il governo Draghi. Di iniziative, non dico dirompenti, ma significative, ad opera dei parlamentari non se ne vedono, tranne, forse, la creazione di una associazione ad opera di Paola De Micheli, ex-ministro.
A livello locale, esistono, come dovrebbe essere noto anche a Letta, diversi partiti con dirigenti abilissimi nel (ri)posizionamento, meno nel fare crescere il consenso attraverso qualche iniziativa originale. Di queste iniziative, almeno nelle città: Milano, Torino, Bologna, Napoli e, nient’affatto ultima, Roma, il partito avrebbe proprio bisogno. Invece, per lo più, ma sono probabilmente influenzato dal caso di Bologna, il partito è in stallo, come anche a Roma e a Napoli, oppure scalcia, come a Bologna. I sondaggi dicono che lo scalciare non paga e il Partito Democratico rimane tristemente intorno al 20 per cento delle intenzioni di voto che nessun mago delle coalizioni riuscirà a fare diventare maggioranza di seggi nel prossimo Parlamento neppure con la più solida e stretta alleanza con le Cinque Stelle calanti.
Per suggerire la necessità di andare oltre il duetto PD/5 Stelle non c’è bisogno di un grande stratega — quello che tale viene definito non mi sembra avere delineato percorsi altrimenti inesplorati. Comunque, Letta ambisce ad essere stratega di se stesso,. No, non mi permetterei mai di fare riferimento all’Ulivo con tutte le vestali pronte ad attaccarmi poiché nel passato fui molto critico delle modalità con le quali si ridusse ad operare, ma Letta deve perseguire fermamente e fortemente un allargamento della coalizione. Con un italiano su tre che ha cambiato voto in tutt’e tre le elezioni più recenti, con enormi sacche di insoddisfazione un po’ dappertutto nel paese, è imperativo correre sul territorio sollecitando, interloquendo, invitando tutto quello che si muove. Non è con il contrasto a Salvini che gli si strappano voti, comunque pochi. Piuttosto è con la proposta di soluzioni formulata da dirigenti e candidati credibili.
Il modo con il quali i dirigenti del PD bolognese si contrappongono a Isabella Conti che farà le primarie per diventare sindaco di Bologna non segnala nulla di buono. Da un lato, sta la preferenza per il candidato del partito, non l’interpretazione corretta del valore aggiunto che può essere apportato dalle primarie. Dall’altro, il quasi respingimento della Conti in quanto ex-renziana che porterebbe alle urne anche settori di elettorato di centro-destra, come se la conquista dei renziani e di quegli elettori di centro-destra non debba essere un compito da svolgere con successo. Sì, a Bologna, non da oggi e neppure da ieri, ma almeno dal 1999, ne hanno fatte di tutti i colori, ma, proprio per questo, il segretario Letta non dovrebbe schierarsi né a favore dell’enfant du parti né contro colei che viene “da fuori”, ma per le primarie fatte secondo le regole e le procedure. Non sarebbe solo una lezione di metodo e di stile, ma di una politica aperta e inclusiva, proprio quella da lanciare anche a livello nazionale. Per chi suona la campana?
Perché Giorgia Meloni piace tanto e non solo a destra @DomaniGiornale
Cedo subito alla tentazione di un paragone significativo. Mentre noi italiani guardiamo con interesse e maggiore o minore preoccupazione all’ascesa di Giorgia Meloni, a fare notizia in Germania è la crescita di consensi per la verde Annalena Baerbock. Fratelli d’Italia, guidata da Meloni, si avvia al 18 per cento; i Verdi di Baerbock sono arrivati al 28 per cento e sembrano destinati ad essere il partito che deciderà il prossimo governo della Germania. Quel governo, sicuramente e fortemente europeista, non piacerà a Meloni che, tutte le volte che può, dichiara la sua preferenza per la variante ungherese rappresentata da Orbán. Saldamente insediata alla guida dei Conservatori e Riformisti Europei, in larga misura contrari all’Europa che c’è, ma anche sostanzialmente irrilevanti, Meloni afferma di essere “per un’Europa confederale, che decide le grandi cose, e sulle altre lascia libertà agli Stati”. Iniziata la Conferenza sul Futuro dell’Unione Europea, la leader di Fratelli d’Italia ha un’occasione propizia di fare valere le sue idee in maniera del tutto trasparente e di sottoporre a critica quanto quegli europei, che desiderano un’Unione ancora più stretta, sapranno proporre.
Ciò detto, il consenso italiano per Fratelli d’Italia dipende solo in piccola parte dalle posizioni anti-europee: l’elettorato non è tenuto a cogliere le sottili distinzioni fra l’UE com’è e l’Europa eventualmente confederale. L’ascesa di Giorgia Meloni è una storia tutta italiana. Nel degrado e nel declino complessivo dei partiti, Fratelli d’Italia ha comunque saputo mantenere un prezioso aggancio con quello che era stato un partito piccolo, ma con radicamento: il Movimento Sociale Italiano. Meloni lì nasce e lì cresce meritandosi i complimenti per avere conquistato spazio personale e agibilità politica in un organismo di uomini (tuttora) maschilisti. Il resto sembra in misura quasi eguale un misto fra doti di carattere e intelligente sfruttamento delle opportunità. Il carattere è quell’elemento, importante e nella politica italiana abbastanza poco frequente, che spiega la coerenza finora espressa da Meloni. Nessuna impennata nessuna giravolta nessun inseguimento di novità: Meloni è rimasta fedele alle sue idee, destra nazionale e, in fondo, tradizionale (che ha troppa contiguità con Casa Pound e Forza Nuova). Un po’ di sovranismo, che è il nazionalismo trasferito a Bruxelles, ma quasi niente populismo, consegnato largamente a Salvini (ma che, talvolta, fa capolino nei berluscones). In una certa misura, è lo stesso Salvini che, con il suo marcato opportunismo e esibizionismo, continua ad offrire opportunità di crescita a Giorgia Meloni. Le critiche salviniane al governo di cui fa parte sono tanto frequenti e tanto simili a quelle di Meloni che una parte dell’elettorato pensa che allora è meglio confluire su Fratelli d’Italia. Altri elettori in uscita dal Movimento 5 Stelle trovano nei Fratelli d’Italia l’organizzazione più credibile per esprimere sia l’insoddisfazione per la politica italiana sia il dissenso nei confronti del governo Draghi. Poiché, coerentemente, Giorgia Meloni non è entrata nella fin troppa ampia coalizione di governo, gode adesso di quella che chiamo “rendita d’opposizione”. Ė una rendita che si sta rivelando cospicua e che è destinata a durare. So che dovrei concludere mettendo in guardia dai rischi di un governo prossimo venturo guidato dalla non europeista Giorgia Meloni. Sarebbe inevitabilmente e preoccupantemente un governo di centro-destra i cui guai, a mio parere, verrebbero dalle ambiguità e dalle ambizioni di Salvini, anche e soprattutto se la competizione per la leadership fosse vinta, seppur risicatamente, proprio da chi guida Fratelli d’Italia.
Pubblicato il 12 maggio 2021 su Domani
Las Ciencias Políticas y Sociales ante Contingencias de Amplio Impacto. Incógnitas y Propuestas #webinar #11demayo 11:00 – 12:40 México; 18:00 – 19:40, Bolonia, Italia @iapasfs
LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS Y ESTUDIOS DE FUTURO, A.C. Y SUS CAPÍTULOS ESTATALES DE TAMAULIPAS, SONORA, QUINTANA ROO, PUEBLA, CHIAPAS, TLAXCALA Y EL ESTADO DE MÉXICO; EL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA Y EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
PRESENTAN EL LIBRO:
Las Ciencias Políticas y Sociales ante Contingencias de Amplio Impacto.
Incógnitas y Propuestas
Martes 11 de mayo, 2021, 11:00 – 12:40 México; 18:00 – 19:40, Bolonia, Italia
11:47 – 12:05 Comentarios del Dr. Gianfranco Pasquino.
Profesor e Investigador de la Universidad de Bolonia, nombrado profesor emérito en 2014. Enseñó 5 años (1970/1975) en la facultad de Ciencias políticas “Cesare Alfieri” de Florencia, en la School of Advanced International Studies de Washington, D.C., en la Harvard Summer School, en la Universidad de California, Los Angeles. Fue Fellow de ChristChurch y St Antony’ s en Oxford y es Life Fellow de Clare Hall, Cambridge; autor de multiples libros, artículos científicos y ensayos.
Link zoom https://zoom.us/j/91835343511?pwd=Nms2Ym9qYlgvS0U1VThoMHFQYWRqZz09#success
Democrazia Futura. Da partiti pigliatutto al vuoto, gli effetti della trasformazione della forma-partito oggi @Key4biz
Gli effetti della trasformazione dei modelli di partito oggi, Democrazia Futura entra nel vivo con una riflessione sul tema “Effetto Draghi”. Prove tecniche di post-democrazia sobria e di restaurazione di un’etica pubblica.
Nel 1966 fu pubblicato postumo un articolo che per qualche decennio ha segnato l’analisi delle trasformazioni dei partiti fino ad oggi (1). L’autore, Otto Kirchheimer, Professore di Government alla Columbia University, era uno degli scienziati sociali e politici della Scuola di Francoforte che aveva dovuto lasciare la Germania di Hitler. Socialdemocratico, autorevole studioso della Costituzione di Weimar, aveva contrastato con vigore il pensiero di Carl Schmitt. Nel suo breve saggio, Kirchheimer sostenne che i partiti di massa di classe, socialisti e comunisti, e confessionali, le Democrazie cristiane, in Francia, Germania e Italia stavano diventando partiti pigliatutti (2). Con nostalgia per quel partito di massa, l’autore individuava cinque grandi cambiamenti in corso, anzi, in stadio avanzato: a) drastica riduzione del bagaglio ideologico; b) rafforzamento dei gruppi dirigenti di vertice e valutazione delle loro azioni e omissioni dal punto di vista dell’identificazione, non con gli obiettivi del partito, ma con l’efficienza dell’intero sistema sociale; c) diminuzione del ruolo del singolo iscritto; d) minore accentuazione di una specifica classe sociale o di una platea religioso-confessionale per reclutare invece elettori tra tutta la popolazione; e) apertura all’accesso di diversi gruppi di interessi. Quasi subito si aprì nel contesto italiano una colluttazione fra i comunisti, che negavano qualsiasi loro scivolamento verso il partito pigliatutti, e esponenti della sinistra non comunista che in parte lo criticavano per la perdita di slancio al cambiamento sociale e per l’integrazione nel sistema e in parte lo auspicavano. Quello che è successo in seguito, un po’ dappertutto, anche se in maniera diseguale, ai partiti di massa delle democrazie dell’Europa occidentale, conferma che Kirchheimer aveva colto una tendenza fondamentalmente inarrestabile.
La riflessione sui fattori che avevano dato inizio alla tendenza è stata forse meno approfondita del necessario. In estrema sintesi, sempre con la nota di cautela che le condizioni iniziali erano alquanto diverse da paese a paese e da partito a partito, fra quei fattori spiccavano le nuove modalità di comunicazione grazie alla diffusione della televisione, la prosperità conseguita e diffusa, i mutamenti nelle classi sociali a partire dalla classe operaia, i processi di secolarizzazione. Quello che non apparve chiaramente allora e che anche in seguito non è stato, a mio parere, sufficientemente studiato, è che quei partiti di massa non erano e non avevano mai voluto essere organizzazioni puramente elettorali. Fra i loro compiti avevano inserito e esercitato quelli relativi al reclutamento di iscritti, alla loro educazione politica, alla selezione di dirigenti e candidati alle cariche elettivi. I partiti pigliatutti si erano dati altri obiettivi distanti e talvolta molto differenti, sostanzialmente meno impegnativi di quelli perseguiti dai partiti di massa, di classe e confessionali.
Praticamente negli stessi anni in cui scrisse Kirchheimer, si era affacciata una ambiziosa spiegazione della nascita e del consolidamento dei partiti in Europa occidentale basata sulle fratture sociali e, in parte, politiche: Stato/Chiesa; centro/periferia; città/campagna; imprenditori/lavoratori. Esposta per la prima volta congiuntamente dall’americano Seymour M. Lipset e dal norvegese Stein Rokkan (3) questa tesi fu poi perfezionata e ampiamente utilizzata dal solo Rokkan. La combinazione variegata di quelle fratture aveva dato vita ai sistemi di partito che, consolidatisi già all’inizio degli anni Venti del ventesimo secolo, erano riusciti a durare attraversando tempi difficilissimi senza cambiamenti di rilievo (ad eccezione della nascita del Partito gollista, fondatore della Quinta Repubblica francese) fino alla metà degli anni Sessanta –proprio gli anni nei quali stavano emergendo i partiti pigliatutti. Implicita nella tesi di Lipset e Rokkan stava la necessità di vere e profonde fratture sociali per la comparsa di nuovi partiti (anche se Rokkan riconobbe che alla base dei partiti fascisti e comunisti si trovavano fratture eminentemente politiche). Qui mi corre l’obbligo di mettere in evidenza che Sartori non aderì mai alla tesi di Rokkan, sostenendo piuttosto, in linea con una più che convincente interpretazione del pensiero di Max Weber in materia e anche di Schumpeter, che i partiti sono il prodotto della abilità/volontà di un imprenditore politico che sfrutta le circostanze e utilizza lo spazio politico esistente.
Quello che è certo è che i partiti nati nei decenni successivi non sembrano avere un collegamento solido con qualche importante frattura sociale tranne, forse, quella industrialismo/ambientalismo che, infatti, ha dato vita a partiti verdi, anche se, nella maggioranza dei casi, non di grande successo elettorale e politico. Non mi spingerei fino a sostenere che esista una frattura “europeismo/sovranismo” e che sia di portata tale da ristrutturare i sistemi di partito delle democrazie europee, ma, forse, è prematuro discettare in proposito.
Partito è, nelle parole di Sartori che cito a memoria, un’organizzazione di uomini e donne che presenta candidature alle elezioni, ottiene voti, vince cariche. Fra queste cariche, le più ambite sono, ovviamente, quelle di governo. Kirchheimer si era fondamentalmente preoccupato del ruolo di rappresentanza politica delle preferenze degli elettori e del compito sociale e pedagogico del partito di massa. Da molto tempo, però, soprattutto in Gran Bretagna, l’attenzione degli studiosi era stata dedicata allo studio dei partiti che andavano al governo e ai loro comportamenti: party government. Peraltro, un po’ dappertutto le democrazie erano effettivamente casi di party government nei quali: “1. Le decisioni sono prese da personale di partito eletto (a cariche di governo) o da soggetti sotto il suo controllo; 2a) le politiche pubbliche sono decise all’interno dei partiti che 2b) poi agiscono in maniera coesa per attuarle; 3a) i detentori delle cariche sono reclutati e 3b) mantenuti responsabili attraverso il partito” (4). La Repubblica italiana, nella quale tutti questi criteri avevano trovato applicazione concreta, è sicuramente stata un caso di “governo di partito” dal 1946 al 1992, persino nella sua degenerazione chiamata partitocrazia. (5)
Fra il 1994 e oggi nel caso italiano è andato perso tutto quello che, in conformità con le teorie e con le pratiche esistenti nelle democrazie occidentali, aveva funzionato soddisfacentemente fino allo smantellamento del Muro di Berlino 1989 (sì, asserisco anche l’esistenza di consequenzialità post hoc ergo propter hoc). Tutti i partiti, che per lo più rifiutano persino questo appellativo, sono oramai pigliatutti. Nessuno di loro svolge qualsivoglia attività pedagogica (le “scuole” sono balletti per le ledearship, esibizioni festaiole), di produzione di cultura politica. I loro meccanismi di reclutamento e di selezione funzionano poco, saltuariamente, male, a scapito del ruolo e della partecipazione degli iscritti. Per lo più i partiti italiani hanno e manifestano caratteristiche “personalistiche” con l’accentuazione della visibilità del leader proprio come evidenziato e lamentato già da Kirchheimer. Quanto al “governo di partito”, gli esperimenti dei governi non-politici, ma affidati a personale sostanzialmente privo di appartenenze e esperienze politiche (Ciampi; Dini; Monti; Draghi), stanno a dimostrare che quel tipo di governo viene spesso messo in soffitta. La questione non è che i governi non-politici non sono eletti da nessuno/non escono dalle urne, come perseverando nell’errore costituzionale grave, affermano imperterriti alcune grandi firme e lo stesso Direttore del Corriere della sera. La vera questione è che quei governi e molti loro ministri sono tecnicamente “irresponsabili”. Non hanno un elettorato di riferimento, non dovranno tornare a chiedere il voto agli elettori assumendosi la responsabilità di quello che hanno fatto, non hanno fatto, hanno fatto male. Anche in questo modo si svuotano le democrazie. (6)
*Gianfranco Pasquino è Professore Emerito di Scienza Politica dell’Università di Bologna e Accademico dei Lincei. Il suo libro più recente è Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana (UTET 2021).
Pubblicato il 6 maggio 2021 su Key4biz
Gli intellettuali europei non si occupano più d’Europa #CoFoE @DomaniGiornale

Con una (in)certa regolarità gli intellettuali vengono (giustamente) criticati per i documenti che firmano, per le frasette che twittano, per quello che dicono nei salotti televisivi. Spesso sono intellettuali contro intellettuali. Qui, invece, indirizzerò il tiro della critica ad un loro grave silenzio, quello che riguarda l’Unione Europea, l’Europa. Domenica 9 maggio, 71esimo anniversario della dichiarazione del Ministro degli Esteri francese Robert Schumann che portò alla nascita della Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio (CECA), prenderà il via una ambiziosa Conferenza sul Futuro dell’Europa. La Commissione europea intende così perseguire gli obiettivi di “coltivare, proteggere, rafforzare la democrazia europea”, mirando a coinvolgere al massimo i cittadini europei in una molteplicità di modi, fino a forme di democrazia deliberativa che ne incoraggino e valorizzino la partecipazione e l’influenza sulle decisioni europee. Non ho letto, non ho sentito, non ho visto commenti rilevanti ad opera degli intellettuali europei. Non ne sono sorpreso.
Sono passati tantissimi anni da quando il grande studioso Raymond Aron, tanto raffinato quanto scettico, scrisse il libro In difesa di un’Europa decadente (Mondadori 1978) criticando più o meno indirettamente i suoi colleghi non solo francesi. Probabilmente, l’esempio più alto di discussione fra intellettuali pubblici e di analisi e proposta fu scritto dal sociologo Ralf Dahrendorf, tedesco, e dagli storici François Furet, francese, e Bronislav Geremek, polacco: La democrazia in Europa (Laterza 1992). L’assenza di un intellettuale italiano non è causale, ma riflette lo stato dell’arte. I grandi intellettuali italiani si sono sostanzialmente disinteressati dell’unificazione politica europea, che, pure, è un evento di portata “epocale”. Studiosi certamente tutt’altro che provinciali, presenti e famosi sulla scena europea, frequentemente invitati a importanti convegni, come Umberto Eco, Norberto Bobbio, Giovanni Sartori, non hanno dedicato nessuno studio specifico alla cultura e alla politica europea. Difficile spiegare il loro disinteresse. Hanno dato per scontato il processo di unificazione europea? Erano delusi dalla sua apparente lentezza? Non ne ritenevano importanti le acquisizioni in materia di pace, di diritti, di democrazia che motivarono l’assegnazione all’Unione Europea del Premio Nobel per la Pace nel 2012?
Neanche i grandi scrittori italiani, faccio solo due esempi: Leonardo Sciascia e Claudio Magris, hanno dedicato la loro attenzione letteraria e culturale e le loro non rare prese di posizione politica alla discussione dell’Europa che c’è, alla progettazione dell’Europa che vorrebbero. Questa assenza degli intellettuali che riflettano sull’Europa, che contribuiscano al dibattito pubblico, che arricchiscano il discorso su quel che viene fatto bene, non viene fatto, è stato fatto male, non riguarda, però, soltanto gli italiani. Ė possibile sostenere che l’ultimo grande influente intellettuale che si confronta con l’Europa, che ha una certa idea di Europa è l’ultranovantenne sociologo e filosofo tedesco Jürgen Habermas. Mi viene in mente soltanto un altro nome, quello del saggista Timothy Garton Ash, di Oxford, autore di notevoli libri sulle opposizioni nei regimi comunisti dell’Europa centro-orientale e sull’imperfetta transizione di quei paesi alla democrazia. La Conferenza sul Futuro dell’Europa avrà tanto più successo quante più idee entreranno in circolazione. Ė una grande opportunità anche per gli intellettuali europei di dimostrare che intendono e sanno contribuire ad un futuro migliore.
Pubblicato il 5 maggio 2021 su Domani
Tutti riformisti #parole @Mondoperaio #Aprile2021
Le riforme fanno il riformismo e il riformismo fa le riforme. Nessuno più contrappone il riformismo alla rivoluzione. Semmai, oggi, il contrasto sta fra coloro che ritengono che il termine riformismo possa legittimamente essere applicato alle attività e alle scelte di coloro che cambiano l’esistente per andare oltre e coloro che ugualmente cambiano l’esistente nel tentativo più o meno esplicito di tornare alla fase precedente, di riportare indietro le lancette dell’orologio. Qualsiasi restaurazione richiede, non importa con quali motivazioni, di fare cambiamenti. Perché quei cambiamenti, chiedono i restauratori facendo l’omaggio del vizio alla virtù (sic!), non dovrebbero meritare la definizione di riforme? Ma, questa è, invece, la mia personale domanda, non sarebbe preferibile utilizzare il termine contro-riformismo per definire i cambiamenti che eliminano e distruggono le riforme fatte? Quello che sembra giustamente preoccupare i riformisti è la necessità di definire con precisione il contenuto e la qualità delle riforme rispetto ai “semplici” cambiamenti dei più vari generi e tipi. Si potrebbe sostenere che cambiamento è qualsiasi movimento dallo status quo, dunque, anche il ritorno alla situazione precedente. Poiché, però, il termine contro-riformismo esiste, credo se ne debba fare un uso accorto. Il problema mi pare piuttosto quello di precisare quali cambiamenti meritino la definizione di riforme e quali insiemi/pacchetti di riforme possano essere caratterizzate come riformismo. Qui, un cenno alla rivoluzione è opportuno, vale a dire, la sottolineatura che si ha rivoluzione quando un intero assetto politico, sociale, economico viene capovolto. Poi, nella versione che Trotskij voleva attuare, la rivoluzione può tentare di diventare/essere permanente costruendosi sui cambiamenti già prodotti e perseguendone altri. La rivoluzione potrebbe anche venire periodicamente rilanciata come fece Mao Tse-tung dagli anni cinquanta agli anni settanta del XX secolo. Tuttavia, il punto discriminante rimane: la rivoluzione non si accontenta mai di alcuni cambiamenti per quanto importanti, ma mira alla distruzione dell’insieme di rapporti politici, sociali, economici esistenti per costruirne di nuovi, dirompenti a cominciare dal vertice, dai detentori del potere politico. Incidentalmente, sappiamo che spesso il riformismo “realizzato” è stato accusato proprio di non avere cambiato i rapporti politici. Lascio qui il discorso, che mi pare antico e obsoleto, sulla rivoluzione (ma mi permetto di rinviare alla voce Rivoluzione che pubblicai nel Dizionario di Politica, UTET, nel 1976 e che, imperterrito, ho mantenuto anche nella più recente edizione del 2016).
Ritorno da dove ho preso le mosse. Riformulo in chiave problematica: a quali condizioni riforme singole sparse nel tempo danno sostanza e vita al riformismo? Usando il lessico contemporaneo, la condizione dirimente è che esista una cabina di regia in grado di indirizzare e orientare ciascuna di quelle singole riforme verso un obiettivo predefinito sul quale raccogliere condivisioni. Quell’obiettivo non è mai una Minerva che scaturisce nella sua interezza dalla testa di Giove. Proprio per questo ritengo che sia necessario distinguere fra riforme singole, pure importantissime, e riformismo. Qui cito per esteso Bobbio secondo il quale, il riformismo politico è una “azione o insieme di azioni prolungatesi nel tempo, indirizzate al cambiamento in base a progetti a lunga o breve scadenza (in base cioè a un programma massimo o a un programma minimo)”. Di “progetto” parlerò oltre evitando qualsiasi distinzione fra minimo e massimo –anche perché il minimo può diventare, se non massimo, almeno moltissimo. Qui riparto dalle riforme il cui elenco Bobbio auspica e fa, ma con riferimenti soltanto al contesto italiano e a quelle, che condivido, del centro-sinistra (al quale, personalmente, attribuisco, almeno per quel che riguarda le intenzioni e le ambizioni dei socialisti di allora, la qualifica di “progetto”). In seguito, riforma singola fu certamente l’istituzione del Sistema sanitario nazionale con legge approvata nel dicembre 1978: riforma di notevole qualità. Tuttavia, esiterei molto, e alla fine mi esprimerei in maniera negativa, qualora si volesse definire riformista tutta l’esperienza del governo di solidarietà nazionale (1976-1978). Il taglio della scala mobile, 1984-85, fu certamente una riforma importante, ma il pentapartito non è mai stato definito da nessuno una coalizione riformista. Forse, a proposito di qualche riforma singola che segue altre riforme singole, gli americani parlerebbero di riformismo piecemeal, che tradurrò, anche per l’assonanza, con spicciolo, ma, per l’appunto, lo terrei distinto da quello che vorrei definire progetto riformista. Mi sento rafforzato in questa opinione/valutazione anche dall’Affordable Care Act, l’unica grande riforma del Presidente Obama, approvata nel marzo 2010, certamente una perla, unica e non facente parte di una “collana” riformista.
Per continuare nella metafora, le collane riformista sono inevitabilmente poco numerose nella storia dei sistemi politici democratici. Non esiste nessun riformismo nei regimi non-democratici. Pure in assenza di analisi comparate dei riformismi realizzati, credo che sia accettabile fare riferimento al New Deal di Franklin Delano Roosevelt, al quinquennio di governo del laburista Clement Attlee (1945-1950), alle esperienze socialdemocratiche scandinave dagli anni Trenta agli anni Sessanta del XX secolo, brillantemente analizzate da G. Esping Andersen (Politics Against Markets. The Socialdemocratic Road to Power, Princeton, Princeton University Press, 1985) e, si parva licet, al centro-sinistra italiano 1962-1970 (la datazione è tuttora controversa). Aggiungo il programma di riforme del Presidente Lyndon B. Johnson (1964-1968) noto come Great Society. Richiamo l’attenzione sulla contrapposizione fatta da Esping-Andersen della politica ai mercati. Servirà ad una migliore valutazione del ruolo dello Stato nel riformismo socialista. Evidenzio anche la del tutto consapevole intenzione di Johnson di ampliare gli spazi di liberà della società USA con le leggi sui diritti civili e diritti elettorali. Né le une, certamente socialiste, né le altre, certamente liberatrici, furono esempi di “riforme dal basso” che Bobbio sembrerebbe volere privilegiare come esemplari della sua concezione di riformismo che allarga gli “spazi di libertà”. Ci tornerò.
Straordinariamente diverse per tempo, luogo e protagonisti, queste esperienze presentano un importante elemento comune: sono il prodotto di un progetto. Qui ritengo appropriato evidenziare gli elementi comuni ai riformismi realizzati, ma altrove sono andato alla ricerca delle diversità: Varianti del riformismo (Bologna, Materiali di ricerca dell’Istituto Cattaneo, 1985). Il pensiero riformista, che non è mai necessariamente del tutto elaborato fin dall’inizio, ha preceduto e informato l’azione riformista. In parte è anche stato trasformato da quella azione e dalle reazioni. Mi sono spesso compiaciuto nell’affermare che il tratto fondamentale del riformista e, quindi, per derivazione, del riformismo, è la volontà/capacità di riformare le riforme. Potrei ricondurre questa affermazione e darle nobiltà facendo riferimento a quello che Karl Popper considera l’irrinunciabile criterio scientifico: la falsificazione delle teorie. Il riformista apprende dall’attuazione delle sue riforme tanto quello che funziona quanto quello che non funziona e traduce il suo apprendimento nella logica e conseguente riforma di quello che non ha prodotto i risultati attesi e voluti. Bobbio sembra suggerire come prospettiva di ricerca l’individuazione di progetti riformatori che non hanno prodotto riforme. Rimango aperto a suggerimenti in tal senso e a esempi. Non me né venuto in mente nessuno.
Al contrario di quanto sostenuto dal Presidente Ronald Reagan, a suo tempo (1980-1988) controriformista di notevole successo, il governo non è il problema, ma, a determinate condizioni, è abitualmente proprio il produttore delle soluzioni riformiste. In una certa misura, si apre qui il dibattito fra coloro che ritengono che il riformismo emerga da una società vivace e spumeggiante, incline alla sperimentazione, nella quale cambiano i costumi, le abitudini, gli obiettivi, e un, per lo più relativamente ristretto, gruppo di uomini e donne che hanno conquistato il potere politico e che lanciano il (loro) progetto riformista come azione di governo. Gli esempi di riformismi realizzati ai quali ho fatto riferimento in precedenza indicano molto chiaramente da che parte sto. Il riformismo è top down: offre proposte e soluzioni dal vertice del sistema politico. Naturalmente, non è pregiudizialmente chiuso e affatto ostile a quanto possa procedere bottom up. Bobbio vede una sequenza fatta da pluralismo, da conflitti fra gruppi e associazioni, fra idee e proposte, che si conclude con una sintesi che produce “decisioni selettive vincolanti”. Da chi se non dalla politica con l’incontro-scontro dei rappresentanti variamente sostenuti dal consenso elettorale e dei governanti che godono la fiducia della maggioranza di quei rappresentanti possiamo e dobbiamo aspettarci quella sintesi e le decisioni corrispondenti?
La buona politica riformista si esprime nell’accoglimento e nella selezione di quanto scaturito dai conflitti pluralisti (non dagli accordi corporativi), ma quei conflitti saranno tanto più “riformisti” quanto più incontreranno governanti che hanno già elaborato in proprio un loro insieme di idee che compongono a grande linee un progetto riformista. Non conosco esempi storici di società per quanto inquiete, dinamiche e diversificate che si siano rivelate capaci di lanciare, senza l’apporto di settori importanti del ceto politico e intellettuale, un’onda lunga caratterizzabile come riformismo. Al contrario, quando, peraltro raramente, quelle società hanno fatto la loro comparsa, se non esisteva una politica all’altezza, l’esito è stato molto diverso e lontano dal riformismo: ingovernabilità. Credo che si debba respingere fermamente la contrapposizione troppo spesso presentata senza conferme probanti fra società buona e Stato cattivo.
Ancora con riferimento agli esempi di cui sopra sono convinto che sia assolutamente indispensabile aggiungere che quegli uomini e quelle donne portatrici del progetto riformista sono accomunati dalla stessa appartenenza partitica. Non c’è mai stato riformismo in assenza di robuste organizzazioni partitiche. Anche se nel caso di FDR è evidente che il potere presidenziale svolse un ruolo importantissimo, alla sua base e come suo strumento stava un Partito Democratico che diede vita e sostanza ad una coalizione politico-elettorale in grado di ottenere vittorie elettorali ripetute nel tempo fino al 1968. In un certo senso, la Great Society è stata un vero e proprio canto dell’ultimo cigno democratico (lo rileva e analizza con acume e precisione John R. Petrocik, Party Coalitions: Re-alignments and the Decline of the New Deal Party System, Chicago, University of Chicago Press, 1981)
Da allora, gli USA non hanno più conosciuto riformismo come progetto anche se è possibile individuare singole riforme, in particolare durante i due mandati presidenziali di Bill Clinton (1992-2000). Il riferimento a quegli anni consente, anzi, invita a prendere in seria considerazione quella che in tempi recenti si è senza dubbio imposta come la più importante teorizzazione e ricerca di neo-riformismo: la Terza Via. Nel mezzo del cammin della Presidenza Clinton nasce in Inghilterra la ricerca di una Terza via fra il classico capitalismo e il vecchio laburismo. Sul piano intellettuale e culturale il suo artefice è il prestigioso sociologo politico Anthony Giddens, oggi Lord laburista, autore di alcuni influenti libri: Oltre la destra e la sinistra, Bologna, il Mulino, 1997; The Third Way, Cambridge, Polity Press, 1998; e The Third Way and Its Critics, Cambridge, Polity Press, 2000. Sul piano politico, i protagonisti sono Tony Blair e Gordon Brown, rispettivamente dal 1997 al 2007 Primo ministro e Ministro dell’Economia, poi, Brown anche Primo ministro dal 2007 al 2010 (ma la Terza Via s’era già smarrita).
Anche le “terze vie” formulate prima di Giddens si erano presentate come strategie riformiste. Vi fu una mitica terza via che intendeva collocarsi fra il comunismo stalinista e il riformismo socialdemocratico. Qualcuno ritenne di doverla cercare fra il capitalismo e il comunismo. Sono, invece, molto riluttante a pensare che la terza via si situasse fra il liberalismo e il socialismo e che potesse essere definita liberal-socialismo. Peraltro, sono consapevole che il dibattitto italiano, anche per merito/responsabilità di Bobbio contiene un’accezione/accentuazione liberal-socialista del riformismo. Fuori d’Italia il riferimento al liberal-socialismo è assente sarà anche perché sia in Germania sia in Gran Bretagna esiste un Partito Liberale, nel primo paese spesso al governo anche se poco riformista, nel secondo, anche se effettivamente riformista non abbastanza spesso politicamente rilevante.
Non è questo il luogo per rincorrere le terze vie tentate in altre parti del mondo, Italia compressa con la variante di poca durata e scarsa incisività detta Ulivo. Certo è che Giddens ne vedeva e auspicava le potenzialità di espansione/estensione a livello globale tanto contro il neo-liberalismo quanto contro il radicalismo (di sinistra). Per rendere breve una storia alquanto lunga, come dicono gli inglesi, l’unico dato certo è che, finita l’epoca della Terza Via, molto dibattuta anche se in alcuni luoghi neppure tentata, la sinistra, i suoi partiti, le sue organizzazioni, la sua capacità di elaborare idee e di prendere voti appaiono enormemente indebolite. Con riferimento al Partito Democratico USA, ai socialdemocratici, svedesi e tedeschi, e ai laburisti lo documenta criticamente in maniera comparata con qualche punte di nostalgia per un passato sostanzialmente irrecuperabile Stephanie L. Mudge, Leftism Reinvented. Western Parties From Socialism to Neoliberalism, Cambridge, Mass.-London, Harvard University Press, 2018.
Pur con tutte le critiche che, sia nella influente versione formulata da Giddens sia nelle peraltro non molte varianti nazionali, la Terza Via si è meritatamente attirate, è innegabile che abbia costituito un progetto riformista anche secondo i criteri ai quali ho fatto cenno in precedenza. Vale a dire che è stata formulata con l’apporto di intellettuali, acquisita da uomini politici con il loro partito giunto al vertice del sistema politico quindi in grado di utilizzare il potere di governo per attuare la visione e le politiche pubbliche riformiste. Questo è il momento in cui diventa indispensabile riflettere su entrambe: visione e politiche. Che cosa è una visione riformista e come è possibile stabilire quali politiche pubbliche sono effettivamente riformiste?
Del tutto consapevole della inevitabile problematicità di qualsiasi definizione della visione riformista sostengo che essa debba avere come criterio ispiratore l’allargamento, concordo con Bobbio, degli spazi di libertà. Mi fa anche molto piacere che il titolo dell’Avanti!, attribuito a Pietro Nenni, il 6 dicembre 1963 all’indomani della formazione del primo governo di centro-sinistra fosse: “Da oggi siamo tutti più liberi”. Dissento da Bobbio quando sembra sostenere che per allargare gli spazi di libertà è necessario limitare e restringere lo spazio del potere politico. Non dovremmo ragionare in termini di spazio per cui quello che si “concede” ai cittadini lo si toglie allo Stato e viceversa. Soprattutto, non dovremmo in nessun modo pensare che liberalismo sia Stato minimo. Certamente, non era questa la concezione di quel grande liberale che fu John Maynard Keynes. Chi cerca, in quanto rifomista, di utilizzare I’intervento dello Stato, per esempio, al fine di creare posti di lavoro, di accrescere l’istruzione dei cittadini, di costruire un sistema sanitario nazionale, non sta riducendo la libertà di nessuno, non sta infrangendo nessun principio liberale.
Trovo gravemente monca qualsiasi concezione del liberalismo che lo veda unicamente come strumento per dare spazio al mercato, che, comunque, oramai lo sanno tutti, è una costruzione sociale bisognosa di regole e di regolamentazione, e al laissez-faire della “sregolamentazione” (togliere regole non è necessariamente riformismo). Lo stato liberale è quello della separazione dei poteri e della loro autonomia relativa, dei freni e dei contrappesi, della responsabilizzazione (solo in parte questi elementi sono centrali nella riflessione di Rawls, Liberalismo politico. Nuova edizione ampliata, Torino, Einaudi, 2012). Il liberalismo correttamente inteso non ha nessuna opposizione di principio a politiche riformiste approvate secondo le regole costituzionali. Anzi, Sartori ha rigorosamente sostenuto che il liberalismo contemporaneo è costituzionalismo e Bobbio quasi si vantava della sua concezione della democrazia procedurale. Tutto questo, però, non serve ad avvicinarsi ad un riformismo che vorremmo socialista. Bobbio conclude che la stella polare del suo socialismo è la giustizia sociale. In materia, avrebbe potuto, forse dovuto, citare e confrontarsi John Rawls (Una teoria della giustizia, edizione americana 1971, italiana Feltrinelli, 1986), meglio se non collegando troppo strettamente la giustizia sociale all’eguaglianza. Vanno individuati e perseguiti tutti gli obiettivi che migliorino le condizioni di vita di coloro che sono più svantaggiati. La chiave di volta del riformismo socialdemocratico è stata la ricerca e nella misura del possibile l’attuazione, tuttora, della eguaglianza di opportunità. Qui sta la differenza profonda con la visione espressa da Rawls poiché il grande filosofo politico americano affida la sua giustizia sociale al conseguimento di punti di approdo fra una molteplicità di gruppi sociali, mentre da parte socialdemocratica classica vi è una esplicita e convinta attribuzione, che condivido, di un ruolo predominante alla politica e allo Stato. Il progetto riformista si traduce in politiche pubbliche formulate dai detentori del potere di governo e fatte approvare nelle appropriate sedi decisionali a cominciare dal Parlamento. Fra queste politiche pubbliche le più importanti sono quelle che hanno caratterizzato e tuttora improntano lo Stato sociale, nel senso che, dalla istruzione alla salute, dal lavoro alla pensione, ampliano e mantengono aperte le opportunità.
Questo tipo di riformismo, per il quale mi pare giusto mantenere il riferimento socialista, è ancora possibile e praticabile. Risulta molto difficile all’interno dei singoli paesi che, però, possono coltivare e curare tutte le politiche riformiste che hanno formulato e attuato nel tempo. La sua praticabilità si è trasferita a livello dell’Unione Europea. Nella consapevolezza che la ripresa e la resilienza che seguiranno al Covid potranno molto concretamente tradursi in politiche riformiste, il piano NextGenerationEU contiene elementi relativi alla trasformazione dell’ambiente, alla ricerca e all’innovazione, alla parità di genere significativamente promettenti. Un nuovo riformismo a livello sovranazionale, dove unicamente può essere situato, è dietro l’angolo. Resta da vedere se esiste un gruppo di uomini e donne, un tempo avrei scritto “un partito”, sufficientemente convinto e compatto per suscitarlo e perseguirlo pur in tempi non brevi.
Pubblicato su Mondoperaio n 4 Aprile 2021