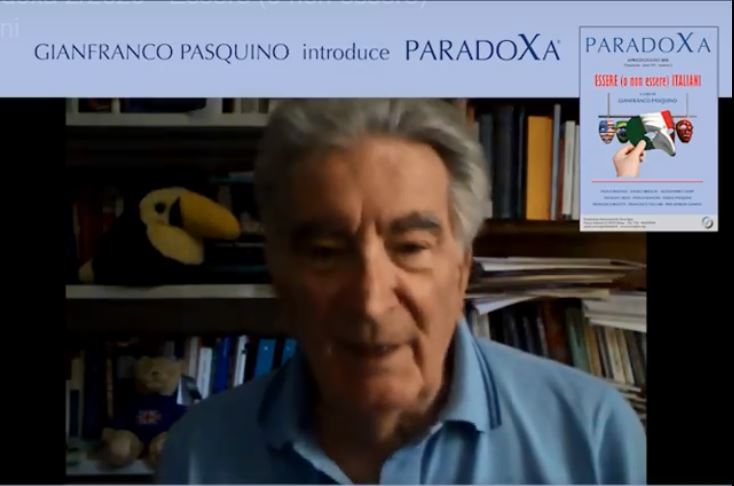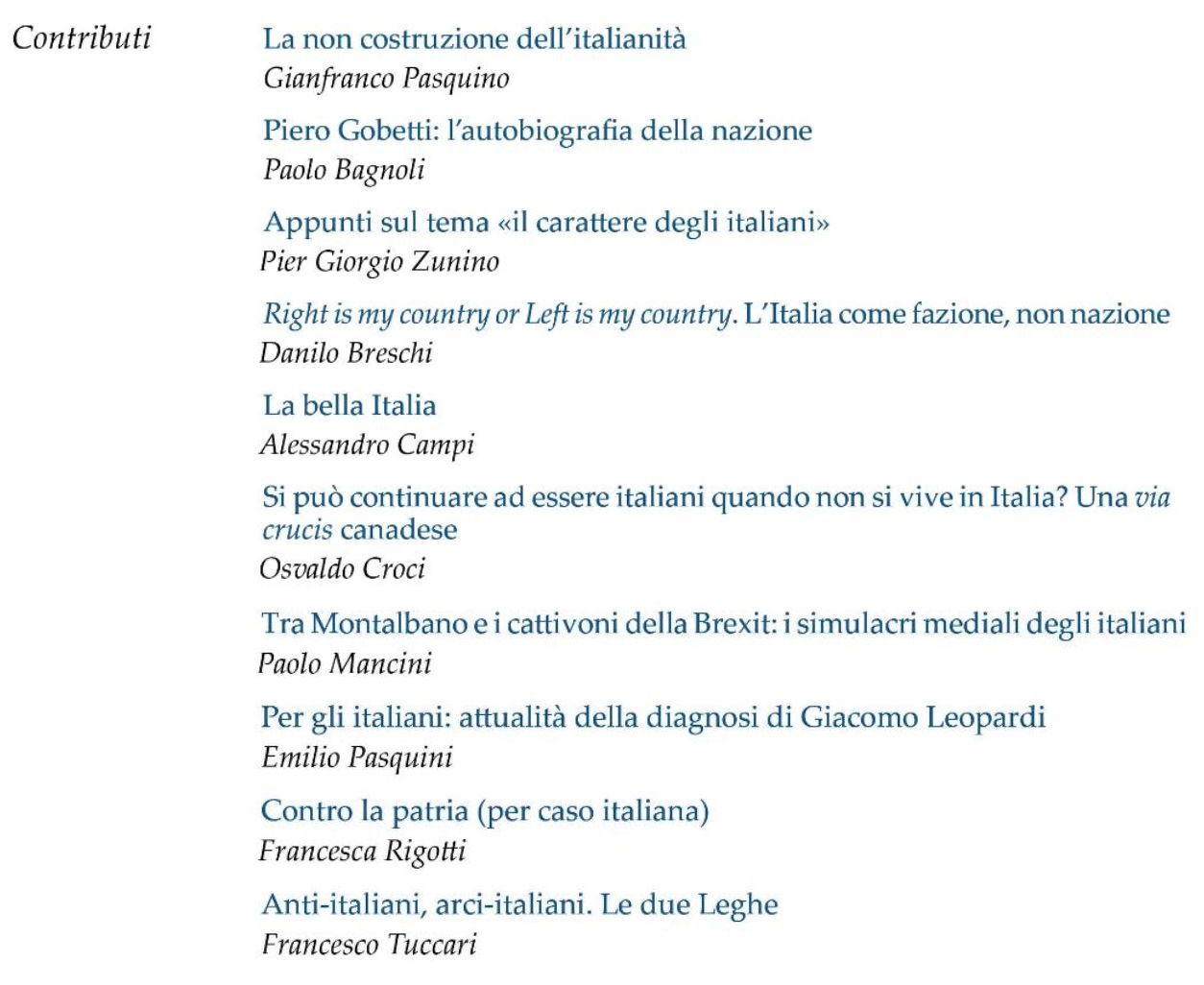Home » Posts tagged 'Paradoxa'
Tag Archives: Paradoxa
È uscito il fascicolo “L’etica pubblica ma non solo” a cura di Gianfranco Pasquino #Paradoxa Anno XIX– Numero 4 – Ottobre/Dicembre 2025
Non finisce qui. Le considerazioni con le quali concludo vanno intese come una sorta di prontuario democratico. La prima considerazione riguarda la competizione democratica che, ampia, aperta, allargata, approfondita, trova sempre limiti nell’etica. Ci sono comportamenti vecchi e nuovi, ad esempio attacchi, più o meno infamanti, alle persone in politica, che una pluralità di cittadini ritiene inaccettabili, deplorevoli e riprovevoli. Secondo, truccare la competizione politica dando vantaggi, ad esempio, di finanziamenti e di visibilità, ad alcuni concorrenti che portano in politica risorse suscettibili di produrre poi conflitti di interessi, tocca un punto nevralgico dell’etica in politica. Terzo, è plausibile ipotizzare che il grado di presenza e di effettività dell’etica in politica dipenda dalla sua presenza e effettività nella rispettiva società con potenziamenti e indebolimenti reciproci. Pertanto, uno studio che intenda essere esauriente dovrebbe partire da una ricognizione sull’etica nelle famiglie, nelle scuole, nelle confessioni religiose, nelle associazioni, in particolare nei sindacati e nei partiti, nella cultura politica complessiva. Oserei affermare che esiste un circolo virtuoso di etiche che si rincorrono e si rafforzano.
Così sia.

Contributi:
Lo spazio dell’etica in politica
Gianfranco Pasquino
Etica e politica: rapporti tesi
Giovanni Giorgini
L’etica del servizio
Maurizio Viroli
Etica costituzionale
Francesca Rescigno
«La Repubblica delle pere indivise»: etica, politica e non solo nell’Italia contemporanea
Antonio Maria Orecchia
Un giornalismo etico è ancora possibile
Roberto Vicaretti
Conservatorismo(i) e Progressismo(i): mentalità e pratiche #Progressismo ParadoXa 1/2024

G. Pasquino*, Conservatorismo(i) e Progressismo(i): mentalità e pratiche, in Progressismo. Prospettive criticità attualità, ParadoXa gennaio/marzo 2024 · anno XVIII · numero 1, (pp. 23-35)
The Progressive Era (1896–1917) was a period of widespread social activism and political reform across the United States focused on defeating corruption, monopoly, waste, and inefficiency.
Pongo in testa a questa difficile riflessione su “conservatorismo e progressismo” la sintetica valutazione che Wikipedia esprime su un ventennio molto importante della storia politica degli USA. I progressisti si impegna(ro)no con attivismo sociale e riforme politiche al fine di sconfiggere la corruzione, i monopoli, gli sprechi e l’inefficienza. Noto subito che in nessun modo se ne deve derivare che i conservatori siano disponibili ad accettare l’esistenza, la permanenza e la perpetuazione di quei quattro gravi vizi sistemici. In materia, la linea distintiva fra progressisti e conservatori concerne le modalità con le quali quelle politiche vengono formulate e applicate e da quali coalizioni di interessi e ideali sono sostenute. Troppo facile sarebbe rispondere che, dunque, bisogna contare sulla presenza di uno o più partiti conservatori che si contrappongono a uno o più partiti che si definiscono progressisti per cogliere tutte o quasi le differenze intercorrenti. Nel corso dell’articolo vedremo come meglio procedere a questa distinzione e quale è la sua validità interpretativa.
In questo mondo del politically correct e della cancel culture, dei fondamentalismi, dei populismi e dei personalismi, andare alla ricerca di idee/ideali politici con fondamenta culturali di una qualche profondità sembra essere un’operazione tanto difficile quanto destinata all’insuccesso. Quando non sono sostanzialmente scomparse (come ho sostenuto a proposito dell’Italia nel fascicolo di “Paradoxa”, Anno IX, n. 4, Ottobre-Dicembre 2015), un po’ dappertutto le culture politiche, in special modo, quelle, classiche, dal liberalismo al socialismo, che hanno segnato i due secoli successivi alla rivoluzione francese, sono diventate tenui, pallide, sostituite da populismi differenziati di molte risme e da fondamentalismi di molte credenze religiose.
Atti di nascita. In questo quadro generale, la dicotomia “conservatorismo/progressismo” ha, per quanto immersa in tempi molto lontani e molto diversi, quelli dell’Illuminismo, una sua specificità degna di nota. Prima di allora, ovvero prima degli illuministi, quella dicotomia era inesistente. Sarebbe, comunque, apparsa priva di senso; era sostanzialmente improponibile. Più in generale, azzardo qui e non riprenderò oltre, la dicotomia conservatorismo/progressismo si sovrappone largamente alla dicotomia “destra/sinistra” non soltanto nella molto nota e importante, peraltro non del tutto esente da critiche, non però distruttive, trattazione che ne ha fatto Norberto Bobbio (Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Roma, Donzelli, 1994, 2023), ma anche, in misura variabile, nelle pratiche politiche e, a richiesta dei sondaggisti, nelle autoconcezioni e autocollocazioni politiche/partitiche della stragrande maggioranza degli intervistati delle democrazie contemporanee.
In buona sostanza, credo che sia plausibile e corretto sostenere che la dicotomia “conservatorismo/progressismo” nasce attorno alla rivoluzione francese del 1789 e con riferimento a quell’evento, alla sua dinamica e alle sue implicazioni. Con tutte le semplificazioni del caso, che farebbero la felicità di ricercatori eruditi, ma ancora curiosi, quella rivoluzione è anche, sottolineo anche, il prodotto di un pensiero, non esclusivamente politico, ricco e articolato come quello degli illuministi e della loro credenza e fiducia in miglioramenti possibili, nel progresso. Molto, ma non troppo, indirettamente, una fiducia non dissimile può essere trovata nella Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati che, fra i diritti inalienabili, oltre alla vita e alla libertà, include “il perseguimento della felicità” ovvero, nella mia ardita interpretazione, la ricerca di miglioramenti, dunque di progresso, nelle condizioni materiali e emozionali di vita delle persone.
A riprova delle enormi diversità rispetto alla rivoluzione francese, la rivoluzione americana, forse da intendere meglio come la prima guerra di liberazione nazionale, consentì e facilitò carriere politiche di enorme successo a tutti i suoi figli. Dal canto suo, la rivoluzione francese i suoi figli li divorò tutti in tempi brevi. In un certo senso, seppellì, almeno per qualche tempo, l’idea di progresso e ebbe il merito, assolutamente paradossale, di suscitare l’elaborazione iniziale più compiuta del conservatorismo, quella di Edmund Burke (1730-1797). Da Wikipedia definito “politico, filosofo e scrittore anglo-irlandese”, Burke, severissimo critico della Rivoluzione francese (nel libro Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia, 1790) che è possibile considerare come il punto più alto raggiunto da coloro che credevano nel progresso e lo volevano, è il conservatore imprescindibile. Non posso approfondire, ma il bel libro di Yuval Levin, The Great Debate: Edmund Burke, Thomas Paine, and the Birth of Right and Left. New York: Basic Books 2014, offre un’ottima indagine sulle due contrapposte prospettive (Paine,1737-1809, fu illuminista, radicale, combattente nella rivoluzione americana), come furono elaborate, con quante e quali differenze e implicazioni su pensiero e azione.
Segni di vita/lità. Quanto di quella contrapposizione sia rimasta, continui a improntare atteggiamenti e visioni del mondo, faccia parte integrale della politica contemporanea e la influenzi merita di essere esplorato nelle sue ramificazioni e nelle sue manifestazioni contemporanee. Per cominciare, è possibile e utile mettere alcuni punti fermi. Sosterrei, in primo luogo, che il conservatorismo, inteso come pensiero, appare più coerente e più compatto del progressismo. Risulta anche dotato di elementi che poggiano su un terreno di idee e di pratiche più solide del progressismo. Volendo, il conservatorismo è in grado di fare riferimento a un vate dal pensiero forte e a un partito politico, quello inglese, per il quale Burke fu a lungo deputato, partito che dispone di una storia e che ha esercitato significativo potere politico e periodicamente continua a conquistarlo. Mi riferisco, naturalmente, al Partito Conservatore inglese, peraltro noto anche come Tory. Sarebbe facile e probabilmente anche corretto considerare il Partito Conservatore inglese, anche grazie alla sua preminenza e al lungo e frequente controllo e esercizio del potere di governo, come il progenitore di tutti i partiti conservatori, in particolare di quelli che hanno fatto la loro comparsa e che esistono nelle democrazie anglosassoni. In buona misura, è certamente così. Tuttavia, l’osservatore attento non può fare a meno di cogliere, da un lato, accentuazioni molto diverse su alcuni temi portanti; dall’altro, differenze programmatiche non marginali. Approfondimenti convincenti richiederebbero analisi comparate per me improponibili a causa delle difficoltà di individuazione dei più vari tipi di conservatori(smi) a cominciare addirittura dai materiali di base che soltanto gruppi di ricerca ampi e strutturati potrebbero reperire, analizzare, portare a sintesi.
Non esiste un pensatore del progressismo comparabile a Burke come statura intellettuale tranne se consideriamo gli illuministi francesi, Diderot, Voltaire, D’Alembert, ma non Rousseau, nel loro insieme. In seguito, fu Immanuel Kant a parlare soprattutto di progresso scientifico e delle difficoltà del pure auspicabile e prospettabile progresso morale. Questa distinzione spesso trascurata è cruciale, meritevole di una molteplicità di precisazioni e approfondimenti. Più in generale l’idea di progresso è soggiacente a tutte le teorie della storia formulate come stadi da Charles Darwin, Herbert Spencer e Karl Marx, ciascuno stadio essendo superiore al precedente e quindi rappresentando una evoluzione, termine talvolta preferito a progresso, rispetto al precedente.
Non intendendo svolgere una ricognizione esaustiva sulle teorie della storia, sicuramente molto al di là delle mie capacità e conoscenze, concludo provvisoriamente sottolineando che la parola progresso non appare nell’indice dei nomi dell’opus magnum di Max Weber, Economia e società. Desidero, però, non soltanto per ragioni disciplinari, fare riferimento ad un conciso libro sullo sviluppo politico, essendo sviluppo a sua volta un termine assimilabile a progresso: A.F.K Organski, The Stages of Political Development (New York, A. Knopf, 1965, trad. it, con il titolo Le forme dello sviluppo politico (Roma-Bari, Laterza, 1970). Purtroppo, il titolo italiano è assolutamente fuorviante e manca clamorosamente il bersaglio. Infatti, prendendo le mosse da un famoso libro di Walt Rostow sugli stadi dello sviluppo economico, offre una efficace analisi del fascismo come “stadio trasformativo” che blocca la democratizzazione, ma al tempo stesso la prelude. Quindi, il fascismo, assolutamente non assimilabile a nessuna variante di conservatorismo, risulta l’inconsapevole e involontario artefice del progresso politico.
Sopra ho fatto cenno al Partito Conservatore inglese come il padre di tutti i conservatori. Adesso, spostando il tiro sui progressisti mi rendo immediatamente conto che non sono in grado di identificarne un padre. Questa assenza è spiegabile, forse spiegata, dalla esistenza e presenza dei partiti socialisti/socialdemocratici che fanno del miglioramento delle condizioni di vita, del progresso sociale, economico, culturale la ragione stessa della loro esistenza e azione. Queste idee che sono anche obiettivi hanno permeato tutto il secolo XX tanto da farne, come scrisse il grande sociologo Ralf Dahrendorf, il “secolo socialdemocratico”. La fiducia dei socialdemocratici nella scienza si traduce per molti di loro anche nella convinzione che le scoperte scientifiche, la crescita economica, le trasformazioni materiali porteranno a positivi mutamenti culturali, al progresso nell’ambito morale, nelle credenze relative all’eguaglianza e alla giustizia sociale. Per i partiti comunisti, il progresso, in special modo se graduale, era non soltanto insufficiente, ma andando a scapito di una trasformazione più rapida e più profonda, più coinvolgente, forse anche irreversibile, vale a dire la rivoluzione (come presupposto per la comparsa e affermazione dell’homo novus), era da criticare, condannare, contrastare. Nessun “progresso” avrebbe portato prima o poi alla rivoluzione. È la nota contrapposizione “riforme contro rivoluzione” per la quale rimando al piccolo denso saggio del socialista Antonio Giolitti (Torino, Einaudi, 1957). Qualsiasi progresso sociale, economico, politico rischiava di rendere più improbabile e più difficile la rivoluzione, la rimandava sine die. Tuttavia, sta al cuore del marxismo stesso l’idea che gli stadi della trasformazione storica condurranno al punto più elevato, il comunismo, il massimo di progresso concepibile e realizzabile.
Esemplificazioni random. Per saperne di più mi pare utile rincorrere e mettere in evidenza senza nessuna pretesa di sistematicità alcune manifestazioni di progressismo e di conservatorismo. Negli USA, qualsiasi riferimento al socialismo, persino prima della rivoluzione bolscevica, suscitava reazioni molto negative (continua a farlo). Peraltro, nel 1901 fece la sua comparsa il Partito Socialista d’America (sciolto nel 1973) dal quale nel 1919 nacque il Partito Comunista d’America. Non si deve sottacere l’esistenza di un partito progressista portatore dell’ottimismo delle possibilità nel futuro spesso attribuito più in generale alla cultura politica USA. La storia del Progressive Party negli Stati Uniti si colloca all’interno della Progressive Era (1896-1917) un periodo, ripeto la citazione da Wikipedia messa in testa a questo articolo, di “diffuso attivismo sociale e riformismo politico” inteso a sconfiggere “la corruzione, i monopoli, lo spreco, l’inefficienza”. Su quest’onda di proteste e di obiettivi mobilitanti, mirando a trarne profitto politico nacque nel 1912 il Progressive Party, prodotto di una scissione del Partito Repubblicano. Subito presentò un suo candidato alle elezioni presidenziali nello stesso 1912. Lo fece ancora nel 1916 e nel 1920. La personalità più nota, più duratura e influente ne è stato il governatore del Wisconsin, poi anche Senatore, Robert M. La Follette. Qui trovo opportuno rilevare e sottolineare che, in un certo senso, negli Stati Uniti il pragmatismo di John Dewey (1859-1952) può essere interpretato come la filosofia politica del progressismo. In forma diversa, sarà un altro Progressive Party a costituire il veicolo politico-organizzativo di Henry A. Wallace, già Vice-Presidente del democratico Franklin D. Roosevelt, nelle elezioni presidenziali dl 1948 con una prestazione molto mediocre.
Nello stesso periodo, il conservatorismo caratterizza pensiero e azione dei Presidenti Repubblicani Warren Harding (1921-1923), Calvin Coolidge (1923-1929) e Herbert Hoover (1929-1933). Anche in questo caso non ho lo spazio per approfondire, ma negli ultimi vent’anni il forte spostamento a destra dei Repubblicani ha fatto del loro partito il veicolo di politiche tecnicamente reazionarie: non solo conservare, ma tornare indietro. La filosofia giuridica prima che politica che sottende questo spostamento è definita originalismo, utilizzato come principio dominante, se non esclusivo, per l’interpretazione della Costituzione USA. Furbescamente, il Presidente George W. Bush (2000-2008) cercò di ridefinire le sue politiche attribuendole ad una visione di “conservatorismo compassionevole”. Immagino che il contrario sia il conservatorismo punitivo, forse crudele, dal quale Bush intendeva prendere le distanze. Non è questo il luogo per stabilire se vi sia riuscito, ma certo “compassionevole” non è aggettivo che si possa usare per la visione conservatrice di Donald Trump, prima, durante e dopo la sua Presidenza.
Per contrastare questa visione la propaganda democratica enfatizza che il Presidente Biden e la Vicepresidente Harris stanno lavorando sodo spingendo per il progresso (Newsletter digitale Team Joe, 21 ottobre 2023). Come esponenti di un partito mai noto per la sua compattezza, se non nell’era rooseveltiana (1932-1948), i Democratici continuano nella loro politica, diventata sempre più complicata, di costruzione di alleanze, ma al loro interno hanno fatto comparsa, da un lato, il Sen. Bernie Sanders con la sua convinzione della necessità di una “rivoluzione politica”, dall’altro, donne e uomini giovani eletti alla Camera dei Rappresentanti che si fanno vanto dell’etichetta di Progressisti. Anche da questo sviluppo ben si comprende come la politica USA si sia fortemente polarizzata. Progresso è andare oltre le politiche esistenti, più avanti, mentre lo slogan trumpiano di grande successo Make America Great Again (MAGA) fa riferimento ad un passato di (quasi sicuramente esagerato) splendore politico, economico e militare, come obiettivo da recuperare. Attorno a questo slogan si raccolgono tutti i conservatori, prevalentemente bianchi di mezz’età e più che quel passato hanno sperimentato, lo rimpiangono, pensano possa essere ricostruito e vedono in Trump il ricostruttore.
Per quanto nient’affatto esaustive e necessariamente aneddotiche, ma non prive di rilevanza e capacità suggestiva, le indicazioni e considerazioni contenute nella panoramica condotta fin qui dovrebbero avere il pregio di segnalare la difficoltà di contrapporre limpidamente conservatorismo a progressismo, con il primo che sembra mostrare maggiore coerenza e profondità. In tempi recenti le dinamiche politiche hanno aggiunto specificazioni che comportano maggiore confusione, talvolta vere e proprie manipolazioni intese a conseguire qualche vantaggio politico-elettorale. Mi limito a poche esemplificazioni che ritengo probanti. In Danimarca del 1972 e in Norvegia dal 1973 è attivo un Partito del Progresso il cui nucleo programmatico è costituito dalla riduzione delle tasse. Altrove, ad esempio in Italia, la riduzione delle tasse è, abitualmente, uno degli obiettivi più spesso dichiarati, ancorché raramente conseguiti, dei parti di destra, conservatori.
Su un piano diverso, nel contesto italiano, il segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer fece scandalo quando nel 1978 dichiarò di essere al tempo stesso conservatore e rivoluzionario. Pochi notarono che anni prima, nel 1943, era stato il grande filosofo liberale Benedetto Croce a definirsi politicamente facendo ricorso agli stessi aggettivi che, a parere di molti, sono inconciliabili.
Dal canto suo, l’attuale Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni è anche orgogliosamente presidente del Gruppo Conservatori e Riformisti Europei il cui asse portante è la difesa, forse anche il recupero, della sovranità nazionale. Lo dirò meglio: “conservare” la sovranità nazionale contro il progressivo scivolamento sovranazionale e federalista dell’Unione Europea.
Una concettualizzazione accettabile. A questo punto, dopo avere indicato en passant, in maniera mai sistematica, ricorrendo al non-metodo che in inglese si chiama cherry picking, non posso più eludere l’approfondimento concettuale. Piuttosto che procedere a dotte disquisizioni relative alle motivazioni di Croce e di Berlinguer, credo che sia giunto il momento di definire conservatorismo e progressismo con riferimento al loro rispettivo pensiero (politico, sociale, economico, culturale, istituzionale). La procedura corretta mi pare debba consistere nel delineare quelle che chiamerò le sindromi di conservatorismo e di progressismo. La fonte essenziale per il conservatorismo non può, come ho già scritto, che essere il pensiero e l’elaborazione di Burke. Per lui, il conservatorismo si caratterizza come un insieme di tradizione, autorità, gerarchia, ordine e prudenza. In un certo senso, si tratta di credenze e atteggiamenti che furono travolti dalla e nella rivoluzione francese. La tentazione di definire il progressismo come tutto il contrario deve essere contrastata e respinta. Però, prima di essere più precisi nella chiarificazione della sindrome propria del progressismo che dalla rivoluzione francese in poi ha continuato a cambiare, è opportuno chiarire i contenuti dei principi del conservatorismo.
Non credo possano esserci dubbi e contestazioni su due premesse che considero essenziali, fondanti. Prima premessa: il conservatorismo tiene in grande conto il passato e cerca di preservarne e di trasmetterne gli aspetti migliori. Nel progressismo si trovano opinioni diverse che, tuttavia, convergono su un punto importante: il passato deve essere superato affinché si possa perseguire e costruire il futuro. Fra i progressisti c’è anche la convinzione che quel futuro sarà migliore. Nello spesso citato titolo dell’autobiografia pubblicata postuma di un antifascista comunista francese Gabriel Péri,: Les lendemains qui chantent, si trova la forte convinzione di un futuro radioso che, nel tempo, ha ispirato molti progressisti. Mentre scrivevo quest’articolo mi sono imbattuto nella frase “dobbiamo essere acerrimi avversari della paura di futuro” pronunciate dalla segretaria del PD Elly Schlein al Congresso dei Popolari, il 2 dicembre 2023. In effetti, è oramai da qualche tempo che i progressisti manifestano qualche perplessità sul futuro, anche/proprio quello che dovrebbero offrire e illuminare per i loro concittadini.
In un certo senso, il conservatorismo, in special modo nelle società democratiche in trasformazione, sembra avere buon gioco. Può farsi forte della necessità di preservare valori e stili di vita che larga parte della popolazione conosce, con i quali è cresciuta e, grazie ai quali, ha probabilmente già almeno un po’ migliorato la sua vita. Rispetto delle tradizioni, ossequio alle autorità, preferenza per l’ordine costituito, accettazione delle regole, delle procedure e delle istituzioni esistenti. Per quanto necessariamente schematico il trittico Dio, Patria e Famiglia, sintetizza il blocco di credenze che innerva il conservatorismo. Bisognerà, poi, vederne la manifestazione e l’impatto, certamente differenziati, nei vari sistemi politici e anche le rivisitazioni e gli aggiornamenti. In alcuni casi, gli sviluppi dipendono dalle sfide provenienti dai fatti nuovi e dalle reazioni, più o meno forti, a seconda dell’esistenza di partiti e di personalità politiche, intellettuali, religiose che difendano e argomentino il conservatorismo.
Le sfide, alcuni studiosi le raggruppano e le etichettano come secolarizzazione e modernità, colpiscono al cuore la religione, la nazione, la famiglia tradizionale. I più abili dei conservatori si adeguano flessibilmente senza cedere il punto e approntano risposte, finora, almeno in parte, non prive di successo. Definirò questo successo con riferimento a due parametri: primo, riaffermare la validità del trittico “Dio, Patria, Famiglia” con opportune declinazioni; secondo, opporre ostacoli e rallentare i cambiamenti pure inevitabili. Al proposito, sento che per illuminare le differenze fra conservatorismo e progressismo vi sarebbe l’esigenza di riflettere da una pluralità di prospettive sul multiculturalismo, come è stato definito, come è stato applicato, come è stato valutato, quale è la sua condizione attuale (non proprio brillante).
Sarebbe un errore pensare che il progressismo non sia consapevole della forza, trainante o frenante, della triade “Dio, Patria, Famiglia”. Non è sbagliato, invece, sottolineare che i i valori del progressismo non sono stati delineati in antitesi alla triade che attribuisco al conservatorismo. Si può sostenere, però, che nel confronto si sono palesati comportamenti diversi, non definibili come una strategia elaborata. In estrema sintesi: molto raramente combattere a viso aperto quei valori; spesso consegnarli all’oblio e alla (illusoria) irrilevanza; semplicemente andare oltre senza riferimenti espliciti di nessun tipo o quasi. D’altronde, il progressismo è ovvero intende presentarsi e dipanarsi all’insegna di un obiettivo sovrastante: la costruzione del futuro, costitutivamente di un futuro migliore. Al proposito, intraprendo un’operazione dalla quale i progressisti si tengono lontani: spiegarne l’atteggiamento nei confronti di ciascuno degli elementi della triade.
“A ciascuno il suo Dio” non è soltanto il riconoscimento da parte dei progressisti dell’irrinunciabile pluralismo religioso, ma anche la manifestazione di una loro indifferenza, che i conservatori non mancano di criticare, nei confronti di importanti valori religiosi. Separazione Stato/Chiesa che è anche separazione fra politica e religione, fondamento dei regimi teocratici (Iran), ma anche religione instrumentum regni nelle mani di autocrati fra i quali spicca il Presidente turco Erdogan, ma il cui paradigma è rappresentato dall’Arabia Saudita. Per quanto non sia in nessun modo possibile affermare che, di per sé, i progressisti non abbiano amor di patria (in Italia, il progressista Maurizio Viroli ha scritto pagine importanti in materia), il loro internazionalismo (“proletari di tutto il mondo unitevi”) e la loro preferenza, in particolare in Europa, per la cessione di parte della sovranità nazionale e di condivisione della sovranità a livello quasi federale, offrono il fianco ai sovranisti che fanno appello ad affetti primordiali (di cui non si possono negare derive nazionaliste). La famiglia tradizionale è oramai minoritaria non esclusivamente in tutti regimi democratici, ma, mentre i conservatori cercano in ogni modo di sostenerla e di salvarla, molto (troppo?) spesso il messaggio dei progressisti sembra essere duplice: i) mettere sullo stesso piano della famiglia tradizionale tutte le più variegate forme di convivenza, ii) incoraggiare qualsiasi modalità di convivenza non tradizionale e, implicitamente criticare coloro che manifestano preoccupazioni e perplessità, vantarsene e vantarle, quasi prefigurassero un futuro migliore.
Non finisce qui. Giunto è il momento di tirare le somme di un discorso, di una comparazione, di un confronto/scontro che sono tutti destinati a fluttuare e rimanere aperti e controversi poiché la vittoria definitiva degli uni o degli altri sfocerebbe nel totalitarismo. Non sono convinto che il conservatorismo sia, come ha scritto Antonio Polito nel suo articolo Dare voce all’Italia conservatrice. Tre ricette per una svolta politica (“Corriere della Sera”, 2 novembre 2023, p. 37: un “consapevole moto volto a governare il processo della modernità, che non ne discute le premesse e i paradigmi, ma cerca di ricondurlo in un alveo sostenibile”; Dirò che il conservatorismo parte avvantaggiato: conservare risulta molto spesso più facile che innovare. Mantenere quello che abbiamo, a cominciare dai valori e dagli stili di vita, costa meno sforzi e implica meno rischi di impegnarsi in trasformazioni mai prima tentate. Convincere i propri concittadini della bontà di un futuro sconosciuto tutto da costruire è operazione che dovrebbe fare tremare le vene ai polsi, non importa quante vene né quanti polsi, anche se i progressisti sanno che l’unione fa la forza, ma il futuro si costruisce non con la forza, ma con l’egemonia culturale, anche transeunte. I progressisti sanno anche, o dovrebbero imparare che il progresso che propongono richiede una definizione chiara e convincente degli obiettivi da perseguire, che bisogna volere e riuscire a distinguere cambiamento da miglioramento, che non esiste un solo futuro possibile, che le riforme che non costruiscono il futuro preferibile debbono essere rapidamente riformate.
Conservatorismo e progressismo non sono più, ma forse non lo sono mai state, vere e proprie ideologie. Certamente, Burke avrebbe sdegnosamente, con ragione, respinto il termine ideologia per caratterizzare il suo pensiero conservatore. A loro volta, anche i socialdemocratici scandinavi, a mio parere esemplificativi del punto più alto di elaborazione culturale e pratica politica del progressismo, non hanno proceduto a elaborazioni di natura ideologica.
Per entrambi faremmo meglio a ricorrere al concetto di mentalità, al plurale, intese come insiemi di idee non in contraddizione che si mescolano liberamente con alcune altre idee, raramente le stesse, che di tanto in tanto acquisiscono la preminenza. Queste considerazioni valgono anche per i rapporti di quelle mentalità con il mercato e con la scienza, tematiche importantissime, ciascuna delle quali meritevole di affascinanti ricognizioni, qui non possibili.
Per entrambi, il nucleo è sufficientemente chiaro e distinto. Non cambia. Il contorno aggiungerà di volta in volta gli elementi più appropriati, mai tali da scalfire il nucleo, per lo più in condizione di aggiornarlo e di arricchirlo. Questa relativa, sottolineo relativa, flessibilità dei concetti di conservatorismo e progressismo ne spiega la durata nel corso del tempo e, nonostante cambiamenti epocali nell’ambiente, il loro appello (appeal) contemporaneo, quello del conservatorismo superiore al progressismo, in situazioni molto diverse.
Coda Quando mi ero convinto di avere trattato conservatorismo e progressismo con la dovuta cautela, con le necessarie distinzioni, con opportuni esempi e selezionati riferimenti, mi è tornata in mente un frase che lessi una trentina/quarantina d’anni del grande intellettuale al tempo molto famoso e citato Daniel Bell, docente di sociologia a Harvard per decenni a partire dal 1970, autore di molti libri due dei quali particolarmente importanti: La fine delle ideologie (1959) e L’avvento della società post-industriale (1973), entrambi rilevanti tanto per i progressisti quanto per i conservatori. Non sono riuscito a trovare la fonte che neppure la Treccani indica. Probabilmente in una delle numerose interviste che era quasi obbligato a concedere, prezzo della sua fama, nel 1983, Bell si autodefinì: “socialista in economia, progressista in politica, conservatore in cultura“.
Non ritengo che questa definizione che fa riferimento sia al progressismo sia al conservatorismo come componenti capaci di convivere negli atteggiamenti e nelle convinzioni di una persona(lità) ponga una pietra tombale sull’utilità di distinguere principi e valori, luoghi e sedi. Non preclude il lavoro di chiarificazione concettuale. Anzi, lo spacchettamento “economia, politica, cultura” vi prelude ingegnosamente. Vi colgo un richiamo alto e esplicito alla complessità di entrambi i concetti e delle loro manifestazioni. In sostanza, non finisce qui.
*Gianfranco PASQUINO (1942) torinese, è Professore Emerito di Scienza Politica nell’Università di Bologna e Socio dell’Accademia dei Lincei. Nella legislatura 1994-1996 è stato un inquieto Senatore del Gruppo Progressisti. I suoi libri più recenti sono Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana (UTET 2021); Tra scienza e politica. Una autobiografia (UTET 2022) e Il lavoro intellettuale. Cos’è, come si fa, a cosa serve, (UTET 2023). Ha altresì curato il volume Fascismo. Quel che è stato. Quel che rimane (Treccani 2022).
L’Occidente on my mind – Orgogliosamente Occidente a cura di Gianfranco Pasquino Paradoxa Anno XVII – Numero 1 – Gennaio/Marzo 2023
Ho imparato, non immediatamente, da Giovanni Sartori che bisogna sapere “scrivere contro”. Vale a dire che, molto di frequente, la tematica che riteniamo rilevante è stata affrontata da altri in maniera che non pare convincente, che le spiegazioni, ma talvolta la stessa impostazione, sono inadeguate e fuorvianti, che la conclusione, per quanto molto sbandierata e diventata popolare, è sostanzialmente sbagliata. Allora, per chi fa lavoro intellettuale corre l’obbligo scientifico di scrivere, non trascurando, ma prendendo le mosse dall’esistente, sfidandolo, andando oltre perseguendo una spiegazione migliore. Però, nessuna spiegazione sarà migliore se si riferisce ad un unico caso. Per quanto approfonditi, esaustivi, persino brillanti gli studi di un unico caso poco o nulla sono in grado di dire su quello che è “normale” e su quello che, al contrario, è “eccezionale”. Neppure quando quegli studi si accumulano potranno portare a conclusioni valide. Sapranno, certo, sollevare interrogativi e suggerire conseguenze. Problematizzeranno, ma nessuna spiegazione riuscirà ad emergere da descrizioni, anche numerose e eccellenti (sì, se ne trovano, anche se non sono numerose), ma “singolari”. Se, parole di Sartori, “chi conosce un solo caso non conosce neppure quel caso”, colgono il punto, a mio modo di vedere sicuramente sì, nelle scienze sociali diventa imperativo procedere a studi comparati con l’apposito metodo comparato. L’operazione è tutt’altro che facile, ma, se eseguita con impegno e applicazione, promette grandi ricompense conoscitive.
Questa premessa, tanto indispensabile quanto comprensibilmente sintetica, deve concludersi con altre definitive, ma molto controverse parole di Sartori: “la politica si spiega con la politica”. Non sarà il capitalismo a spiegare le forme di governo, la loro esistenza, funzionamento, trasformazione. Non basterà la psicologia a chiarire i comportamenti delle leadership politiche. Non servirà mettere all’opera la demografia per individuare come cambia un sistema politico. Economia, psicologia, demografia hanno le loro innegabilmente utili specificità. Contribuiscono conoscenze anche di grande interesse, ma la politica, quello che è, come funziona, le modalità del suo cambiamento, dipende da elementi e fattori politici, da regole e da istituzioni. Naturalmente chi non condivide questa impostazione politica e comparata è invitato a criticarla “scrivendo contro”, proponendo le alternative praticabili punto per punto, evidenziando i loro costi e i loro vantaggi esplicativi, formulando una interpretazione più convincente. Sartori aggiungerebbe “capace di viaggiare” nello spazio e nel tempo. Dal canto mio, in questo breve scritto nella misura del possibile e delle mie capacità farò tesoro di e ricorso a ciascuno degli insegnamenti di Sartori.
Scrivere contro.
Da un lato, è impossibile procedere ad una ricognizione approfondita degli articoli e dei libri dedicati alla crisi dell’Occidente in particolare sotto forma di declino e di tramonto (non ho visto le parole tonfo e crollo, ma il senso è spesso anche quello); dall’altro, è persino inutile farlo poiché quasi nessuno di quegli scritti contiene elementi di originalità. Qui mi limito a due titoli recenti dello stesso quotidiano: “Paura e nostalgia. L’autunno dell’Occidente” e “Occidente in crisi”. Il primo, pubblicato il 13 novembre 2022 (pp. 36-37), è una intervista a Andrea Graziosi in occasione della pubblicazione di un suo libro L’Ucraina e Putin, nel quale forse la discussione avrebbe potuto opportunamente essere indirizzata anche sul possibile tramonto della Russia. Il secondo è il resoconto della Lettura del Mulino affidata allo stesso studioso e pubblicato il 27 novembre dal Corriere di Bologna (p. 13) nella quale si preannuncia l’uscita di un libro in materia. Non sintetizzo poiché intendo leggere il libro (e, eventualmente, recensirlo, forse addirittura per “Paradoxa”!). Al momento, due osservazioni mi paiono assolutamente necessarie. La prima è la mancanza di una definizione sufficientemente operativa di che cosa si intende quando si parla di Occidente. La seconda è l’incrocio latente e/o manifesto fra tre presunte crisi: quella, principale, dell’Occidente, quelle, non saprei se secondarie o derivate, della Unione Europea e quella, presunta, delle democrazie.
Quanto alla definizione di Occidente non sarei soddisfatto dalla soluzione talvolta “generosamente” proposta: “ognuno ha la sua definizione”, certamente tutto meno che scientifica e inadeguata a stabilire feconde interazioni intersoggettive. Concedete a ognuno la sua definizione e vi troverete nel caos lessicale e concettuale. Vero è che spesso le definizioni indirizzano l’analisi, ma sono anche per questo criticabili e migliorabili, pertanto utili. Personalmente, mi sono fatto l’opinione che la maggior parte degli autori ritenga che Occidente è Europa più USA, qualche volta dicendo America, quindi aggiungendovi anche il Canada e i paesi dell’America latina. I più colti non si dimenticano che, facendo uno strappo alla geografia, Australia e Nuova Zelanda debbono certamente trovare posto nell’Occidente. Questa è anche la tesi di Huntington: “L’Occidente comprende l’Europa, il Nord America, più altri paesi a forte colonizzazione europea quali l’Australia e la Nuova Zelanda”, mentre l’America latina è definita “una civiltà a sé stante strettamente associata all’Occidente e divisa in merito alla sua appartenenza o meno ad esso (Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Milano, Garzanti, 1997, p. 53). Probabilmente, i molti latino-americani che sono anti-USA accetterebbero questa loro collocazione ambigua: un po’ democratico/occidentale e un po’ no, e ne farebbero un vanto. In sostanza, mi attesto su una definizione che ritengo elegante e parsimoniosa: Occidente è la combinazione giudiziosa di geografia e storia, politica democratica, valore della persona.
Nel prosieguo della maggior parte delle analisi, l’Unione Europea e gli Stati Uniti fanno la parte del leone. E anche degli USA, in effetti, si riscontrano gli elementi che ne segnalano il declino assoluto oppure relativo, facendo il confronto con la Cina. Dal Presidente francese François Mitterrand (1981-1995) ho imparato dove arrivava ovvero, meglio, finiva la sua Europa: (dall’Atlantico) agli Urali. Grazie al grande professore di Government a Harvard, Samuel P. Huntington so che le civiltà possono riguardare paesi contigui, ma anche no, e che “la sopravvivenza dell’Occidente dipende dalla volontà degli Stati Uniti di confermare la propria identità occidentale e dalla capacità degli occidentali di accettare la propria civiltà come qualcosa di peculiare, ma non di universale, e di unire le proprie forze per rinnovarla e proteggerla dalle sfide provenienti dalle società non occidentali” (Ibidem, p. 15 c.vi miei). Di protezione ha grande necessità e urgenza poiché “sono la Russia di Vladimir Putin e la Cina di Xi Jinping a guidare l’assalto all’Occidente” sostiene senza mezzi termini Maurizio Molinari (Assedio all’Occidente, Milano, La nave di Teseo, 2019, p. 13).
Quanto agli incroci, gli acuti studiosi che vedono crisi dappertutto (curiosamente non nei regimi autoritari), in particolare nell’Unione Europea e nelle (liberal)democrazie, sono inevitabilmente costretti a denunciare l’impatto di queste crisi sull’Occidente. Altrove, spesso, ho criticato, rimanendo nel solco del “pensare contro”, gli analisti delle crisi e gli esiti delle loro riflessioni. Qui drasticamente affermo che non esiste nessuna crisi nel sistema politico dell’Unione Europea e che nessuna democrazia occidentale, ad eccezione, se si vuole, del Venezuela, è crollata negli ultimi trent’anni. Manteniamo pure le giuste e opportune riserve nei confronti del funzionamento dei regimi democratici in Polonia e, soprattutto, in Ungheria, ma nessun crollo è alle viste. Anzi, potrebbe presto manifestarsi quello che intendo chiamare “rimbalzo democratico”.
Comunque, chi voglia parlare e scrivere di “crisi dell’Occidente/di Occidente in crisi” ha l’obbligo preliminare di definire con ragionevole precisione che cosa significa “crisi” e che cosa è l’Occidente. Del “mio” Occidente, che non è una semplice categoria geografica, ma attiene a una cultura/civiltà condivisa, ho già detto sopra. Per quanto riguarda la definizione di crisi, personalmente ritengo ci si debba riferire a una rottura profonda del modello esistente, rottura non rimediabile con qualche rammendo, ma che richiede una vera e proprio ristrutturazione. Sia il tipo di rottura sia le modalità della ristrutturazione appaiono fortemente problematiche tanto dal punto di vista concettuale quanto dal punto di vista dell’individuazione nella storia di rotture e ristrutturazioni. Il libro di Edward H. Carr, The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939 (1939), coglie l’elemento centrale e cruciale. In quel fatidico ventennio, crisi fu la rottura irrisolta e non ricomposta nel sistema di relazioni internazionali fra gli Stati europei. La seconda guerra mondiale produsse una ristrutturazione totale dei rapporti fra gli Stati che portò all’instaurazione di un ordine internazionale liberale da qualche tempo in visibili difficoltà (crisi?), ma senza che se ne intravveda un sostituto funzionale egualmente accettabile (sul punto Vittorio Emanuele Parsi, Titanic. Naufragio o cambio di rotta per l’ordine liberale, Bologna, il Mulino, 2022). Ovvero, una ristrutturazione dell’occidente e dell’ordine internazionale dovrà fare seguito alla fine dell’aggressione russa all’Ucraina, ma le sue, al momento imprevedibili, modalità dipenderanno dagli esiti della guerra.
Per chi accetta, com’ è il mio caso, questa accezione di crisi e il suo riferimento agli Stati e ai loro rapporti, riesce molto difficoltoso e nient’affatto utile attribuire la crisi dell’Occidente e il suo declino a fattori come la paura, la nostalgia, l’ansia collettiva, l’invecchiamento della popolazione. Citerò per esteso dall’articolo del “Corriere di Bologna”: “attese di crescita sfumate, disomogeneità culturale, religiosa e etnica, formazione di uno scontento livido e reazionario … rancore generato nei giovani dalla loro oggettiva emarginazione e da aspettative decrescenti, solitudine montante nella parte più anziana della popolazione, irritata contro mutamenti troppo veloci”. Su tutto si colloca, nelle parole di Graziosi riportate nell’articolo, “l’incapacità delle élite di garantire la realizzazione delle aspettative della popolazione, con conseguente sfiducia nei loro confronti”. Di tutte le élite? Di tutte le aspettative? Di quale popolazione? Con quanta sfiducia? Espressa con quali modalità? Non concluderò affermando che sembra fin troppo facile scrivere contro l’affermazione citata. Certamente, è doveroso chiederne le indispensabili precisazioni esplicitando anche alcune essenziali confutazioni. Magari confrontandosi anche con la tesi originale dell’Occidente come “una figura drammaticamente incompiuta” dove “incompiutezza … non vuol dire tramonto. Significa piuttosto sospensione e incertezza” (Aldo Schiavone, L’Occidente e la nascita di una civiltà planetaria, Bologna, il Mulino, 2022, p. 22 e p. 23). A suo tempo.
Comparazione.
“Chi conosce un solo Occidente non conosce neppure quell’Occidente”. Epperò, qualcuno sosterrebbe che non siamo in grado di moltiplicare gli Occidente al puro scopo di procedere a comparazioni che amplino e/o rafforzino le nostre conoscenze. Quel qualcuno, come scriverò più avanti, sbaglierebbe. Per lo più, sembrerebbero avere partita vinta fin troppo facilmente coloro che affermano che se si vuole procedere ad una comparazione significativa e istruttiva, essa va fatta, ad esempio, con l’Oriente. Però, se si è già rivelato molto problematico individuare l’Occidente e dargli unitarietà, lo sarebbe ancora di più per l’Oriente, a sua volta notevolmente diversificato. Come mettere e tenere insieme la Cina e l’India, il Giappone e l’Indonesia? Dunque, la comparazione Occidente/Oriente è, salvo una molteplicità di accorgimenti e di note di cautela, improponibile, a troppo alto livello di genericità. Fortunatamente esiste una strategia altamente raccomandabile al fine di effettuare una comparazione feconda di apprendimenti. Si traduce in due modalità di comparazione. La pima, comparazione intrasistemica, consiste nell’individuare aggregazioni di sistemi politici, ad esempio, gli Stati scandinavi, i paesi anglosassoni, l’Europa meridionale e paragonarli con riferimento alla variabile desiderata: durata della democrazia, stabilità dei governi, partecipazione elettorale, natura dei sistemi di partiti. L’altra strategia, preferibile per i miei obiettivi in questo sintetico articolo, consiste nel comparare l’Occidente stesso (sì, lo so, con comunque inevitabili variazioni che sono proprio il sale di questa modalità) in tempi diversi. La comparazione intertemporale consente di acquisire numerose importanti conoscenze sull’oggetto di studio. L’Occidente com’era prima della guerra 1914-1918 paragonato all’Occidente del dopoguerra. L’Occidente nel 1945 paragonato con l’Occidente dopo il 1989. Infine, l’Occidente del secondo immediato dopoguerra con l’Occidente del 2022.
Le comparazioni intertemporali al tempo stesso più semplici e più rivelatrici riguardano il numero dei regimi democratici. Grazie a Huntington tutti hanno preso contezza del fenomeno da lui definito democratic wave, che tradurrò con ondate di democrazia. Rimando al suo bel libro La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo (Bologna, il Mulino, 1995) per le prime due ondate limitandomi a segnalare che hanno riguardato essenzialmente i sistemi politici occidentali e mi soffermo brevemente sulla terza ondata. Si tratta di un’ondata particolarmente importante culminata nella caduta del muro Berlino 8/9 novembre 1989 che travolse i regimi comunisti dell’Europa orientale aprendo lo spazio alla loro, peraltro molto complicata e differenziata, democratizzazione
La maggior parte di quei sistemi politici già comunisti tentò di coronare l’instaurazione della democrazia (occidentale) con l’accesso all’Unione Europea, concesso soltanto ai sistemi politici che danno la garanzia di promuovere e proteggere i diritti civili e politici dei cittadini e di operare secondo i criteri della rule of law. Nella prospettiva che qui interessa, il crollo del Muro di Berlino pose fine ad un doloroso distanziamento storico e politico, di mondi vitali, durato quarantacinque anni, fra le democrazie dell’Europa occidentale e i sistemi politici dell’Europa centro-orientale.
In questo importantissimo caso, quel che era Occidente rivelò di avere una enorme capacità di attrazione, mentre i cittadini dei sistemi politici delle cosiddette democrazie popolari espressero limpidamente il loro desiderio di (ri)congiungimento politico e ideale a una storia e a un ambito che sentivano anche loro. Forse, come ha acutamente sottolineato Milan Kundera, Un’Occidente prigioniero o la tragedia dell’Europa centrale (Milano, Adelphi, 2022) gli europei occidentali e i dirigenti dell’Unione Europea, pur aprendo le porte alla adesione, non compresero appieno le aspirazioni degli europei centro-orientali, da non trattare come parvenus, come cittadini di seconda classe, e non si posero il compito di come soddisfarle. L’Occidente rimaneva attraente, ma non si rivelò sempre e per tutti accogliente. Molti europei centro-occidentali nutrivano aspettative troppo elevate; molti non erano preparati; molti divennero prigionieri della nostalgia di regimi che avevano comunque garantito sicurezza senza ansi di competizione, acquisizione, prestazione. ,
In maniera che oscilla tra scetticismo e pessimismo, Huntington si interrogò molto problematicamente anche sull’eventualità di un riflusso non-democratico nei sistemi politici dell’Europa centro-orientale (pp. 303-308), che facesse seguito alla comparsa di una sorta di dittatura elettronica legittimata e resa possibile dalla manipolazione dell’informazione, dei media e di altri sofisticati mezzi di comunicazione (pp. 307-308). Oggi sappiamo che qualcosa di più essenziale è in ballo: la rule of law e i diritti dei cittadini. Non dovremmo, peraltro, parlare di crisi conclamata, ma di sfide da affrontare. Non mi pare questione di lana caprina.
Le possibilità di comparazione intertemporale si moltiplicano a seconda degli interessi e degli obiettivi di ricerca degli studiosi. Ma, qual è il problema, l’interrogativo di ricerca al quale prestare maggiore attenzione: il declino/la crisi dell’Occidente? In quali termini dovremmo declinare, il bisticcio di parole è del tutto voluto, la crisi e le sue componenti? Escludo fin dall’inizio qualsiasi riferimento esclusivo e decisivo alle variabili economiche. D’altronde, fermo restando che studi di questo genere sarebbero utilissimi, anche, soprattutto per i “declinisti”, è semplicissimo rilevare come la maggioranza dei paesi occidentali siano in cima a tutte le classifiche degli indicatori economici e come nessuno, neppure quelli dalle prestazioni peggiori, si trovi nella seconda metà delle classifiche disponibili. Naturalmente, i “declinisti” buttano subito la palla in tribuna e si dirigono verso l’elementi che, quando non sono impalpabili o quasi, risultano di difficilissima, per quanto non del tutto trascurabile, misurazione: paura, nostalgia, ansia et al., esistenti, ma fluttuanti. Tuttavia, possono essere manipolati e mobilitati a favore di politiche populiste. Non c’è dubbio che esistono relazioni anche abbastanza strette fra declinismo e populismo. Infatti, alcuni degli studi migliori del populismo in Occidente guardano proprio a elementi culturali: Pippa Norris e Ronald Inglehart, Cultural Backlash. Trump, Brexit, and Authoritarian Populism (Cambridge, Cambridge University Press, 2019).
Non volendo evitare del tutto una valutazione comparata sono costretto a fare riferimento a un unico indice composito e assolutamente affidabile: l’Indice di Sviluppo Umano elaborato dalle Nazioni Unite. I tre elementi sui quali si basa sono: il reddito pro capite, il livello di istruzione e le aspettative di vita. Quali sistemi politici hanno garantito ai loro cittadini maggiore benessere economico, migliori scuole e sanità più efficiente? Nei primi trenta posti della graduatoria si trovano soltanto sistemi politici occidentali con sei eccezioni: Hong Kong, Singapore, Corea del Sud, Giappone, Israele, Emirati Arabi. Noto che soltanto due delle eccezioni sono regimi non-democratici anche se la Cina ha forse già posto fine alla democrazia in Hong Kong.
Poiché conosciamo l’obiezione che il benessere non rende necessariamente felici, ho fatto una escursione proprio nel campo della felicità. Grazie al World Happiness Report 2022 sono in grado di comunicare ai lettori che nei primi trenta paesi della graduatoria compaiono praticamente gli stessi paesi occidentali. Gli intrusi, per così dire, nella posizioni oltre la ventesima sono Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Taiwan e Singapore (l’Italia è 31esima; la Francia 20esima). Sono paesi nei quali, evidentemente, il tenore di vita, la ricchezza, anche se molto irregolarmente distribuita, fa una differenza per la felicità. Non c’è niente da aggiungere tranne qualche doverosa riserva sulla distribuzione interna della felicità per i paesi grandi produttori di petrolio.
A questo punto, anche per ragioni disciplinari, ritengo importante affermare che qualsiasi analista dovrebbe porsi il compito di connettere il benessere socio-economico con le regole e le procedure di funzionamento del sistema politico. In special modo, questo compito è imperativo per i declinisti: il cosiddetto Occidente non garantisce più il benessere economico anche perché nel suo seno si manifesta la crisi della democrazia liberale che viene rimpiazzata da altri regimi illiberali e non democratici? Purtroppo, nonostante il gran parlare di crisi, riferita all’Occidente, e della superiorità decisionale dei regimi non-democratici, non esiste nessuna analisi comparata che metta in relazione lo sviluppo economico con il tipo di regime. L’interessante analisi pionieristica del commentatore politico Fareed Zakaria (The rise of illiberal democracy, in “Foreign Affairs”, November/December 1997, pp. 22-43) coglie il manifestarsi del fenomeno delle democrazie illiberali nel loro nascere, ma le sue implicazioni e conseguenze sono appena accennate. Gli studi successivi non hanno finora fatto meglio. A mio modo di vedere rimane anche aperto il problema definitorio vale a dire se si possa appropriatamente parlare di democrazia quando mancano gli elementi liberali. Quasi sicuramente, Sartori sosterebbe di no. Sto agiatamente dalla sua parte.
Più spesso che no, con l’eccezione dell’Ungheria e di alcune tendenze in Polonia, le tendenze illiberali si sono manifestate in sistemi politici (l’elenco è di Zakaria) che sarebbe molto ingiustificatamente generoso definire democrazie: Peru, l’Autorità Palestinese, la Sierra Leone, il Pakistan, le Filippine, tanto è vero altri studiosi hanno ricorso piuttosto alla categoria altrettanto scivolosa “autoritarismi competitivi” (Steven Levitsky e Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism. Hybrid Regimes After the Cold War, Cambridge, Cambridge University Press, 2010). Prima, meglio che poi, sarà necessario fare chiarezza, ma il punto rimane. Peraltro, tutte queste etichette, più o meno azzeccate, e le relative esemplificazioni non riguardano che molto marginalmente l’Occidente ovvero due o tre sistemi politici nei quali, per di più, i giochi sono tutt’altro che fatti.
Spiegare (con) la politica. Anche per capire meglio e spiegare le varietà di esperienze e regimi autoritari, appare indispensabile tenere conto del terzo insegnamento di Sartori: fare ricorso fondamentalmente alle variabili politiche. Per quanto implicita, la premessa non potrebbe essere meno importante. Nessun obiettivo esplicativo potrà essere conseguito da chi non sa, non riesce, non vuole separare la politica dalla religione. Non soltanto quanto proposto e effettuato da Machiavelli è assolutamente decisivo per chi fa e per chi analizza la politica. Oserei dire che è il precetto analitico e politico occidentale per eccellenza: l’autonomia della politica. Sappiamo che questo precetto è negato in radice e respinto da tutti i fondamentalismi, in modo particolarmente brutale dall’Islam, come prova ad abundantiam la teocrazia al potere in Iran.
Se la politica nella sua essenziale autonomia va spiegata con la politica, allora tre insiemi di elementi meritano di essere presi in considerazione e analizzati: le idee/ideali; le regole e le procedure; le istituzioni. Non è questa la sede nella quale andare alla ricerca delle modalità con le quali si sono affermate le tre grandi idee “occidentali” vessillo della Rivoluzione francese: libertà, eguaglianza, solidarietà (che è la mia traduzione di fraternité). Pur senza svolgere una ricognizione approfondita, credo si possa dire che queste idee/ideali occidentali non hanno trovato accoglienza unanime né elaborazioni ulteriori nel mondo non occidentale. Naturalmente, dobbiamo, da un lato, preoccuparci tutte le volte che quelle idee/ideali vengono trascurate e tradite nello stesso Occidente, ma, dall’altro, rallegrarci, non sono gli unici esempi, quando a Hong Kong gli studenti e a Teheran le donne manifestano a loro sicuro rischio e pericolo esponendo striscioni inneggianti alla libertà, più precisamente, poiché il messaggio è inteso per il mondo, freedom. Il riferimento è alla libertà politica, ma anche alla libertà dalla paura, alla libertà nella scelta degli stili di vita non, come spesso sostengono pensatori e politici occidentali, alla deregolamentazione.
Le regole e le procedure, vale a dire la famosa/famigerata democrazia “formale” senza la quale non riuscirebbe mai ad emergere, a affermarsi, a persistere nessuna democrazia “sostanziale”, stanno nelle Carte costituzionali, altro grande prodotto politico-culturale dell’Occidente. Incidentalmente, il costituzionalismo è inseparabile dal liberalismo e viceversa. Infatti, nel mondo non democratico, non occidentale le Costituzioni non danno nessuno spazio ai precetti liberali e sono, per lo più, carta straccia.
Il discorso sulle istituzioni dell’Occidente richiede un più ampio respiro. Deve partire dalla pietra miliare della separazione delle istituzioni e dei loro rispettivi poteri come delineata da Montesquieu nel saggio De l’esprit des lois (1748). Strappare potere all’esecutivo assegnandolo oculatamente al legislativo e al giudiziario nella consapevolezza che i confini saranno sempre oggetto di conflitti, ma anche che quei conflitti non dovranno mai terminare con la vittoria assoluta, irreversibile di un potere sugli altri. L’Occidente come è evoluto da allora e come lo conosciamo è caratterizzato da una notevole varietà di forme di Stato (monarchie/repubbliche; stati accentrati/stati federali, l’Unione Europea essendo uno Stato federale in the making) e di forme di governo (parlamentari, presidenziali, direttoriali, semipresidenziali) il cui cardine è la democraticità, vale a dire il rapporto di accountability fra rappresentanti e elettori. Il termine migliore per designare questa peculiarità occidentale non è il troppo vago “varietà”, ma pluralismo, anzitutto, weberianamente inteso, come autonomia delle diverse sfere di attività degli uomini e delle donne: cultura, economia, religione, scienze sociali, ciascuna con i suoi specifici criteri razionalità. In Occidente l’autonomia di queste sfere, ciascuna e tutte, è garantita. In secondo luogo, il pluralismo va compreso e riferito alla molteplicità dinamica di esperienze in competizione che nascono, si trasformano, muoiono, si ripresentano sotto mutata forma, ma dentro i canoni democratici. Proprio dentro quei canoni si sviluppa la competizione che, anche se viene esposta al rischio di una conquista egemonica, grazie al pluralismo strutturale e sociale risulta in grado di farvi fronte con successo. La sfida “monista” di Donald Trump, “Make America Great Again”, che mirava a concentrare tutto il potere politico nelle sue mani in quanto vincitore delle elezioni presidenziali, ha costituito il momento della verità per la democrazia USA. La sua sconfitta, anche se non è ancora scontato che sia definitiva, parla di anticorpi democratici diffusi e sufficientemente solidi.
Nel quadro di questo rassicurante pluralismo, non è, però, da sottovalutare il pericolo evidenziato da Vera Zamagni (Occidente, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 102-107) consistente nella mancanza nelle democrazie di un principio trascendente. In società caratterizzate da pluralità di credenze religiose e non religiose, probabilmente confortate dalla convinzione che nessuno tenterà di imporre a tutti gli altri la propria credenza, il proprio principio trascendente e esclusivo, non sembra che vi sia spazio per procedere in questo senso. In verità, la battaglia è in corso, in maniera molto esacerbata da qualche decennio negli USA. In Europa, neppure la presenza già vistosa e imponente dell’Islam ha finora suscitato richieste di un fronte comune a sostegno di un unico principio trascendente in grado di contrapporsi all’Islamismo. Questa reductio ad unum non sarebbe comunque coerente con la evoluzione e l’essenza dell’Occidente. Piuttosto dovremmo attenderci conflitti fra ideali, società più coese, individualismi più marcati, tensioni fra spazi di libertà e esigenze di eguaglianza. Il pluralismo dell’Occidente è spesso più che semplicemente competitivo; è anche conflittuale, sanamente tale.
Non finisce qui.
Pretendere di offrire una sintesi alla visione di Occidente che ho qui delineato sarebbe altrettanto incongruente con il mio tentativo svolto all’insegna del pluralismo e della competizione. Questo Occidente è apparentemente permeabile poiché in effetti è una “società aperta”, proprio come voleva il filosofo e epistemologo austriaco Karl Popper (1902-1994), ma non è conquistabile. Al contrario, l’Occidente dilaga con le sue idee e il suo esempio e le società chiuse reagiscono con risentimento e rancore, con repressione. L’Occidente risulta spesso capace di adattamenti nei limiti che di volta in volta stabilisce lui stesso. Gli occidentali hanno imparato a scegliere fra ragione e coscienza, a combinare, proprio come desidererebbe Max Weber, l’etica della convinzione con l’etica della responsabilità. Più problematicamente, le loro democrazie sono approdate alla consapevolezza che la pax kantiana, quella fra Repubbliche che sanno federarsi, è possibile e duratura, perpetua (che è l’aggettivo usato da Immanuel Kant). Lo hanno imparato a caro prezzo le democrazie del cuore dell’Europa costruendo l’Unione Europea. La lezione è giunta ai sistemi politici dei Balcani che faticosamente agiscono di conseguenza per ottenere di aderirvi. Non è finita.
D’altro canto, più in generale, che tuttora vi siano problemi e sfide, nell’Occidente e contro l’Occidente, non autorizza e non consente a nessuno, meno che mai ai non occidentali, di parlare di crisi dell’Occidente. Al contrario, rifiutando nei fatti e nei comportamenti le tesi dei declinisti, ogni giorno milioni di donne e uomini riconoscono che l’Occidente, si chiami Europa o USA, Svezia o Germania, Texas o California, Australia o Canada, è innegabilmente luogo agognato e preferito di diritti umani, di opportunità e di istituzioni, di pluralismo e di competizione nel quale vivere e fare vivere le proprie famiglie. Anche per chi la pensa così e tutt’altro che soltanto nella mia mente, questo è l’Occidente.
VIDEO Come si può essere o non essere italiani? Cosa vuol dire essere cittadini italiani in Europa? #paradoxa 2/2020

Essere (o non essere) italiani, a cura di Gianfranco Pasquino, Paradoxa, Anno XIV – Numero 2 – Aprile/Giugno 2020
LA NON COSTRUZIONE DELL’ITALIANITÀ
Gianfranco Pasquino
Premessa
Poiché ho da tempo acquisito, anche sulla scia di buone letture (classica e insuperata quella del libro di P. Berger e T. Luckmann, La realtà come costruzione sociale, pubblicato dal Mulino nel 1969), la convinzione che qualsiasi appartenenza nazionale costituisca una delle componenti della costruzione personale e sociale dell’identità, le pagine che seguono sono state elaborate di conseguenza. Vale a dire che, con l’obiettivo di pervenire ad una spiegazione del mio rapporto con quella che chiamo “italianità”, ho intrecciato alcune mie esperienze personali con avvenimenti “storici” e con interpretazioni di commentatori e di studiosi. Non ho nessuna pretesa di avere conseguito una spiegazione generalizzabile. Nutro, però, più di una speranza di avere gettato un po’ di luce su una problematica che, con tutta la sua complessità e, talvolta, vaghezza, riguarda valori e comportamenti che influenzano rapporti e modi d’essere nazionali e internazionali tutt’altro che trascurabili e irrilevanti. Credo che sarebbe interessante, anche con l’obiettivo di ottenere una visione comparata, leggere esperienze di altre persone, in altri tempi e in altri luoghi. Finora, le mie letture non sono arrivate a tanto.
Delle origini
Per un lungo periodo di tempo non ho avuto nessuna occasione nella quale pormi il quesito relativo all’essere (o non essere) italiano e, meno che mai, di che tipo di italiano fossi o desiderassi essere/diventare oppure, meglio non diventare. Certamente, non m’interrogai sulle differenze intercorrenti fra me, torinese, e i molti ragazzi meridionali giunti a vivere nel mio quartiere. Il fatto che al Liceo i miei insegnanti di italiano, latino e greco e di scienze fossero siciliani non mi sembrò qualcosa di rilevante. Negli anni Cinquanta dello scorso secolo, la divisione “culturale”, nel senso antropologico, Nord/Sud non stava nei miei pensieri e neppure nei miei pregiudizi. Apprezzai “Rocco e i suoi fratelli” in quanto racconto della vita di una famiglia senza dare particolare peso o significato all’essere quella una famiglia meridionale trasferitasi nel cuore del Nord, a Milano. Leggevo e studiavo la storia d’Italia e dell’Europa senza nessuna visione nazionalistica né fierezza e orgoglio né senso di inferiorità. Non ricordo fra i miei compagni di classe voci che esprimessero particolare apprezzamento, in sé o con paragoni, per il nostro essere italiani.
Quando, nella prima esperienza all’estero, in Francia dove c’era una ottima scuola per imparare il francese, a La Rochelle, fui esposto a ragazzi e ragazze di molte nazioni europee, non furono le diversità che mi colpirono. Al contrario, quel 13 agosto 1961, giorno in cui cominciò la costruzione del Muro di Berlino, nell’evidente dolore degli studenti tedeschi, ma forse anche con qualche loro rassegnazione: “ancora il prezzo da pagare per i crimini nazisti”, e nella grande condivisione, in forme diverse e contenute, ma tutte chiare, degli altri studenti dagli svedesi agli inglesi, dai pochi spagnoli agli austriaci, dagli svizzeri agli italiani (che, peraltro, evitavo cercando di parlare esclusivamente in francese) e allo staff, docenti e assistenti, francese, mi si manifestò in maniera visibilissima l’Europa. Negli sguardi e nelle poche parole di tutti apparve lampante che, per quanto inconsapevolmente, stava in noi un sentimento comune e condiviso. Era il sentimento della libertà sotto ogni forma di cui godevamo noi, che da molti paesi europei eravamo arrivati in quello che fu uno dei più importanti luoghi frequentati e popolati dagli Ugonotti. Quel sentimento si tradusse e si espresse nella critica di quel grave evento e nella preoccupazione per tutto quanto quel Muro che separava Berlino segnalava, significava e faceva supporre.
Non posso interpretare pensieri e valutazioni di tutti quegli studenti europei, ma la loro riprovazione non nasceva sicuramente dalle appartenenze nazionali. C’era molto di più. Sì, lo scriverò con la necessaria retorica, c‘era il sentimento fino ad allora inconsapevole che, in effetti, qualcosa ci accomunava, noi ragazze e ragazzi europei, non credo di esagerare, qualcosa che quel Muro temeva e voleva separare fisicamente. La mia italianità, la Britishness, persino la grandeur francese (De Gaulle era allora il Presidente della Quinta Repubblica) e le altre appartenenze nazionali erano tutte recedute soppiantate da una convinzione (credenza?): l’essere europei, portata alla luce.
Quello che allora era solo il Corso di Laurea in Scienze Politiche a Torino era qualificabile, senza bisogno di dirlo, come “europeista” in quasi tutti i suoi docenti (uno solo dei quali aveva un noto passato fascista) e nella maggioranza degli insegnamenti. Il nazionalismo non abitava a Palazzo Campana. Grandi autori e grandi libri venivano dalla Francia e dalla Germania, dalla Gran Bretagna e dalla Svezia (il famoso economista Gunnar Myrdal e il “modello” socialdemocratico), molto più che dagli Stati Uniti d’America, e la storia moderna e contemporanea, anche quando l’argomento era l’Italia, veniva insegnata in prospettiva europea che si trattasse dell’industrializzazione (Gerschenkron, Il problema storico dell’arretratezza economica, 1962) o della resistenza. Non c’era ragione di soffermarsi sulle peculiarità (positive e/negative) italiane tranne che nell’analisi del fascismo. Nella città di Piero Gobetti, era molto facile respingere l’interpretazione crociana del fascismo come parentesi, e aderire con pochissime specificazioni e variazioni, alla tesi del fascismo “autobiografia della nazione”: che il fascismo era stato nche, forse, soprattutto, la conseguenza della inadeguatezza e dei cedimenti delle classi politiche italiane e delle cattive modalità di funzionamento della democrazia. In uno dei luoghi più antifascisti d’Italia, la “nazione” faceva una davvero brutta figura rispetto alla città di Torino e alla sua università (che non era dimentica di quel manipolo di professori i quali, avendo rifiutato di giurare obbedienza al Duce, persero consapevolmente il posto), a valori e comportamenti civili.
Che avendo i sabaudi “fatta l’Italia”, bisognasse, nella famosa frase attribuita (ma, certamente, ne condensava il pensiero politico di fondo) al torinese Massimo D’Azeglio, “fare gli italiani” era un dato di fatto, una constatazione sostanzialmente indisputabile, non messa in questione. Peraltro, quello che era un imperativo, politico e morale, non serviva certamente a suscitare sentimenti nazionalisti. Prima di diventare orgogliosi dell’Italia, era indispensabile che gli italiani acquisissero molte qualità che, forse, potremmo sintetizzare non tanto nell’amor di Patria, ma nel senso civico, nella disponibilità mazziniana all’adempimento dei doveri a cominciare da quelli scritti nella Costituzione repubblicana.
Anche se l’argomento del come fare gli italiani non fu mai preso di petto nei corsi che seguii, faceva capolino nelle lezioni di storia delle dottrine politiche di Luigi Firpo. Talvolta veniva evocato Giacomo Leopardi per la sua analisi spietata dei vizi degli italiani. Spesso veniva indirettamente criticato il nazionalismo fascista come cattivo maestro di malposta italianità. Insomma, nelle mie esperienze di studente non ebbi nessuno stimolo a definire la mia italianità né, meno che mai, ad essere particolarmente orgoglioso della mia appartenenza alla Nazione. Lo so, naturalmente, che, leggendo queste frasi, alcuni deprecheranno tanto l’internazionalismo della sinistra quanto, forse più, la versione piemontese, asciutta e severa, “moralistica” per i critici, intransigente, dell’Azionismo. Personalmente, non condivido in nulla queste critiche, nel frattempo divenute noiose e stantie, ma so che l’ambiente dei miei studi e le convinzioni dei miei docenti non lasciavano spazio a nessuna conquista o fierezza di italianità. Irrilevante. Per di più, nessuna versione di italianità intervenne nella costruzione della mia personale identità alla quale contribuirono letture come Cesare Pavese, Carlo Levi, Italo Calvino, Primo Levi e Beppe Fenoglio nei quali è impossibile ritrovare qualsiasi accentuazione di italianità, al tempo stesso che si esprimono valori civili di permanente rilevanza che stanno e vanno oltre qualsiasi considerazione “nazionale”.
Non una sola appartenenza
Da nessuna parte in Europa degli anni Sessanta del secolo scorso fecero la loro comparsa espressioni particolarmente significative di nazionalismo, neanche, semplicemente, nella versione di orgoglio nazionale. Per quel che mi riguarda, invece, tre episodi molto diversi, ma concatenati, mi esposero in maniera inaspettata al tema dell’appartenenza nazionale. Nel 1965 fui ammesso al Bologna Center della Johns Hopkins per un Master in Relazioni Internazionali, 160 studenti, metà statunitensi metà europei dei quali sei italiani. I primi ostentatamente fieri, persino troppo, della loro cittadinanza (credevano ancora al cosiddetto “eccezionalismo” americano appena incrinato dall’assassinio del Presidente Kennedy e c’era anche uno studente che veniva proprio da Dallas), gli europei di rimbalzo consci delle differenze culturali intercorrenti e delle loro specificità, disposti a vantarle. Noi italiani, di provenienze regionali diverse, certo collocati dalla parte degli europei, non eravamo comunque interessati a nessun vanto, ma coglievamo le diversità. Lo dirò così: “sì, c’è qualcosa di specificamente italiano, persino, positivamente tale” (un pensiero che non avevo mai avuto in precedenza) che attribuivo davvero alla cultura e, allora, persino, all’istruzione che si poteva ottenere nei licei un po’ dappertutto in Italia.
Vinta la borsa di studio per proseguire il secondo anno alla School of Advanced International Studies di Washington D.C., mi venne anche offerta la possibilità di acclimatarmi alla vita in USA, dove non ero mai stato in precedenza, grazie ad un programma che prevedeva quattro settimane ospite di una famiglia americana. Mi accolse una famiglia di Montclair, ricco sobborgo del New Jersey, repubblicana, molto benestante, con quattro figli, il più grande intorno ai vent’anni, il padre operatore economico di alto livello a Wall Street che faceva giornalmente il commuter. Quando chiesi come ero finito lì, se erano stati loro a sceglier/mi, la signora, donna squisita dell’alta borghesia di Philadelphia, mi rispose candidamente che l’alternativa era un africano del Ghana, peraltro un Ashanti, gruppo etnico molto importante e potente, e che avevano preferito l’italiano. Capii, allora, che la nazionalità era un fattore di qualche importanza (…).
Il terzo episodio è il più importante. Studiando Scienza politica alla School of Advanced International Studies mi imbattei (è il verbo giusto poiché il testo di cui parlerò non faceva parte delle letture assegnate) nella ricerca comparata di Gabriel Almond e Sidney Verba, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton University Press 1963), uno dei libri di scienza politica più giustamente citati e influenti del secolo scorso. Per rendere breve, come dicono gli inglesi, una storia molto lunga, il dato che mi colpì maggiormente è che per gli Americani, gli inglesi e i messicani l’elemento di cui erano più fieri era chiaramente politico, rispettivamente: la Costituzione, il modello di governo, noto come Westminster, la rivoluzione, mentre per i tedeschi, i quali ad appena vent’anni dalla sconfitta del regime nazional-socialista (non necessariamente delle idee naziste) preferivano tenersi lontani dalla politica, era l’economia sociale di mercato. Per gli italiani la dispersione delle risposte premiava il Bel Paese, cioè la bellezza del territorio e delle città, e i grandi poeti e artisti del passato (Leonardo, Michelangelo, Dante) relegando la politica in un secondo piano molto lontano. Più che sorprendermi, questi dati mi incuriosirono assai. Di tanto in tanto continuo a chiedermi non soltanto quale risposta avrei dato allora e darei oggi, ma anche quali dovrebbero essere gli elementi da porre a fondamento della mia identità, della mia, più o meno pallida, italianità.
Negli anni Novanta che la politica (italiana) c’entrasse con l’italianità me lo fecero sentire i colleghi studiosi di politica che incontravo ai convegni accademici in vari paesi europei, negli USA e in diversi stati latino-americani. Ricordo la perplessità, la cautela, la sensazione di un “tenere le distanze”, l’imbarazzo iniziale di molti di coloro che mi incontravano per la prima volta negli anni del berlusconismo. Avevano a che fare con un italiano sostenitore di Berlusconi? Potevano criticare liberamente il fondatore e leader di Forza Italia, il fenomeno inusitato di un magnate delle televisioni private, del più ricco uomo italiano diventato capo del governo senza nessuna precedente esperienza in clamoroso conflitto di interessi? Da che parte stavo e, dunque, che “italiano” ero? Mi resi conto che, agli occhi di molti stranieri, certo, per lo più, ma non solo, accademici: politologi, sociologi, storici, la mia identità di italiano era concepita in termini politici, con riferimento alle mie eventuali preferenze politiche che, però, per non pochi di loro riflettevano pregiudizi su un popolo che, più o meno pittorescamente, non rispetta le regole.
Da un lato, ho regolarmente tentato di offrire una sobria analisi delle condizioni e delle modalità dell’avvento di Berlusconi, considerandolo ampiamente rappresentativo di una parte nient’affatto marginale dell’elettorato italiano. Dall’altro, non ho mai rinunciato alla critica della politica e dei politici dei paesi di provenienza dei miei interlocutori. Grande, enorme è dal 2016 il mio compiacimento nel dire alto e forte che, in quanto a cultura politica e pericolosità per le istituzioni e per il mondo, il Presidente Donald Trump è incomparabilmente peggiore di Berlusconi, e, insomma, il Primo ministro Boris Johnson non è sicuramente il modello di leader anglosassone al quale intendiamo guardare e aspirare. A proposito di Berlusconi, ho pensato, scritto e variamente argomentato che la sua comparsa e vittoria costituiscono una parte, non trascurabile della autobiografia della nazione in molti dei tratti che ritengo deprecabili. Li sintetizzo con le parole di Paolo Bagnoli: “L’Italia è un Paese che, per indole, non ama la sobrietà, la compostezza, la misura” (I ‘capiscioni’ smemorati, in “NON MOLLARE” (quindicinale online), n. 60, 16 marzo 2020). Chiudo su questo punto segnalando che mai, nel corso del berlusconismo, ho detto che mi vergognavo di essere italiano e mai ho annunciato che andavo in esilio. Anzi, ho trovato sgradevoli e politicamente inutili, se non addirittura controproducenti, entrambe le affermazioni.
Dell’italianità in politica
Rimanendo nella italianità riferita alla sfera politica, personalmente, senza in nessun modo lodare le mie preferenze politiche, solide e durature, mai intrecciate con un partito, ma collegate piuttosto ad una visione di società, ho preso ad interrogarmi su quel che rimprovero agli italiani. Mi è parso più utile anche per capire che cosa potrebbe essere l’italianità con la quale riuscirei ad identificarmi (ovvero, a sentirmi meno lontano).
Naturalmente, non propongo affatto un’analisi definitiva dei complessi rapporti degli italiani con la politica (per chi volesse saperne di più rimando ai libri del grande antropologo Carlo Tullio-Altan: Populismo e trasformismo. Saggio sulle ideologie politiche italiane, Milano, Feltrinelli, 1989 e La coscienza civile degli italiani. Valori e disvalori nella storia nazionale, Udine, Gaspari, 1995). Non seguirò la storia molto italiana dell’antipolitica e dell’antiparlamentarismo che ha spesso condotto alla critica della democrazia e al suo indebolimento. Non discuterò né di coloro che continuano a fare elogi eccessivi e senza fondamento degli italiani (la società “civile” nella sua interezza) né di coloro che mantengono la loro purezza “non prendendo neppure un caffè con i politici” [per chi non lo ricordasse fu questo, mai criticato dai suoi colleghi, uno dei grandi vanti di Indro Montanelli che addirittura contribuì alla sua fama]. Non voglio rinunciare a due citazioni che riflettono sulla drammatica epopea del coronavirus, da destra, Danilo Breschi: “ e l’italiano potrebbe persino mostrarsi il più accorto, il più amante della libera democrazia”, in Emergenza: maneggiare con cura, 19 marzo 2020; da sinistra, il Ministro Roberto Gualtieri. Lodata la grande dimostrazione di senso di appartenenza nazionale, il Ministro afferma, alquanto prematuramente che: “siamo diventati un modello sia nella gestione dell’emergenza sanitaria sia nella gestione delle sue conseguenze economiche”. Ne conclude che “credo che potremmo diventare un modello anche sul piano dei comportamenti e dell’etica pubblica” (L’intervista in “Corriere della Sera”, 20 marzo 2020, p. 11).
In senso lato, possiamo ritenere e sostenere che tanto l’orgogliosa separatezza rivendicata da numerosi esponenti della società civile quanto le affermazioni di superiorità di chi “non fa politica” siano elementi costitutivi dell’identità italiana. Da tempo l’Uomo Qualunque, nato in Italia, continua ad aggirarsi fra noi e ha dimostrato straordinarie capacità di trasformazione (di trasformismo) arrivando fino ad oggi, premiato nelle elezioni del 2013 e del 2018 da milioni di elettori/elettrici. Può persino contare su volonterosi megafoni, non solo nelle numerose rubriche delle lettere dei lettori al Direttore (una ricerca, che non consiglio a nessuno, su quelle lettere e sulle risposte di chi tiene la rubrica, fornirebbe uno straordinario spaccato dell’Italia reale e delle componenti dell’italianità). Ancora adesso l’interconnessione “società/politica” deve essere ribadita, come fa Ernesto Galli della Loggia, Il passato ci frena ancora. Scelte guidate dal consenso, Corriere della Sera, 11 marzo, p. 32: “Agli italiani più che la possibilità di contare su reti di servizi efficienti, su prestazioni dagli standard adeguati, in tempi rapidi e in sedi attrezzate, più di questo è sempre importato avere dallo Stato un’altra cosa: soldi. Soldi direttamente dalle casse pubbliche alle proprie tasche”. Non propriamente un “compromesso socialdemocratico”. Lo chiamerò compromesso clientelare. Però, il frenatore del titolo dell’articolo di Galli della Loggia non è il passato. Il frenatore, nell’accezione datagli dall’editorialista, fa parte costitutiva, integrale dell’italianità.
Al proposito, chiunque volesse stilare un elenco delle componenti dell’italianità finirebbe inevitabilmente per farlo, da un lato, in maniera selettiva e, forse, perentoria, dall’altro, individuando in particolare le caratteristiche degli italiani che non condivide, che lo irritano, che ritiene sostanzialmente deleterie e intollerabili. Non sono in grado di sfuggire a questi esiti e, a ragion veduta, rinuncio. Tuttavia, devo in qualche modo concludere la riflessione condotta fin qui. Lo farò con due osservazioni a ampio raggio.
Italianità e emergenza
Di recente in diverse conferenze in contesti diversi, specialmente all’estero, mi sono trovato a citare con approvazione la risposta data da uno studente alla richiesta, abituale nei dibattiti internazionali, di identificarsi. Lo studente in questione rispose con nome e cognome aggiungendo “sono un europeo nato a Torino”. Interpreto “europeo” come un’affermazione di identità e di identificazione con il progetto federalista di un’Europa politicamente unificata, ma anche come adesione ai valori democratici sui quali si fonda e si costruisce quel progetto. E interpreto il riferimento a Torino come il richiamo ad un humus, a radici culturali, a un’esperienza di vita e costumi considerata importante per la costruzione della personalità. Qualcuno potrebbe aggiungere che in quella frase non si trova nulla che richiami l’italianità. Pour cause, poiché lo studente (e ancora una volta concordo) voleva esplicitamente dare una spinta al superamento delle identità nazionali, intese come ostacolo alla costruzione di una identità europea. Sento subito montare il dissenso a questa affermazione, dissenso di frasi fatte tipo “solo forti identità nazionali daranno vita a una forte identità europea”. Finora non ho visto tentativi di sostanziare in maniera non retorica questa affermazione. Quindi, non ho modo di poterla (e neppure l’obbligo di doverla) discutere.
La seconda osservazione riguarda la ricomparsa in occasione dell’emergenza causata dal coronavirus di una frase altrettanto fatta (già spesso periodicamente utilizzata) il cui controllo empirico, fattuale è assolutamente inesistente. La frase, che è stata sulla bocca di quasi tutti gli editorialisti e gli opinionisti, non solo della domenica, nei talk show, è: “nell’emergenza gli italiani danno il meglio di sé”. Questa convinzione, meglio credenza, è talmente diffusa che è stata espressa anche nelle parole, in parte guidate dall’intervistatore, di un famoso calciatore poi allenatore Cesare Prandelli:
D. “Gli italiani nelle difficoltà riescono a fare squadra”.
R. “Fatichiamo ad accettare le regole, ma quando siamo responsabilizzati diamo il meglio, andando oltre le solite liti politiche. Spero che possiamo essere un esempio per gli altri Paesi della Comunità europea”. (Corriere della Sera, 16 marzo 2020, p. 11).
Più sfumato il sondaggista Nando Pagnoncelli: “nelle situazioni difficili il Paese dà il meglio di sé, basti pensare all’abnegazione dei medici e degli operatori sociosanitari e ai piccoli e grandi gesti di altruismo e generosità … relegando in secondo piano alcuni disdicevoli episodi che non ci siamo fatti mancare” (Le strategie decise dal governo promosse dal 62% degli italiani , in “Corriere della Sera” 14 marzo p. 12)
Sarebbe utile verificare quanto e come in occasioni di grandi emergenze, terremoti e inondazioni, non oso menzionare né la mafia né i terrorismi (al plurale), gli italiani abbiano dato il meglio di sé. Immagino che questo “meglio” si configuri come impegno personale (e collettivo) di energie e di tempo, forse anche di denaro, in attività altruistiche e collettive per risolvere e porre fine a quella specifica emergenza. La ricostruzione post-bellica, evento eccezionale, ma assolutamente non frutto di una emergenza, non mi pare un esempio appropriato Per carità di patria, non mi soffermerò sugli scandali, sugli sciacalli, sui profittatori sempre presenti, con pochissime eccezioni, una delle quali sembra essere la ricostruzione post-terremoto in Friuli nel 1976. Vero, parzialmente vero, non-vero che gli italiani sono donne e uomini (più) adatti alle emergenze’? Qui mi limiterò a dire che nell’emergenza del coronavirus a dare il meglio di sé sono stati i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario. Degli altri, di quelle decine di migliaia di persone che hanno violato l’indicazione di restare a casa, discuteremo un’altra volta. Nel frattempo, mi sento di affermare che il buon cittadino è colui che dà sempre il meglio di sé.
Per andare oltre
Naturalmente, mi sono più volte chiesto a che cosa serve/a l’italianità. Cercarla in quello che hanno scritto alcuni italiani da Leopardi a Gioberti da Manzoni fino a De Sanctis può essere un esercizio letterario di grande interesse (come quello offerto da Giulio Bollati, Il carattere nazionale come storia e come invenzione, Einaudi 2011, spec. pp. 35-127), ma mi sembra che, tutto sommato, rimanga senza rilevanza per la vita degli italiani e per la qualità del sistema politico e della democrazia. Che cosa conta fregiarsi del bollino “alta Italianità”? Che messaggio manda agli altri italiani e agli stranieri? Affidabilità o no? I frequenti richiami al Risorgimento, all’unità della patria, alla appartenenza nazionale sono concepibili, anche se non sempre accettabili, come una modalità da utilizzare per costruire e preservare la coesione sociale. Un sistema politico, una comunità nazionale, un regime democratico funzionano meglio, acquisiscono un’alta qualità, producono beni collettivi più abbondanti e, persino, li redistribuiscono in maniera più equa e più soddisfacente laddove la appartenenza nazionale, in questo caso, l’italianità, ha cementato una solida consapevole coesione sociale tramandata fra le generazioni. Capisco, ma non sono del tutto convinto che la coesione sociale derivi per una (in)certa parte dalla diffusione dell’italianità. Credo, ma lo pongo in maniera problematica, che la coesione sociale sia e debba essere il prodotto e la conseguenza del riconoscimento che esiste un patto fra persone, fra cittadini. Si chiama Costituzione ed è intessuto di leggi che regolano i rapporti fra i cittadini e fra i cittadini, i rappresentanti e governanti. Allora, sì, sono italiano perché riconosco nella Costituzione repubblicana del 1948 un patto degno di essere rispettato e attuato. Riconosco anche che quella Costituzione e il patto in essa contenuto e sancito mi offrono la opportunità di sentirmi e essere europeo. Se questo è “patriottismo costituzionale”, allora sono anche quel tipo di patriota. L’italianità sta nella Costituzione, si esprime attraverso la Costituzione, costruisce una comunità in grado di scegliere e decidere, cambiare e perseguire le sue preferenze. Capovolgendo Cicerone: ubi libertas ibi patria.
Pubblicato in Essere (o non essere) italiani, a cura di Gianfranco Pasquino, Paradoxa, Anno XIV – Numero 2 – Aprile/Giugno 2020
Essere (o non essere) italiani, a cura di Gianfranco Pasquino, Paradoxa, Aprile/Giugno 2020

Essere (o non essere) italiani, a cura di Gianfranco Pasquino, Paradoxa, Anno XIV – Numero 2 – Aprile/Giugno 2020
LA NON COSTRUZIONE DELL’ITALIANITÀ
Gianfranco Pasquino
Premessa
Poiché ho da tempo acquisito, anche sulla scia di buone letture (classica e insuperata quella del libro di P. Berger e T. Luckmann, La realtà come costruzione sociale, pubblicato dal Mulino nel 1969), la convinzione che qualsiasi appartenenza nazionale costituisca una delle componenti della costruzione personale e sociale dell’identità, le pagine che seguono sono state elaborate di conseguenza. Vale a dire che, con l’obiettivo di pervenire ad una spiegazione del mio rapporto con quella che chiamo “italianità”, ho intrecciato alcune mie esperienze personali con avvenimenti “storici” e con interpretazioni di commentatori e di studiosi. Non ho nessuna pretesa di avere conseguito una spiegazione generalizzabile. Nutro, però, più di una speranza di avere gettato un po’ di luce su una problematica che, con tutta la sua complessità e, talvolta, vaghezza, riguarda valori e comportamenti che influenzano rapporti e modi d’essere nazionali e internazionali tutt’altro che trascurabili e irrilevanti. Credo che sarebbe interessante, anche con l’obiettivo di ottenere una visione comparata, leggere esperienze di altre persone, in altri tempi e in altri luoghi. Finora, le mie letture non sono arrivate a tanto.
Delle origini
Per un lungo periodo di tempo non ho avuto nessuna occasione nella quale pormi il quesito relativo all’essere (o non essere) italiano e, meno che mai, di che tipo di italiano fossi o desiderassi essere/diventare oppure, meglio non diventare. Certamente, non m’interrogai sulle differenze intercorrenti fra me, torinese, e i molti ragazzi meridionali giunti a vivere nel mio quartiere. Il fatto che al Liceo i miei insegnanti di italiano, latino e greco e di scienze fossero siciliani non mi sembrò qualcosa di rilevante. Negli anni Cinquanta dello scorso secolo, la divisione “culturale”, nel senso antropologico, Nord/Sud non stava nei miei pensieri e neppure nei miei pregiudizi. Apprezzai “Rocco e i suoi fratelli” in quanto racconto della vita di una famiglia senza dare particolare peso o significato all’essere quella una famiglia meridionale trasferitasi nel cuore del Nord, a Milano. Leggevo e studiavo la storia d’Italia e dell’Europa senza nessuna visione nazionalistica né fierezza e orgoglio né senso di inferiorità. Non ricordo fra i miei compagni di classe voci che esprimessero particolare apprezzamento, in sé o con paragoni, per il nostro essere italiani.
Quando, nella prima esperienza all’estero, in Francia dove c’era una ottima scuola per imparare il francese, a La Rochelle, fui esposto a ragazzi e ragazze di molte nazioni europee, non furono le diversità che mi colpirono. Al contrario, quel 13 agosto 1961, giorno in cui cominciò la costruzione del Muro di Berlino, nell’evidente dolore degli studenti tedeschi, ma forse anche con qualche loro rassegnazione: “ancora il prezzo da pagare per i crimini nazisti”, e nella grande condivisione, in forme diverse e contenute, ma tutte chiare, degli altri studenti dagli svedesi agli inglesi, dai pochi spagnoli agli austriaci, dagli svizzeri agli italiani (che, peraltro, evitavo cercando di parlare esclusivamente in francese) e allo staff, docenti e assistenti, francese, mi si manifestò in maniera visibilissima l’Europa. Negli sguardi e nelle poche parole di tutti apparve lampante che, per quanto inconsapevolmente, stava in noi un sentimento comune e condiviso. Era il sentimento della libertà sotto ogni forma di cui godevamo noi, che da molti paesi europei eravamo arrivati in quello che fu uno dei più importanti luoghi frequentati e popolati dagli Ugonotti. Quel sentimento si tradusse e si espresse nella critica di quel grave evento e nella preoccupazione per tutto quanto quel Muro che separava Berlino segnalava, significava e faceva supporre.
Non posso interpretare pensieri e valutazioni di tutti quegli studenti europei, ma la loro riprovazione non nasceva sicuramente dalle appartenenze nazionali. C’era molto di più. Sì, lo scriverò con la necessaria retorica, c‘era il sentimento fino ad allora inconsapevole che, in effetti, qualcosa ci accomunava, noi ragazze e ragazzi europei, non credo di esagerare, qualcosa che quel Muro temeva e voleva separare fisicamente. La mia italianità, la Britishness, persino la grandeur francese (De Gaulle era allora il Presidente della Quinta Repubblica) e le altre appartenenze nazionali erano tutte recedute soppiantate da una convinzione (credenza?): l’essere europei, portata alla luce.
Quello che allora era solo il Corso di Laurea in Scienze Politiche a Torino era qualificabile, senza bisogno di dirlo, come “europeista” in quasi tutti i suoi docenti (uno solo dei quali aveva un noto passato fascista) e nella maggioranza degli insegnamenti. Il nazionalismo non abitava a Palazzo Campana. Grandi autori e grandi libri venivano dalla Francia e dalla Germania, dalla Gran Bretagna e dalla Svezia (il famoso economista Gunnar Myrdal e il “modello” socialdemocratico), molto più che dagli Stati Uniti d’America, e la storia moderna e contemporanea, anche quando l’argomento era l’Italia, veniva insegnata in prospettiva europea che si trattasse dell’industrializzazione (Gerschenkron, Il problema storico dell’arretratezza economica, 1962) o della resistenza. Non c’era ragione di soffermarsi sulle peculiarità (positive e/negative) italiane tranne che nell’analisi del fascismo. Nella città di Piero Gobetti, era molto facile respingere l’interpretazione crociana del fascismo come parentesi, e aderire con pochissime specificazioni e variazioni, alla tesi del fascismo “autobiografia della nazione”: che il fascismo era stato nche, forse, soprattutto, la conseguenza della inadeguatezza e dei cedimenti delle classi politiche italiane e delle cattive modalità di funzionamento della democrazia. In uno dei luoghi più antifascisti d’Italia, la “nazione” faceva una davvero brutta figura rispetto alla città di Torino e alla sua università (che non era dimentica di quel manipolo di professori i quali, avendo rifiutato di giurare obbedienza al Duce, persero consapevolmente il posto), a valori e comportamenti civili.
Che avendo i sabaudi “fatta l’Italia”, bisognasse, nella famosa frase attribuita (ma, certamente, ne condensava il pensiero politico di fondo) al torinese Massimo D’Azeglio, “fare gli italiani” era un dato di fatto, una constatazione sostanzialmente indisputabile, non messa in questione. Peraltro, quello che era un imperativo, politico e morale, non serviva certamente a suscitare sentimenti nazionalisti. Prima di diventare orgogliosi dell’Italia, era indispensabile che gli italiani acquisissero molte qualità che, forse, potremmo sintetizzare non tanto nell’amor di Patria, ma nel senso civico, nella disponibilità mazziniana all’adempimento dei doveri a cominciare da quelli scritti nella Costituzione repubblicana.
Anche se l’argomento del come fare gli italiani non fu mai preso di petto nei corsi che seguii, faceva capolino nelle lezioni di storia delle dottrine politiche di Luigi Firpo. Talvolta veniva evocato Giacomo Leopardi per la sua analisi spietata dei vizi degli italiani. Spesso veniva indirettamente criticato il nazionalismo fascista come cattivo maestro di malposta italianità. Insomma, nelle mie esperienze di studente non ebbi nessuno stimolo a definire la mia italianità né, meno che mai, ad essere particolarmente orgoglioso della mia appartenenza alla Nazione. Lo so, naturalmente, che, leggendo queste frasi, alcuni deprecheranno tanto l’internazionalismo della sinistra quanto, forse più, la versione piemontese, asciutta e severa, “moralistica” per i critici, intransigente, dell’Azionismo. Personalmente, non condivido in nulla queste critiche, nel frattempo divenute noiose e stantie, ma so che l’ambiente dei miei studi e le convinzioni dei miei docenti non lasciavano spazio a nessuna conquista o fierezza di italianità. Irrilevante. Per di più, nessuna versione di italianità intervenne nella costruzione della mia personale identità alla quale contribuirono letture come Cesare Pavese, Carlo Levi, Italo Calvino, Primo Levi e Beppe Fenoglio nei quali è impossibile ritrovare qualsiasi accentuazione di italianità, al tempo stesso che si esprimono valori civili di permanente rilevanza che stanno e vanno oltre qualsiasi considerazione “nazionale”.
Non una sola appartenenza
Da nessuna parte in Europa degli anni Sessanta del secolo scorso fecero la loro comparsa espressioni particolarmente significative di nazionalismo, neanche, semplicemente, nella versione di orgoglio nazionale. Per quel che mi riguarda, invece, tre episodi molto diversi, ma concatenati, mi esposero in maniera inaspettata al tema dell’appartenenza nazionale. Nel 1965 fui ammesso al Bologna Center della Johns Hopkins per un Master in Relazioni Internazionali, 160 studenti, metà statunitensi metà europei dei quali sei italiani. I primi ostentatamente fieri, persino troppo, della loro cittadinanza (credevano ancora al cosiddetto “eccezionalismo” americano appena incrinato dall’assassinio del Presidente Kennedy e c’era anche uno studente che veniva proprio da Dallas), gli europei di rimbalzo consci delle differenze culturali intercorrenti e delle loro specificità, disposti a vantarle. Noi italiani, di provenienze regionali diverse, certo collocati dalla parte degli europei, non eravamo comunque interessati a nessun vanto, ma coglievamo le diversità. Lo dirò così: “sì, c’è qualcosa di specificamente italiano, persino, positivamente tale” (un pensiero che non avevo mai avuto in precedenza) che attribuivo davvero alla cultura e, allora, persino, all’istruzione che si poteva ottenere nei licei un po’ dappertutto in Italia.
Vinta la borsa di studio per proseguire il secondo anno alla School of Advanced International Studies di Washington D.C., mi venne anche offerta la possibilità di acclimatarmi alla vita in USA, dove non ero mai stato in precedenza, grazie ad un programma che prevedeva quattro settimane ospite di una famiglia americana. Mi accolse una famiglia di Montclair, ricco sobborgo del New Jersey, repubblicana, molto benestante, con quattro figli, il più grande intorno ai vent’anni, il padre operatore economico di alto livello a Wall Street che faceva giornalmente il commuter. Quando chiesi come ero finito lì, se erano stati loro a sceglier/mi, la signora, donna squisita dell’alta borghesia di Philadelphia, mi rispose candidamente che l’alternativa era un africano del Ghana, peraltro un Ashanti, gruppo etnico molto importante e potente, e che avevano preferito l’italiano. Capii, allora, che la nazionalità era un fattore di qualche importanza (…).
Il terzo episodio è il più importante. Studiando Scienza politica alla School of Advanced International Studies mi imbattei (è il verbo giusto poiché il testo di cui parlerò non faceva parte delle letture assegnate) nella ricerca comparata di Gabriel Almond e Sidney Verba, The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton University Press 1963), uno dei libri di scienza politica più giustamente citati e influenti del secolo scorso. Per rendere breve, come dicono gli inglesi, una storia molto lunga, il dato che mi colpì maggiormente è che per gli Americani, gli inglesi e i messicani l’elemento di cui erano più fieri era chiaramente politico, rispettivamente: la Costituzione, il modello di governo, noto come Westminster, la rivoluzione, mentre per i tedeschi, i quali ad appena vent’anni dalla sconfitta del regime nazional-socialista (non necessariamente delle idee naziste) preferivano tenersi lontani dalla politica, era l’economia sociale di mercato. Per gli italiani la dispersione delle risposte premiava il Bel Paese, cioè la bellezza del territorio e delle città, e i grandi poeti e artisti del passato (Leonardo, Michelangelo, Dante) relegando la politica in un secondo piano molto lontano. Più che sorprendermi, questi dati mi incuriosirono assai. Di tanto in tanto continuo a chiedermi non soltanto quale risposta avrei dato allora e darei oggi, ma anche quali dovrebbero essere gli elementi da porre a fondamento della mia identità, della mia, più o meno pallida, italianità.
Negli anni Novanta che la politica (italiana) c’entrasse con l’italianità me lo fecero sentire i colleghi studiosi di politica che incontravo ai convegni accademici in vari paesi europei, negli USA e in diversi stati latino-americani. Ricordo la perplessità, la cautela, la sensazione di un “tenere le distanze”, l’imbarazzo iniziale di molti di coloro che mi incontravano per la prima volta negli anni del berlusconismo. Avevano a che fare con un italiano sostenitore di Berlusconi? Potevano criticare liberamente il fondatore e leader di Forza Italia, il fenomeno inusitato di un magnate delle televisioni private, del più ricco uomo italiano diventato capo del governo senza nessuna precedente esperienza in clamoroso conflitto di interessi? Da che parte stavo e, dunque, che “italiano” ero? Mi resi conto che, agli occhi di molti stranieri, certo, per lo più, ma non solo, accademici: politologi, sociologi, storici, la mia identità di italiano era concepita in termini politici, con riferimento alle mie eventuali preferenze politiche che, però, per non pochi di loro riflettevano pregiudizi su un popolo che, più o meno pittorescamente, non rispetta le regole.
Da un lato, ho regolarmente tentato di offrire una sobria analisi delle condizioni e delle modalità dell’avvento di Berlusconi, considerandolo ampiamente rappresentativo di una parte nient’affatto marginale dell’elettorato italiano. Dall’altro, non ho mai rinunciato alla critica della politica e dei politici dei paesi di provenienza dei miei interlocutori. Grande, enorme è dal 2016 il mio compiacimento nel dire alto e forte che, in quanto a cultura politica e pericolosità per le istituzioni e per il mondo, il Presidente Donald Trump è incomparabilmente peggiore di Berlusconi, e, insomma, il Primo ministro Boris Johnson non è sicuramente il modello di leader anglosassone al quale intendiamo guardare e aspirare. A proposito di Berlusconi, ho pensato, scritto e variamente argomentato che la sua comparsa e vittoria costituiscono una parte, non trascurabile della autobiografia della nazione in molti dei tratti che ritengo deprecabili. Li sintetizzo con le parole di Paolo Bagnoli: “L’Italia è un Paese che, per indole, non ama la sobrietà, la compostezza, la misura” (I ‘capiscioni’ smemorati, in “NON MOLLARE” (quindicinale online), n. 60, 16 marzo 2020). Chiudo su questo punto segnalando che mai, nel corso del berlusconismo, ho detto che mi vergognavo di essere italiano e mai ho annunciato che andavo in esilio. Anzi, ho trovato sgradevoli e politicamente inutili, se non addirittura controproducenti, entrambe le affermazioni.
Dell’italianità in politica
Rimanendo nella italianità riferita alla sfera politica, personalmente, senza in nessun modo lodare le mie preferenze politiche, solide e durature, mai intrecciate con un partito, ma collegate piuttosto ad una visione di società, ho preso ad interrogarmi su quel che rimprovero agli italiani. Mi è parso più utile anche per capire che cosa potrebbe essere l’italianità con la quale riuscirei ad identificarmi (ovvero, a sentirmi meno lontano).
Naturalmente, non propongo affatto un’analisi definitiva dei complessi rapporti degli italiani con la politica (per chi volesse saperne di più rimando ai libri del grande antropologo Carlo Tullio-Altan: Populismo e trasformismo. Saggio sulle ideologie politiche italiane, Milano, Feltrinelli, 1989 e La coscienza civile degli italiani. Valori e disvalori nella storia nazionale, Udine, Gaspari, 1995). Non seguirò la storia molto italiana dell’antipolitica e dell’antiparlamentarismo che ha spesso condotto alla critica della democrazia e al suo indebolimento. Non discuterò né di coloro che continuano a fare elogi eccessivi e senza fondamento degli italiani (la società “civile” nella sua interezza) né di coloro che mantengono la loro purezza “non prendendo neppure un caffè con i politici” [per chi non lo ricordasse fu questo, mai criticato dai suoi colleghi, uno dei grandi vanti di Indro Montanelli che addirittura contribuì alla sua fama]. Non voglio rinunciare a due citazioni che riflettono sulla drammatica epopea del coronavirus, da destra, Danilo Breschi: “ e l’italiano potrebbe persino mostrarsi il più accorto, il più amante della libera democrazia”, in Emergenza: maneggiare con cura, 19 marzo 2020; da sinistra, il Ministro Roberto Gualtieri. Lodata la grande dimostrazione di senso di appartenenza nazionale, il Ministro afferma, alquanto prematuramente che: “siamo diventati un modello sia nella gestione dell’emergenza sanitaria sia nella gestione delle sue conseguenze economiche”. Ne conclude che “credo che potremmo diventare un modello anche sul piano dei comportamenti e dell’etica pubblica” (L’intervista in “Corriere della Sera”, 20 marzo 2020, p. 11).
In senso lato, possiamo ritenere e sostenere che tanto l’orgogliosa separatezza rivendicata da numerosi esponenti della società civile quanto le affermazioni di superiorità di chi “non fa politica” siano elementi costitutivi dell’identità italiana. Da tempo l’Uomo Qualunque, nato in Italia, continua ad aggirarsi fra noi e ha dimostrato straordinarie capacità di trasformazione (di trasformismo) arrivando fino ad oggi, premiato nelle elezioni del 2013 e del 2018 da milioni di elettori/elettrici. Può persino contare su volonterosi megafoni, non solo nelle numerose rubriche delle lettere dei lettori al Direttore (una ricerca, che non consiglio a nessuno, su quelle lettere e sulle risposte di chi tiene la rubrica, fornirebbe uno straordinario spaccato dell’Italia reale e delle componenti dell’italianità). Ancora adesso l’interconnessione “società/politica” deve essere ribadita, come fa Ernesto Galli della Loggia, Il passato ci frena ancora. Scelte guidate dal consenso, Corriere della Sera, 11 marzo, p. 32: “Agli italiani più che la possibilità di contare su reti di servizi efficienti, su prestazioni dagli standard adeguati, in tempi rapidi e in sedi attrezzate, più di questo è sempre importato avere dallo Stato un’altra cosa: soldi. Soldi direttamente dalle casse pubbliche alle proprie tasche”. Non propriamente un “compromesso socialdemocratico”. Lo chiamerò compromesso clientelare. Però, il frenatore del titolo dell’articolo di Galli della Loggia non è il passato. Il frenatore, nell’accezione datagli dall’editorialista, fa parte costitutiva, integrale dell’italianità.
Al proposito, chiunque volesse stilare un elenco delle componenti dell’italianità finirebbe inevitabilmente per farlo, da un lato, in maniera selettiva e, forse, perentoria, dall’altro, individuando in particolare le caratteristiche degli italiani che non condivide, che lo irritano, che ritiene sostanzialmente deleterie e intollerabili. Non sono in grado di sfuggire a questi esiti e, a ragion veduta, rinuncio. Tuttavia, devo in qualche modo concludere la riflessione condotta fin qui. Lo farò con due osservazioni a ampio raggio.
Italianità e emergenza
Di recente in diverse conferenze in contesti diversi, specialmente all’estero, mi sono trovato a citare con approvazione la risposta data da uno studente alla richiesta, abituale nei dibattiti internazionali, di identificarsi. Lo studente in questione rispose con nome e cognome aggiungendo “sono un europeo nato a Torino”. Interpreto “europeo” come un’affermazione di identità e di identificazione con il progetto federalista di un’Europa politicamente unificata, ma anche come adesione ai valori democratici sui quali si fonda e si costruisce quel progetto. E interpreto il riferimento a Torino come il richiamo ad un humus, a radici culturali, a un’esperienza di vita e costumi considerata importante per la costruzione della personalità. Qualcuno potrebbe aggiungere che in quella frase non si trova nulla che richiami l’italianità. Pour cause, poiché lo studente (e ancora una volta concordo) voleva esplicitamente dare una spinta al superamento delle identità nazionali, intese come ostacolo alla costruzione di una identità europea. Sento subito montare il dissenso a questa affermazione, dissenso di frasi fatte tipo “solo forti identità nazionali daranno vita a una forte identità europea”. Finora non ho visto tentativi di sostanziare in maniera non retorica questa affermazione. Quindi, non ho modo di poterla (e neppure l’obbligo di doverla) discutere.
La seconda osservazione riguarda la ricomparsa in occasione dell’emergenza causata dal coronavirus di una frase altrettanto fatta (già spesso periodicamente utilizzata) il cui controllo empirico, fattuale è assolutamente inesistente. La frase, che è stata sulla bocca di quasi tutti gli editorialisti e gli opinionisti, non solo della domenica, nei talk show, è: “nell’emergenza gli italiani danno il meglio di sé”. Questa convinzione, meglio credenza, è talmente diffusa che è stata espressa anche nelle parole, in parte guidate dall’intervistatore, di un famoso calciatore poi allenatore Cesare Prandelli:
D. “Gli italiani nelle difficoltà riescono a fare squadra”.
R. “Fatichiamo ad accettare le regole, ma quando siamo responsabilizzati diamo il meglio, andando oltre le solite liti politiche. Spero che possiamo essere un esempio per gli altri Paesi della Comunità europea”. (Corriere della Sera, 16 marzo 2020, p. 11).
Più sfumato il sondaggista Nando Pagnoncelli: “nelle situazioni difficili il Paese dà il meglio di sé, basti pensare all’abnegazione dei medici e degli operatori sociosanitari e ai piccoli e grandi gesti di altruismo e generosità … relegando in secondo piano alcuni disdicevoli episodi che non ci siamo fatti mancare” (Le strategie decise dal governo promosse dal 62% degli italiani , in “Corriere della Sera” 14 marzo p. 12)
Sarebbe utile verificare quanto e come in occasioni di grandi emergenze, terremoti e inondazioni, non oso menzionare né la mafia né i terrorismi (al plurale), gli italiani abbiano dato il meglio di sé. Immagino che questo “meglio” si configuri come impegno personale (e collettivo) di energie e di tempo, forse anche di denaro, in attività altruistiche e collettive per risolvere e porre fine a quella specifica emergenza. La ricostruzione post-bellica, evento eccezionale, ma assolutamente non frutto di una emergenza, non mi pare un esempio appropriato Per carità di patria, non mi soffermerò sugli scandali, sugli sciacalli, sui profittatori sempre presenti, con pochissime eccezioni, una delle quali sembra essere la ricostruzione post-terremoto in Friuli nel 1976. Vero, parzialmente vero, non-vero che gli italiani sono donne e uomini (più) adatti alle emergenze’? Qui mi limiterò a dire che nell’emergenza del coronavirus a dare il meglio di sé sono stati i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario. Degli altri, di quelle decine di migliaia di persone che hanno violato l’indicazione di restare a casa, discuteremo un’altra volta. Nel frattempo, mi sento di affermare che il buon cittadino è colui che dà sempre il meglio di sé.
Per andare oltre
Naturalmente, mi sono più volte chiesto a che cosa serve/a l’italianità. Cercarla in quello che hanno scritto alcuni italiani da Leopardi a Gioberti da Manzoni fino a De Sanctis può essere un esercizio letterario di grande interesse (come quello offerto da Giulio Bollati, Il carattere nazionale come storia e come invenzione, Einaudi 2011, spec. pp. 35-127), ma mi sembra che, tutto sommato, rimanga senza rilevanza per la vita degli italiani e per la qualità del sistema politico e della democrazia. Che cosa conta fregiarsi del bollino “alta Italianità”? Che messaggio manda agli altri italiani e agli stranieri? Affidabilità o no? I frequenti richiami al Risorgimento, all’unità della patria, alla appartenenza nazionale sono concepibili, anche se non sempre accettabili, come una modalità da utilizzare per costruire e preservare la coesione sociale. Un sistema politico, una comunità nazionale, un regime democratico funzionano meglio, acquisiscono un’alta qualità, producono beni collettivi più abbondanti e, persino, li redistribuiscono in maniera più equa e più soddisfacente laddove la appartenenza nazionale, in questo caso, l’italianità, ha cementato una solida consapevole coesione sociale tramandata fra le generazioni. Capisco, ma non sono del tutto convinto che la coesione sociale derivi per una (in)certa parte dalla diffusione dell’italianità. Credo, ma lo pongo in maniera problematica, che la coesione sociale sia e debba essere il prodotto e la conseguenza del riconoscimento che esiste un patto fra persone, fra cittadini. Si chiama Costituzione ed è intessuto di leggi che regolano i rapporti fra i cittadini e fra i cittadini, i rappresentanti e governanti. Allora, sì, sono italiano perché riconosco nella Costituzione repubblicana del 1948 un patto degno di essere rispettato e attuato. Riconosco anche che quella Costituzione e il patto in essa contenuto e sancito mi offrono la opportunità di sentirmi e essere europeo. Se questo è “patriottismo costituzionale”, allora sono anche quel tipo di patriota. L’italianità sta nella Costituzione, si esprime attraverso la Costituzione, costruisce una comunità in grado di scegliere e decidere, cambiare e perseguire le sue preferenze. Capovolgendo Cicerone: ubi libertas ibi patria.
Pubblicato in Essere (o non essere) italiani, a cura di Gianfranco Pasquino, Paradoxa, Anno XIV – Numero 2 – Aprile/Giugno 2020
VIDEO “La democrazia come ideale e come fatto”
Riprese audio e video a cura di Radio Radicale Roma, 8 gennaio 2020 Sala Conferenze del Partito Democratico
Sono intervenuti nell’ordine:
Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all’Università degli Studi di Bologna, Accademia dei Lincei
Gianni Cuperlo, membro della Direzione Nazionale, Partito Democratico
Claudia Mancina, professoressa associata di Etica alla Sapienza Università di Roma
Giacomo Marramao, professore emerito di Filosofia politica e Filosofia teoretica dell’Università degli Studi Roma Tre
Dario Franceschini, ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, Partito Democratico
Tra gli argomenti discussi: Crisi, Democrazia, Economia, Globalizzazione, Liberalismo, Mercato, Politica, Società.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 32 minuti.
Tavola rotonda a partire da ParadoXa 3-2019
Democrazie Fake
a cura di Gianfranco PasquinoLa democrazia come ideale e come fatto
La democrazia come ideale e come fatto #TavolaRotonda #Roma #8gennaio
8 gennaio 2020, ore 17 Sala del Nazareno via Sant'Andrea delle Fratte 16 Roma
a partire da ParadoXa 3-2019
Democrazie Fake
a cura di Gianfranco PasquinoTavola rotonda
La democrazia come ideale e come fatto
Gianni Cuperlo
Dario Franceschini
Claudia Mancina
Giacomo Marramao
Gianfranco Pasquino
Coerenza, vo cercando ch’è sì cara…
Dove sta la linea divisoria fra coerenza e opportunismo? Ho sempre pensato che i due grandi paesi anglosassoni, capostipiti, rispettivamente delle Repubbliche presidenziali e delle democrazie parlamentari, offrissero gli esempi migliori della coerenza in politica, di politici coerenti che maturano una posizione, la mantengono nelle avversità, ne accettano la totale responsabilità. Di recente, ho visto queste qualità in Robert Kennedy e in John McCain, ma anche, pur ritenendo le sue politiche sbagliate, in Margaret Thatcher (troppo facile citare Winston Churchill). Poi, brutto segno dei tempi, sulla scena politica USA ha fatto irruzione Donald Trump e, più di recente, sulla scena londinese si è affermato Boris Johnson. Entrambi esemplari di opportunismo, che non definirò mai “puro”, per i quali l’unica coerenza è la ricerca del potere, la soddisfazione del narcisismo, lo sberleffo.
La politica, l’ho imparato da tempo, è l’arte di costruire le condizioni del possibile, pongo l’enfasi sul verbo costruire, quindi di afferrare le opportunità, di utilizzarle, piegarle, indirizzarle. Chi si chiama fuori è perduto. Chi è senza una bussola di valori ondeggia, oscilla, diventa preda di altri. C’è un solo modo, weberiano, di chiamarsi fuori rimanendo coerenti: accettare la sconfitta e ricominciare da capo. Senza sostenere di avere comunque avuto ragione e che i tempi non erano maturi. Sono sempre stato in disaccordo con l’affermazione che si meritano la sconfitta coloro che hanno ragione in anticipo sui tempi, troppo presto sostengono gli opportunisti. Non ritengo affatto geniali i comportamenti di coloro che contraddicono platealmente quanto hanno affermato poco tempo prima senza neppure curarsi di offrire una spiegazione. Neppure l’affermazione che solo le persone stupide non adattano i loro comportamenti alle mutate situazioni mi ha mai convinto pienamente. Certo, cambiare i comportamenti è possibile e spesso auspicabile, ma lo si deve fare riconoscendo gli errori insiti nei comportamenti precedenti, magari chiarendo le motivazioni dei comportamenti sbagliati e quelle dei nuovi comportamenti.
Non sono in grado di valutare le ragioni (non può essere quella da lui addotta “sterilizzare l’aumento dell’IVA”, sarebbe banale e preoccupante per povertà di visione) che hanno spinto Matteo Renzi a chiedere quel governo con le Cinque Stelle che lui aveva fermamente rigettato dopo la sua pesante sconfitta elettorale del marzo 2018. Qui, non scenderò in nessun particolare poiché in quanto a coerenza anche il gruppo dirigente delle Cinque Stelle ha molto su cui riflettere. Invece, il Presidente del Consiglio Conte, attraverso errori e ripensamenti e soprattutto apprendimenti accelerati, sembra essere riuscito a capire e a fare capire come sono maturate le sue posizioni che ne giustificano la permanenza a Palazzo Chigi seppure con una compagine governativa molto diversa, oppure proprio per questo.
Adesso, il discorso sulla coerenza si sposta sulle politiche del governo e soprattutto sui rapporti con l’Unione Europea. Coerenza è mantenere gli impegni presi dall’Italia, molti dei quali si trovano nei Trattati, in particolare in quello di Lisbona. Coerenza è credibilità delle posizioni che i Ministri italiani prenderanno e delle responsabilità che si assumeranno. Coerenza, infine, è spiegare agli italiani che il problema non è riacquisire quella sovranità che condividiamo con gli altri stati-membri dell’Unione, ma procedere e approfondire affinché diventi presto possibile sentirsi e essere al tempo stesso concretamente italiani e europei-europei perché italiani. Allora coerenza è insegnare l’educazione civica in chiave di patriottismo europeo e praticarla nella speranza che gli operatori dei massa media sappiano (e vogliano) “narrarla” senza stravolgimenti. Amen.
Pubblicato il su paradoxaforum.com
La egemonia della Destra
La Destra, in particolare nella versione che ne offre costantemente Matteo Salvini, ha acquisito una egemonia anche, forse, soprattutto culturale nell’Italia contemporanea? Lasciando, per una volta, da parte le responsabilità, che pure ci sono e grandi, del Partito Democratico, politiche e culturali, di persone e di proposte, a quali fenomeni/fattori bisogna guardare? La nuova Lega e il suo Capitano hanno soltanto saputo sfruttare una onda alta di insoddisfazione (peraltro, in competizione con le Cinque Stelle) e stanno facendo operazioni da abili surfisti oppure c’è qualcosa di più profondo nella cultura e nella politica in particolare italiana che la Lega interpreta meglio di chiunque altro?
Davvero si tratterebbe di una nuova manifestazione del fascismo? Perché, a mio modo di vedere di un “ritorno”, non potremmo assolutamente parlare, dal momento che il fascismo, notoriamente, in Italia non è mai andato via perché mai gli italiani hanno voluto fare i conti con se stessi e sempre hanno cercato di fare dimenticare le loro colpe spingendo sotto il tappeto quelli che Renzo De Felice chiamò Gli anni del consenso (1929-1936)? La mia risposta è negativa, discutibile, ma solo da chi conosce non solo il fascismo italiano, ma anche come giunsero al potere i movimenti autoritari in Europa e America latina.
Due tematiche hanno finora fatto la fortuna politica di Salvini: l’immigrazione e la sicurezza. Sono anche legate fra di loro, ma non così strettamente come Salvini e diverse frange della sua Lega vorrebbero fare credere. In termini tecnici: agenda setting e issue ownership, da un lato, Salvini ha dettato l’agenda, dall’altro, si è impadronito saldamente di entrambe le tematiche. È presumibile che le due tematiche durino nel tempo, ma da sole certamente non garantiscono una egemonia culturale, anche se scomparse, snervate e sfibrate, le culture politiche del XX secolo (Paradoxa, La scomparsa delle culture politiche in Italia, Ottobre/Dicembre 2015 documenta il possibile), non esiste nessun argine.
Sull’onda del trumpismo, Salvini continua a dire “prima gli italiani” e questa sì è una tematica che ha radici profonde e durature. Fare leva sull’identità in una fase in cui pare sfidata sia dagli immigranti che da coloro che predicano accoglienza e solidarietà dalle loro comode abitazioni cittadine nelle zone a traffico limitato lasciando che quell’accoglienza e quella solidarietà la forniscano gratis et amore dei gli abitanti delle periferie è un’operazione che fa acquisire molti consensi. Può anche essere sfruttata come sfida all’Unione Europea le cui politiche sui migranti non sono state coronate da successi spettacolari. L’identità nazionale può essere utilizzata contro le sinistre da sempre e, almeno in parte correttamente, accusate di debole identità nazionale e di esagerato europeismo “mentale”, non politicamente argomentate. Che, poi, nella sinistra facciano outing anche i non pochi sovranisti è una scoperta soltanto per coloro che la sinistra la frequentano poco e la idealizzano molto. Non è qui che si troveranno gli anticorpi al “corpo” del leader Salvini.
Da ultimo, sta in Salvini e nel suo ampio seguito leghista la mentalità, che non vorrei mai chiamare “cultura”, del cittadino libero e produttivo contro lo Stato impiccione e sprecone. Dovremmo ricordare che è questa mentalità che si è ritrovata d’un sol colpo unita dentro la Forza Italia delle origini, che è stata blandita e remunerata dai governi di Berlusconi, che ha sempre dimostrato di essere molto diffusa, quasi fosse la mentalità italiana, degli italiani. Ed è questa mentalità con le sue radici profonde che può effettivamente costituire il sostrato di lungo periodo dell’egemonia di Salvini della destra. Voi chiamatela se volete “populistica” poiché implica la delega piena al Capitano, cioè al leader. Aggiungete il sovranismo e la miscela è quasi completa. Comunque, funziona e soprattutto rappresenta una parte cospicua degli italiani. Parte di questa miscela circola anche dentro il Movimento Cinque Stelle con una spruzzatina di democrazia diretta che, in verità, è una forma di delega mascherata. Parte, infine, ma in dosi molto minori si trova in quasi tutti gli Stati-membri dell’Unione Europea, ma molti di loro non hanno alle spalle un’esperienza fascista di impronta duratura.
Per concludere, non piangerò neppure una lacrima furtiva sul paese che ha dato i natali a Dante e Leonardo, a Cavour e a Garibaldi, a Spinelli e a De Gasperi. Nelle mentalità della Destra e dei suoi elettori sono quasi tutti dei Carneadi anche se qualcuno fra loro i voti li aveva, eccome. I successori non ne hanno fatto buon uso. Recuperarli richiede, cominciando subito, almeno una generazione (anche su questo “Paradoxa”, Giovani e futuro della politica. Oltre il disincanto, Ottobre/Dicembre 2018).
Pubblicato il 24 giugno 2019 su PARADOXAforum