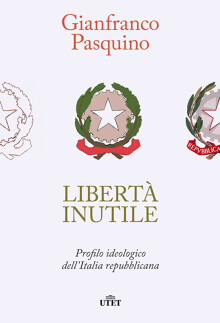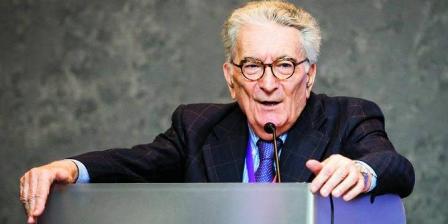Home » Posts tagged 'populismo'
Tag Archives: populismo
La democrazia al tempo di X, fra polarizzazione, intelligenze artificiali e fake news #ParliamoneOra #5aprile #Bologna


Nell’ambito delle iniziative congiunte di ParliamoneOra e dell’Università di Bologna su temi della contemporaneità, venerdì 5 aprile dalle 17 alle 19:30 presso l’aula Prodi complesso di San Giovanni in Monte.
Nel 2024 andranno al voto 4 miliardi di persone. Andranno al voto alcuni dei paesi più popolosi al mondo e alcune delle democrazie storicamente più robuste.
Il sistema di rappresentanza attraverso i partiti politici è ancora un modello valido per organizzare il consenso rispetto alle “bolle” di mono-pensiero dei “social”? L’elezione diretta dei capi di governo garantisce l’espressione della volontà popolare? Fino a che punto gli strumenti di comunicazione di massa, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, l’uso sistematico della disinformazione, possono influenzare se non determinare gli esisti elettorali?
Ne discutiamo con
Fulvio Cammarano (Storia Contemporanea)
Donatella Campus (Scienza Politica, Università di Bergamo),
Giovanna Cosenza (Filosofia e Teoria dei Linguaggi),
Andrea Morrone (Diritto Costituzionale),
Gianfranco Pasquino (Professore emerito di Scienza Politica),
coordina Dario Braga (presidente onorario di ParliamoneOra)
E’ possibile anche seguire in collegamento da remoto collegadosi a
ID riunione: 363 457 587 166
Passcode: a3aXYm
Ma quali due mandati. Pasquino sulla proposta dei 5 Stelle @formichenews

Secondo il professore emerito di Scienza Politica e accademico dei Lincei, il limite di due mandati elettivi per i parlamentari non è solo populista, ma anche illiberale e antidemocratico. Aprire su questo un serio dibattito all’interno del Movimento sarebbe una buona notizia
Il limite a due mandati elettivi per i rappresentanti del “popolo” in Parlamento e altrove non è soltanto una misura populista. È una misura sbagliata, illiberale (contro la libertà) e sostanzialmente anti-democratica. No, non esagero e, prima che mi si opponga, che esiste in altri contesti, ad esempio, in America latina, dalla Costa Rica al Messico, presento per esteso la mia argomentazione. Premessa: imporre un limite ai mandati dei capi degli esecutivi eletti direttamente dal “popolo” ha un senso molto diverso. Significa, se non impedire, quantomeno rendere molto difficili la costruzione e la manutenzione di reti di potere ad opera del sindaco, del governatore, del Presidente. Nessun singolo parlamentare potrà mai essere assimilato al capo di un esecutivo né potrai ma accumulare tanto potere e esercitarlo direttamente.
Primo, il limite del doppio mandato è populista perché soddisfa le esigenze di una parte, difficile dire quanto grande, di elettori che nutrono la convinzione che i rappresentanti si fanno gli affari loro e non si occupano dei problemi della gente. Quindi, bisogna impedire loro di continuare nell’andazzo, fare finire la pacchia. D’altronde, uno vale uno e chi seguirà non sarà peggiore, anzi, c’è il rischio che, occasionalmente, sia migliore. Tutti possono fare politica e poi come valutare le competenze e gli apprendimenti? Qui sta, naturalmente, una batteria di errori. Il parlamentare deve avere un tot di conoscenze iniziali, superiori a quelle di un artigiano (il famoso/igerato idraulico), e se frequenta il Parlamento, le commissioni, l’aula, può imparare molto riguardo la lettura e la valutazione dei testi di legge, la stesura di emendamenti, la comunicazione politica a cominciare da quella con i suoi elettori (peraltro, operazione non facile con le recenti leggi elettorali italiane).
Secondo, il limite ai mandati è illiberale. Infatti, limita la libertà dei parlamentari di ripresentarsi a loro piacimento. Dunque, se imposto, violerebbe un loro diritto politico fondamentale che sta all’inizio della storia delle democrazie liberali e vi si accompagna quasi dappertutto.
Infine, il limite ai mandati è antidemocratico ovvero incide negativamente sul potere del popolo sovrano, quel potere che consente ai cittadini non soltanto di scegliere (eleggere) senza previe discriminazioni attraverso una impersonale mannaia burocratica, ma anche di giungere attraverso una valutazione politica di quello che il parlamentare ricandidato/si ha fatto, non ha fatto, ha fatto male, ad una sua bocciatura.
Vadano le Cinque Stelle al rispetto di una loro regola tanto fondamentale quanto sbagliata e produttiva di conseguenze pessime, come sembra adombrare la più recente dichiarazione del Ministro Di Maio, uno dei più autorevoli decapitabili, oppure no, renderebbero comunque un significativo servizio alla democrazia parlamentare, alla sua funzionalità, alla sua rigenerazione, se aprissero un trasparente dibattito pubblico sul pro e sul contro al limite di due mandati.
Pubblicato il 18 giugno 2022 su Formiche.net
INVITO “Europeismo che c’è e che verrà” #Pesaro #14maggio @ApritiPesaro @UtetLibri
Sabato 14 maggio ore 16.30
Galleria degli specchi Hotel Alexander
Viale Trieste 20 – Pesaro
Apriti Pesaro
Futuro con vista
Europeismo che c’è e che verrà
In occasione dell’uscita dei suoi più recenti lavori
Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana, (UTET 2021)
Tra scienza e politica. Una autobiografia, (UTET 2022)
Apriti Pesaro incontra di nuovo il professor Gianfranco Pasquino per dar seguito al lavoro già svolto su “Populismi e sovranismi”

I populisti si riconoscono ma fanno fatica a unire le forze @DomaniGiornale


Non serve a nulla, ed è sbagliato, criticare alcuni politici, italiani e francesi (mi limito a questi due contesti) perché usano toni e argomenti populisti, al tempo stesso rimproverando partiti (il Partito Democratico, ad esempio) e leader (il Presidente Macron, altro esempio) per avere, più o meno deliberatamente o per incapacità, abbandonato il popolo. Quasi esistesse una contrapposizione netta fra chi va, populisticamente, verso il popolo (i narodniki nostri contemporanei) e chi si muove nelle Zone a Traffico Limitato. Maggiore sofisticatezza analitica offrirebbe un quadro più composito e realistico degli elettorati nei sistemi politici democratici e riuscirebbe a rendere conto di situazioni in cambiamento segnate oggi più di ieri, anche a causa di grandi migrazioni, da fattori culturali.
Prendo le mosse da una considerazione che ritengo imprescindibile. In tutti i regimi democratici esiste sempre una striscia, più o meno grande e visibile, di populismo. D’altronde, senza popolo non è possibile parlare di democrazia. Poi, sicuramente, quello che fa la differenza sono le modalità con le quali gli uomini e le donne in politica fanno appello al popolo, affermano di interpretarlo (“la gente non ci capirebbe”) cercano di mobilitarlo, in special modo, contro i “nemici del popolo”. Al popolo, però, fanno riferimento anche i nazionalisti che vogliono guidarlo, utilizzarlo e contrapporlo ad altri popoli, spesso considerati inferiori, addirittura non-popoli. Quando questo nazionalismo appare frusto e oramai privo di slancio, gli subentra, in particolare nell’ambito del processo di unificazione politica federale dell’Unione Europea, il richiamo allarmato al pericolo della perdita di identità e di sovranità. Con qualche sorpresa dei dirigenti populisti, non sembra vero che tout se tient. Di qui alcune battute d’arresto, alcuni ri-orientamenti, alcuni riposizionamenti in Italia e in Francia accompagnati da alcune regressioni elettorali.
I populisti di tutto il mondo spesso si riconoscono, ma altrettanto spesso fanno fatica a unire le loro forze. Proprio non possono dare vita a una ininterrotta rivoluzione identitaria e ripiegano nel “sovranismo in un solo paese” (il loro). Anzi, almeno i più accorti fra loro evitano di impegnarsi, se non a parole e a distanza, in troppi entusiastici riconoscimenti e approvazioni. Per alcuni populisti il richiamo al popolo viene subordinato, magari anche solo di poco, all’idea di nazione che mi pare il caso di Marine Le Pen. Altri hanno di recente provato ad accentuare il sovranismo subito “puniti” dalla necessità in caso di pandemia di cooperare per soluzioni che non si riescono a trovare negli asfittici confini nazionali. Quale nazione da sola si sentirebbe al sicuro dalle mire espansionistiche di un paese, per esempio, come la Russia?
Sapendolo leggere, il voto di milioni di cittadini “democratici” rivela qualcosa che non può mai essere spiegato da un unico fattore e per ciascuno degli elettori possono esserci differenti scale di priorità. Tanto nel voto per Jan-Luc Mélenchon quanto nel voto per Marine Le Pen esistono motivazioni populistiche, “noi, popolo dimenticato dalle élite”, ma ne segue una divaricazione immediata. L’ex-socialista Mélenchon si preoccupa, politicamente e elettoralmente, della crescita delle diseguaglianze, certamente, non al primo posto nell’agenda neo-centrista del Presidente in carica. La candidata del Rassemblement National vuole più potere per il popolo dei francesi autoctoni. Forse, populismi entrambi; certamente non coalizzabili.
Pubblicato il 13 aprile 2022 su Domani
Democrazie nella pandemia: nonostante populismo, negazionismo e antiscientismo nessuna democrazia ha ceduto
State ancora piangendo sulla morte delle democrazie annunciata alcuni anni fa con grande fanfara? Sursum corda. Tutte colpite dalla pandemia, nessuna democrazia è crollata. Ci sono state normali elezioni competitive. Il populista negazionista quasi golpista Trump ha perso. La democrazia USA ha reagito ed è in via di miglioramento qualitativo. Le democrazie apprendono; avranno sempre qualche inconveniente e problema, ma rimbalzano. Yes, they can.
Perché Giorgia Meloni piace tanto e non solo a destra @DomaniGiornale
Cedo subito alla tentazione di un paragone significativo. Mentre noi italiani guardiamo con interesse e maggiore o minore preoccupazione all’ascesa di Giorgia Meloni, a fare notizia in Germania è la crescita di consensi per la verde Annalena Baerbock. Fratelli d’Italia, guidata da Meloni, si avvia al 18 per cento; i Verdi di Baerbock sono arrivati al 28 per cento e sembrano destinati ad essere il partito che deciderà il prossimo governo della Germania. Quel governo, sicuramente e fortemente europeista, non piacerà a Meloni che, tutte le volte che può, dichiara la sua preferenza per la variante ungherese rappresentata da Orbán. Saldamente insediata alla guida dei Conservatori e Riformisti Europei, in larga misura contrari all’Europa che c’è, ma anche sostanzialmente irrilevanti, Meloni afferma di essere “per un’Europa confederale, che decide le grandi cose, e sulle altre lascia libertà agli Stati”. Iniziata la Conferenza sul Futuro dell’Unione Europea, la leader di Fratelli d’Italia ha un’occasione propizia di fare valere le sue idee in maniera del tutto trasparente e di sottoporre a critica quanto quegli europei, che desiderano un’Unione ancora più stretta, sapranno proporre.
Ciò detto, il consenso italiano per Fratelli d’Italia dipende solo in piccola parte dalle posizioni anti-europee: l’elettorato non è tenuto a cogliere le sottili distinzioni fra l’UE com’è e l’Europa eventualmente confederale. L’ascesa di Giorgia Meloni è una storia tutta italiana. Nel degrado e nel declino complessivo dei partiti, Fratelli d’Italia ha comunque saputo mantenere un prezioso aggancio con quello che era stato un partito piccolo, ma con radicamento: il Movimento Sociale Italiano. Meloni lì nasce e lì cresce meritandosi i complimenti per avere conquistato spazio personale e agibilità politica in un organismo di uomini (tuttora) maschilisti. Il resto sembra in misura quasi eguale un misto fra doti di carattere e intelligente sfruttamento delle opportunità. Il carattere è quell’elemento, importante e nella politica italiana abbastanza poco frequente, che spiega la coerenza finora espressa da Meloni. Nessuna impennata nessuna giravolta nessun inseguimento di novità: Meloni è rimasta fedele alle sue idee, destra nazionale e, in fondo, tradizionale (che ha troppa contiguità con Casa Pound e Forza Nuova). Un po’ di sovranismo, che è il nazionalismo trasferito a Bruxelles, ma quasi niente populismo, consegnato largamente a Salvini (ma che, talvolta, fa capolino nei berluscones). In una certa misura, è lo stesso Salvini che, con il suo marcato opportunismo e esibizionismo, continua ad offrire opportunità di crescita a Giorgia Meloni. Le critiche salviniane al governo di cui fa parte sono tanto frequenti e tanto simili a quelle di Meloni che una parte dell’elettorato pensa che allora è meglio confluire su Fratelli d’Italia. Altri elettori in uscita dal Movimento 5 Stelle trovano nei Fratelli d’Italia l’organizzazione più credibile per esprimere sia l’insoddisfazione per la politica italiana sia il dissenso nei confronti del governo Draghi. Poiché, coerentemente, Giorgia Meloni non è entrata nella fin troppa ampia coalizione di governo, gode adesso di quella che chiamo “rendita d’opposizione”. Ė una rendita che si sta rivelando cospicua e che è destinata a durare. So che dovrei concludere mettendo in guardia dai rischi di un governo prossimo venturo guidato dalla non europeista Giorgia Meloni. Sarebbe inevitabilmente e preoccupantemente un governo di centro-destra i cui guai, a mio parere, verrebbero dalle ambiguità e dalle ambizioni di Salvini, anche e soprattutto se la competizione per la leadership fosse vinta, seppur risicatamente, proprio da chi guida Fratelli d’Italia.
Pubblicato il 12 maggio 2021 su Domani
Ma la realpolitik sarà sufficiente? #FormicheRivista n° 168 #Aprile2021 Elogio del Pragmatismo @formichenews
Aprile 2021 Elogio del pragmatismo
Ma la realpolitik sarà sufficiente?
L’insorgenza populista e sovranista sembra terminata. Un po’ dappertutto la pandemia sembra avere richiamato il popolo, pardon, i cittadini-elettori, e i dirigenti politici a atteggiamenti e comportamenti più sobri. Non sono in vista miracoli, ma riflessioni, in parte, purtroppo, in piccola parte, ispirate dalla consapevolezza che la scienza conta e che, dunque, bisogna contare anche sulla scienza. Qualcuno, forse, è andato audacemente e ardimentosamente oltre, vale a dire, pensa e sostiene che la politica possa e debba essere sostituita dalla scienza, persino, attribuendo capacità taumaturgiche agli economisti. Più fragorosamente che altrove, ma anche prima e più lungamente che altrove, è in Italia che la politica, intesa in senso molto lato, ha mostrato gravi inconvenienti. Tuttavia, non sarà affatto la tecnocrazia, neppure nella versione Draghi e i suoi boys, a risolvere le difficoltà di lungo corso dei partiti italiani e dei loro dirigenti. Ricorrerei ad una comparazione che fa leva sulla retorica. Per risolvere i problemi della democrazia ci vuole più democrazia proprio come per risolvere i problemi della politica ci vuole più politica. Sappiamo, è una certezza, che l’anti-politica in Italia è da sempre forte. Ė stata ingabbiata da partiti veri e seri per un periodo di cui è giusto essere fieri, dal 1945 a, scusatemi, ma non trovo una data convincente per segnalare la fine di quell’esperienza, forse al 1989. Poi l’antipolitica è tornata in forza sulle ali prima di un imprenditore, poi di un comico ed è rimasta alimentando copiosamente le Stelle.
Altrove, la situazione era diversa in partenza ed è rimasta diversa per tutto il tempo con la clamorosa eccezione degli USA e la Presidenza Trump (il Bolsonaro del Brasile è esperienza peculiare, con minor impatto internazionale). Mi viene regolarmente la tentazione di interrogarmi su che cosa rileverebbe Tocqueville come, al tempo stesso, una sorpresa e una correzione rispetto alle sue acutissime osservazioni dell’America degli anni trenta del XIX secolo. Poi, avendo letto le analisi di Robert Putnam sul capitale sociale, capisco che cosa è successo negli USA per aprire la strada a Trump (molto machismo, persistenza del razzismo, terribili semplificazioni che un elettorato con basso livello di istruzione ha dimostrato di sapere e volere apprezzare). Il trumpismo non è, naturalmente, finito, ma è improbabile che negli USA riconquisti i fasti del passato proprio come il populismo europeo non riuscirà ad ergersi come alternativa al ritorno di una politica non urlata, non stravolta. Dagli USA è venuta anche la lezione che le istituzioni e le regole della democrazia costituiscono un baluardo. Ricorderemo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 come il canto di un brutto cigno, ma anche come la sconfitta di quei “patrioti” bianchi insurrezionisti. Joe Biden è, in effetti, qualcosa di più dell’impossibile ritorno ad una normalità pre-2016. Il Presidente democratico è old, ma, consentitemi di aggiungere subito, giocando con le parole, ha dimostrato di essere bold, ovvero audace. Se Biden proseguirà tenacemente la strada del riformismo, economico e culturale, di ampliamento delle opportunità che è il meglio del “sogno americano”, l’impatto si avrà anche sui sistemi politici europei, sull’Unione Europea.
Oggi è impossibile dire se stiamo assistendo soltanto al ritorno del pragmatismo. Non sappiamo se il pragmatismo sarà sufficiente. Certamente, però, tenere conto dei fatti, delle prassi, costituisce la premessa indispensabile di qualsiasi costruzione di idee e di ideali. Temo che la pandemia offrirà ai politici, agli esperti, all’opinione pubblica nelle sue differenziate espressioni, ai cittadini ancora molto tempo per progettare. Ė un auspicio basato su segni ancora relativamente deboli che con l’impegno potranno rafforzarsi. Insomma, all’orizzonte si prospetta una nuova stagione nella quale politica e conoscenza, potere e sapere avranno modi di interagire liberamente. Voilà.
VIDEO Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana @UtetLibri
Perché l’Italia è tanto malmessa? Più di cinquant’anni fa la risposta Norberto Bobbio la offrì nel suo Profilo ideologico del Novecento italiano. Per molto tempo mi sono posto l’ambizioso compito di analizzare le idee che hanno circolato in Italia dopo il libro di Bobbio. Le mie risposte sono ora in Libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana (UTET 2021). La libertà di cui gli italiani hanno comunque goduto non ha fatto, proprio come temeva Bobbio, migliorare le idee e i comportamenti collettivi. È risultata complessivamente inutile. Il mio libro cerca di spiegare perché.
Libertà inutile
Profilo ideologico dell’Italia repubblicana
Quando scelse la repubblica, il popolo italiano, appena uscito dalle rovine di una dittatura e di una guerra mondiale, affidò all’Assemblea costituente l’impegnativo compito, condiviso da tutti (o quasi), di costruire un paese migliore. Ma la repubblica che ne è uscita è stata all’altezza di quelle speranze?
Se lo chiedeva già Norberto Bobbio nel suo fondamentale Profilo ideologico del Novecento italiano, fermandosi però sulle soglie del 1968, e se lo chiede oggi Gianfranco Pasquino, raccogliendo l’eredità del grande filosofo torinese e provando a impostare nuovamente una riflessione che riesca a cogliere l’accidentato percorso della nostra mutevole e inquieta storia repubblicana.
A partire dalle fondamenta costituzionali, Pasquino sismografa gli smottamenti culturali, gli umori e i contrasti che, di decennio in decennio, hanno attraversato la nazione e coinvolto i suoi protagonisti. Così ci immergiamo nelle contraddizioni delle tre grandi culture politiche del Novecento: il liberalismo, fondamentale durante la Resistenza e sminuito nella ricostruzione del dopoguerra; il comunismo, lacerato all’interno dal dibattito fra i desideri di riformismo parlamentare e le pulsioni semirivoluzionarie, negli anni caldi delle contestazioni di piazza; l’area democristiana, appesantita dal troppo potere politico, economico e sociale accumulato senza controlli, fino alla resa dei conti di Tangentopoli.
E poi ancora i mutamenti delle stagioni recenti: la personalizzazione della politica propiziata dal berlusconismo e l’affermarsi di nuove culture che strizzano l’occhio all’antipolitica e al populismo.
Il quadro che ne viene fuori è un’inedita biografia della nazione: un paese di passioni ideologiche ed enormi contraddizioni, in cui le fortune dei leader durano il tempo di una stagione. E allora, attraversando le riflessioni di Pareto, Calamandrei, Gramsci, Sartori, prende forma il dubbio di Pasquino: la democrazia italiana ha disatteso le promesse costituzionali? Quella conquistata con tanta fatica è stata forse una Libertà inutile?
Gianfranco Pasquino (Torino, 1942), allievo di Norberto Bobbio e di Giovanni Sartori, è professore emerito di Scienza politica all’Università di Bologna. Associate Fellow alla SAIS-Europe di Bologna, è stato direttore, dal 1980 al 1984, della rivista “il Mulino” e, dal 2000 al 2003, condirettore della “Rivista italiana di Scienza politica”. Dal 2010 al 2013 presidente della Società italiana di Scienza politica, è autore di numerosi volumi, i più recenti dei quali sono Cittadini senza scettro. Le riforme sbagliate (2015), Bobbio e Sartori. Capire e cambiare la politica (2019, tradotto in spagnolo nel 2020) e Italian Democracy. How It Works (2020). È particolarmente orgoglioso di avere condiretto insieme a Norberto Bobbio e Nicola Matteucci per Utet il celebre Dizionario di politica (2016, nuova edizione aggiornata). Per Utet ha inoltre pubblicato La Costituzione in trenta lezioni (2016), L’Europa in trenta lezioni (2017) e Minima politica (2020). Dal luglio 2005 è socio dell’Accademia dei Lincei.
Los populistas son más fuertes donde los partidos son débiles @eltiempo
El politólogo italiano Gianfranco Pasquino habló con EL TIEMPO sobre las democracias en la región
El profesor italiano Gianfranco Pasquino es uno de los máximos exponentes y autoridad de las ciencias políticas actualmente en el mundo. Fue presidente de la Asociación Italiana de Ciencia Política y es reconocido como uno de los más importantes pensadores europeos del último medio siglo.
Desde 1975 ha sido profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad de Bolonia (Italia), donde es el director del Máster en Relaciones Internacionales ‘Europa-América Latina’ de ese claustro. Ha sido profesor de Cambridge, de Oxford, de la Universidad de California y también en América Latina.
Pasquino fue el invitado principal a la Semana del Politólogo, organizada por la Universidad San Buenaventura, y habló con EL TIEMPO.
Dijo que la mayoría de las democracias en América Latina tienen problemas de funcionamiento. Habló del populismo y aseguró que la región produce caudillos, especialmente porque no hay partidos ni organizaciones políticas fuertes.
En el contexto regional, ¿usted cómo ve el panorama político?
No veo una diferencia sustancial entre gobiernos de izquierda y de derecha. Hago una diferencia entre gobiernos que saben cómo gobernar sus países y gobiernos que no saben cómo hacerlo. En el caso de Brasil, el presidente Bolsonaro no sabe gobernar, mientras que en el caso de Chile la derecha sabe cómo gobernar. En Venezuela, la situación pues no es democrática, mientras que en Bolivia hay una elección libre y la izquierda gana. En Argentina todos dicen que el problema son los peronistas, que son fuertes pero que raramente son capaces de gobernar de manera satisfactoria. Saben cómo ganar elecciones, pero no cómo gobernar.
Es decir, ¿en la región el problema no es de izquierda o de derecha, sino de malos gobiernos?
Exactamente.
Desde ese punto de vista, ¿cómo ve la región, avanzando o estancada?
Lo primero que hay que destacar es que la gran mayoría de los países latinoamericanos son democracias, y eso es muy importante porque si usted tiene una democracia puede cambiar, puede mejorar, puede sustituir a quienes no saben gobernar. Después, el problema es cómo funcionan las democracias. Yo creo que la mayoría de las democracias en América Latina tienen problemas de funcionamiento. Algunos de los problemas son de reglas, también hay problemas de comportamiento de los que tienen el poder, de los que mandan. En algunos casos podemos cambiar a los que mandan, pero si no cambiamos las reglas no tendremos una democracia que funcione bien.
Menciona problemas de funcionamiento. ¿Qué sería necesario cambiar?
En algunos casos, los problemas son los poderes de los presidentes. Y los presidentes que tienen mucho poder raramente pueden ser responsables de lo que hacen, de lo que no hacen, de lo que hacen mal. Entonces debemos redefinir los poderes de los presidentes de la república. En algunos casos, los problemas son las asambleas legislativas, que no tienen el suficiente poder para controlar al presidente y no tienen bastante poder para representar de manera eficaz a los ciudadanos. Los sistemas electorales deben ser reformados en algunos casos. La manera de elección de los representantes debe ser modificada.
¿En la región hay presidentes que tienen demasiado poder?
En algunos casos, sí.
¿Dónde?
Por ejemplo, en Brasil el presidente tiene demasiado poder, y de eso no tengo ninguna duda. En Chile, el poder del presidente es bastante importante. En algunos casos, los presidentes utilizan un exceso de poder político, lo que produce consecuencias negativas.
¿En el caso de Colombia qué ha visto?
No conozco muy bien la situación colombiana, pero me parece que, en general, las elecciones son libres y los presidentes ganan el poder a través de reglas democráticas.
Sabemos que hay un problema de violencia, y está el narcotráfico, pero ese no es un inconveniente institucional, es un problema socioeconómico que incluso puede ser un problema cultural, que es muy difícil de resolver.
¿Se debe avanzar, sobre todo, en el plano social?
Exactamente.
Por acá se habla mucho de caudillismo, ¿ve mucho caudillo en esta parte del continente?
La región tiene una situación favorable a los caudillos porque no hay muchas organizaciones políticas fuertes, sólidas. Los partidos son organizaciones débiles. En Brasil, por ejemplo, los partidos son organizaciones muy débiles; en Argentina, la izquierda ha sido muy débil, el partido radical es un partido pequeño, el partido de la tradición argentina es un partido pequeño, y los peronistas no son un partido. Entonces, los movimientos son importantes, pero no tienen reglas y no tienen democracia en su interior, y los partidos son débiles y en algunas ocasiones son organizaciones personalistas, es decir, el líder del partido crea el partido, el cual dura hasta cuando el líder está bastante fuerte.
Es decir, ¿los partidos deben dejar de ser caudillistas?
Deben fortalecerse como organización. No sé si pueden dejar de ser caudillistas, porque los caudillos nacen dentro de los partidos en algunos casos y en otros casos son los caudillos quienes obtienen el poder de conquistar los partidos. El problema está en los partidos y en algunos de sus dirigentes, que deben resistir contra los caudillos actuales y potenciales.
¿En el caso de Nicolás Maduro estamos hablando de un dictador o de un caudillo?
El problema de los dos partidos más importantes de Venezuela fue que no supieron fortalecerse, no construyeron relaciones con el pueblo, con los electores, con los ciudadanos. El Copei y Acción Democrática abrieron el espacio político para Chávez, y él fue un verdadero caudillo, un líder populista con muchas capacidades que intentó crear un nuevo sistema político.
Pero los populistas raramente saben cómo institucionalizar su fuerza, su poder. Entonces, la situación venezolana es una situación no democrática, podemos decir que es arbitraria también y Maduro utiliza reglas autoritarias. Pero no hay una situación consolidada. Entonces, si los dos grupos no logran una solución compartida es difícil construir algo sólido y duradero en Venezuela.
¿La salida de la crisis venezolana debe tener en cuenta al chavismo?
La salida es como construir reglas e instituciones que sean compartidas entre los opositores y los que apoyan a Maduro. Es claro que Maduro no puede seguir en el poder y debe haber reglas de cogobierno que sirvan para un año de transición y después, elecciones libres. Pero deben existir partidos organizados para producir consecuencias positivas.
Usted menciona el populismo, ¿lo ve aumentando en la región?
Los populistas necesitan que no existan organizaciones fuertes, porque si existen partidos fuertes, porque si existen asociaciones fuertes, los populistas no pueden ganar el poder. Pueden obtener votos, y en Europa hay movimientos y partidos populistas. Los populistas existen porque si evaluamos la democracia como el poder del pueblo, hay populistas, los que dicen que representan el pueblo. Los populistas son más fuertes donde no hay organizaciones fuertes. Entonces, en los países latinoamericanos cuando no hay partidos fuertes, hay líderes populistas. Los partidos chilenos son bastante fuertes, entonces vemos poquísimo populismo. Los partidos en Brasil no son bastante fuertes, entonces Bolsonaro es un líder populista.
¿Cree que las necesidades generadas por el covid-19 les pueden abrir las puertas a los populistas?
Los populistas pueden disfrutar la pandemia de una cierta manera, pero los populistas no tienen soluciones para la pandemia, porque la pandemia necesita soluciones compartidas entre hombres, mujeres y el Estado. Son quienes tienen el poder, especialmente el económico, quienes pueden resolver, quienes pueden enfrentar la pandemia. Los populistas pueden criticar, pueden explicar que saben cómo hacerlo, pero cuando tienen el poder político no saben cómo resolver la pandemia, cómo resolver los problemas del pueblo porque necesitan soluciones compartidas con otros Estados, no contra los otros Estados, sino con otros Estados. No hay una solución nacional para la pandemia.
En Colombia se habla mucho de la polarización, ¿este es un fenómeno local o de toda la región?
La polarización es siempre un problema y nunca una solución. Es necesario que los moderados de izquierda intenten buscar una solución con los moderados de derecha, ese es normalmente el camino para una solución democrática, cuando hay la convergencia entre los moderados. Pero no conozco lo suficiente de la situación colombiana. Pero, en general, podemos decir que hay moderados en todas las democracias, que son los que intentan producir soluciones, controlan la polarización de izquierda y la polarización de derecha.
¿La elección en EE. UU. de Joe Biden implica algún cambio para la región?
En general, puedo decir que Latinoamérica hoy no es muy importante para Estados Unidos. La competencia con China, y de una cierta manera con Rusia, es mucho más importante. Entonces, si los latinoamericanos no crean problemas particularmente delicados, Estados Unidos y Biden no estarán interesados sobre lo que ocurra en Latinoamérica.
¿Podríamos decir que Latinoamérica se mueve entre el caudillismo, el populismo y los malos gobiernos?
No, no podemos, porque América Latina tiene países que son democráticos. Existen caudillos, existe el populismo; en algunos países los populistas parecen ser bastante fuertes, pero el elemento común a todos los países de Latinoamérica es la democracia, y debo decir que hay democracias que funcionan bastante bien y democracias que no funcionan, pero sabemos por los sondeos de opinión que la mayoría de los latinoamericanos prefieren las democracias a los populistas.
¿Qué opinión le merece lo que pasó en Perú, que en menos de dos semanas tuvo tres presidentes?
Perú tiene muchísimos problemas. Los partidos son débiles y la corrupción es muy alta. La inestabilidad política en este país es un fenómeno permanente. No veo ninguna solución. Puede ser que un gobierno de solidaridad nacional produzca algo positivo, pero es difícil convencer a las élites políticas, económicas y culturales de construir y apoyar un gobierno de solidaridad durante un plazo de tiempo bastante largo, cinco o seis años.
¿Esto que pasó en Perú es el reflejo de una democracia débil?
Freedom House, reconocida ONG a nivel mundial, considera a Perú un país “libre” y bastante democrático, pero la calidad de su democracia es débil. No veo una solución en el corto plazo, ahora se deben fortalecer los partidos y compartir el poder. Como país, deben organizarse y luchar. La nación inca debe seguir luchando por defender y fortalecer su democracia.
25 de noviembre 2020 El TIEMPO